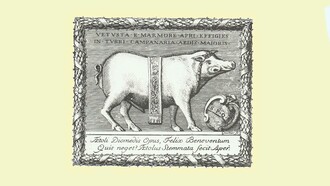Paola Cavanna è poetessa, dialettologa, attrice, fine dicitrice, cantante, ma è soprattutto una persona speciale. Le chiedo di presentarsi, di raccontare la sua storia.
Sono nata nel 1951, da una famiglia modesta, il papà operaio all’Autobianchi di Desio, la mamma, come si diceva allora, casalinga. Figlia del dopoguerra, protetta da ogni evento che non riportasse a ordine e rigore, a me il dialetto era negato (ancora sull’eco della proibizione fascista che riportava tutto all’italico idioma). Tra loro i miei in casa parlavano dialetto, ma il vero baluardo delle “lingua madre” erano i miei nonni paterni, che non sapevano parlare un italiano corretto.
Ah benedetti nonni, portatori fedeli di una lingua che si fa storia di una gente...
La raccomandazione di mia madre ai nonni era: “Alla bambina parlate in italiano, perché poi farà fatica a scuola”.
E quindi, casa succedeva nel vostro parlarvi?
Da lì le più divertenti conversazioni della mia infanzia: “Pavoletta, pizza il chiaro” –pizza el ciar = accendi la luce. La mia nonna Genoveffa era uno spettacolo di espedienti: “Vai a prendermi le orgnette sul ciffone” Vá a toeumm i orgnett sul ciffon = vai a prendermi gli occhiali sul comò.
Davvero commovente lo sforzo della nonna di tradurre in italiano per te, commovente ed esilarante.
Fu così che io imparai solo con l’ascolto attento, una lingua disobbediente, negata, piena di mistero.
Paola, mi piace tantissimo questa visione del dialetto milanese come una lingua disobbediente e piena di mistero. Mi piace perché rende benissimo gli accadimenti psichici in una mente stupefatta infantile e attiva in me tenerezza e curiosità, di quale mistero sarà portatore il dialetto? E nel frattempo mi rimanda alla mia infanzia, alle storie raccontate dalla nonna paterna mentre lavorava all’arcolaio e io, a bocca aperta, seduta su un seggiolino ai suoi piedi, incalzavo continuamente con un “…e allora?” ero smaniosa di sapere e adesso “e allora…” lo chiedo te.
Col vezzo tipico dei milanesi, sovente qualche vecchia signora mi approciava in dialetto, subito traducendolo con colpevole sollecitudine: “T’hoo dii de corr nò! - Ti ho detto di non correre! – e altre amenità del genere, che oltre a divertirmi, mi facevano amare questa lingua sonora, a volte aspra, a volte così dolce.
Oltre ai nonni, dove lo incontravi il dialetto?
Nel cortile spesso si sentivano gli ambulanti che chiamavano a raccolta le donne (obrellee, moletta, strascee = ombrellaio, affilatore, straccivendolo), le piccole baruffe tra comari, da lontano il litigio di una coppia, la portinaia che rincorreva i monelli che giocavano a palla. Tutto in milanese.
Io capivo tutto, ma non osavo parlarlo.
E certo, lingua proibita. E la poesia come fa capolino?
Sin da piccola ero affascinata dalle poesie e ricordo di aver scritto la prima a nove anni, quando la mia amata nonna Genoveffa era mancata. Questo in italiano. In età adulta, già sposata e madre, il desiderio di qualcosa di mio, di esclusivo, di rappresentativo, mi è arrivato con un articolo di un concorso per solo poetesse milanesi: il premio Anna Carena (attrice di teatro milanese).
E come hai fatto? Scrivere in dialetto è un’impresa.
Avevo già provato a cimentarmi col dialetto e ho sentito che quella era la svolta giusta. Acquisto un vocabolario e scrivo le mie prime righe nella mia lingua del cuore.
E poi è come andata?
Con la fortuna dei neofiti, vengo segnalata al Concorso in mezzo ad altre poetesse di grande livello: Piera Bottini, Ada Lauzi, Caterina Sangalli. In giuria l’attrice Franca Brambilla mi prende da parte e brusca e materna mi dice: “Se scriv nò insci! Vá a scòla!” “Non si scrive così! Vai a scuola!” (anche lei con la solita modalità: ti dico e ti traduco!).
E allora come hai rimediato al tuo non sapere?
È così che scopro la scuola del Circolo Filologico Milanese che frequento per anni sotto la guida cordiale di Cesare Comoletti (grammatica, lettura e scrittura) e quella rigida e austera di Claudio Beretta (letteratura, metrica poetica). Passano anni, divento Socia del Circolo e anche un anno emozionante Presidente della Sezione di Milanese (la prima presidente donna).
Grande scalata …
Ma li lascio per andare ad insegnare per un ventennio in una biblioteca della zona sud di Milano, la biblioteca Fra’ Cristoforo, in Barona.
E cosa insegni?
Insegno soprattutto grammatica milanese, intanto che con uno straordinario attore, Antonio Bozzetti, comincio a portare per le varie biblioteche e in provincia uno spettacolo di poesie e canzoni. Antonio recita, io canto.
Che coppia…
Mi richiama il Circolo Filologico e mi offre di insegnare in un corso di lingua milanese, insieme al poeta Edoardo Bossi. Edoardo insegna grammatica e io finalmente apro la mia “Bottega de Poesia”, in una classe numerosa e attenta.
Che soddisfazione…
Nel 2018 lascio, sbattendo la porta, il Filologico e apro il mio “Atelié milanes” nel prestigioso Atelier del maestro Aldo Parmigiani, che ospita la mia classe di ottimi allievi e poeti spesso premiati in vari concorsi, che riapre per la settima edizione, martedì 30 settembre alle ore 18 fino alle 19,30 e sarà attivo fino a fine maggio 2026.
Perciò la poesia entra a grandi passi…
Oltre al mio libro ultimo nato Nemis (Nemici), piccola antologia di uomini famosi, con un'anima nera, ho al mio attivo due antologie su donne più e meno celebri: Dòna de cent color e Stria in ciel, un libro a quattro mani con la poetessa Enrica Cortellezzi Parmigiani El Diavol e l’Acquasanta (dove io non sono l’acquasanta), tre quaderni di filastrocche per l’infanzia: I filastròcch de Nòna Gatta, L’abecedari de la cassina e l’Abecee de l’arca de Noè. Di prossima pubblicazione il quarto L’Olimpo de Nòna Gatta.
Parlami dei quaderni di filastrocche.
In realtà il primo quaderno era nato perché per quindici anni sono stata nelle scuole elementari di Milano Sud per incontrare i bambini e portare loro le filastrocche, le conte, le canzoncine milanese, con inaspettato successo.
La bambina che non poteva imparare a parlare il dialetto in realtà è diventata una nobile portavoce e sostenitrice della lingua “milanesa”.
Nel 2024 ricevo il “Panettone d’Oro alla benemeranza civica” per il mio lavoro sul dialetto della Città.
Mamma mia che carriera incredibile e che riconoscimento da parte della tua città.
Quest’anno sono stata eletta Vice Presidente dell’Accademia del dialetto Milanese (Presidente Gianfranco Gandini) e mi occupo della selezione delle poesie da pubblicare sul giornale dell’Accademia “El Sciroeu de Milan”). Collaboro anche con alcune case Editrici e al Calendario dei Martinitt.
E poi?
E poi? Poi scrivo, scrivo, scrivo. Poesie, Spillett (Siparietti), recito e canto dove mi chiamano, felice di far sentire la mia lingua dai suoni vari e variabili, misteriosi e affascinanti.
Si percepisce un grande amore per la tua lingua.
La mia lingua è la mia anima, anche se a volte, qualcosa arriva in italiano, ma devo dire, sempre meno.
Qual è la musica che senti quando parli o ascolti il dialetto?
È il ritmo del mio cuore, il battito, cadenzato come le parole antiche. Il mio dialetto, gagliardo e ironico, pieno di frasi idiomatiche, di modi di dire, di doppi sensi anche un po’ screanzati, con alcune sonorità grevi e altre leggiadre.
Ce la fai sentire e gustare questa amata lingua? Ma avevi parlato anche di lingua disobbediente, perché?
Dicevo, lingua di disubbidienza: mi spiego. Quando Milano era invasa da spagnoli, austriaci, francesi, a seconda del periodo storico, il potere invasore capiva e parlava l’italiano, ma non il dialetto. Questo era la lingua franca per comunicare tra gli oppressi, per sfuggire a nuove ingrate regole.
Commovente questa funzione rivoluzionaria del dialetto.
Ecco, forse per me è proprio questo, una lingua libera, lontana dalla globalizzazione, dalle inique consuetudini, da lingue che non hanno le nostre medesime ridici. Un pensiero in fuga, liberatorio, travolgente.
Il dialetto è il parlare della gente. Ha qualche riverbero allora nel sociale?
Il mio dialetto è anche una lingua di solidarietà: per dieci anni ho affiancato Edoardo Fiorini nel suo Progetto “Palinuro” dell’Istituto dei Tumori, per la produzione di CD, traducendo testi internazionali in milanese e partecipando come interprete in molti spettacoli per la raccolta di fondi.
Grazie Paola anche per questa iniziativa generosa che testimonia la nostra cara “Milan col coeur in man”. Lingua della solidarietà, della libertà, della spontaneità, della creatività. E a proposito della creatività ti chiedo di regalarci una filastrocca dai tuoi quaderni come saluto in diretta dopo questa bella chiacchierata.
Eccola. È una filastrocca tratta dal quaderno I filastròcch de Nòna Gatta.
Ballottin: el gatt grass
Quand che l’era piscinin
el ciameven Ballottin
El destin ghe l’hann segnaa
cont el nòmm che gh’hann cattaa
Dess l’è grass come on porscell
fa stremizzi al soll vedell
Ballotton se pò ciamall
vist ch’el pesa mezz quintall!
Par ‘na balla de mòchett:
ghe se stòrten i gambett
sòtt el pes del sò culon
el par quasi in genoggion
De saltà ‘l ghe pensa nò
l’è pientaa come on comò
Mai ona corsa: senza fiaa
el se stracca al soll a pensà
'l va a dormì sù l’ottomana
granda assee per fagh la nanna
Se disseda vers mezz dì
el s’ingòzza e ‘l va a dormì
El spazzetta el sò mangià
col coo bass, senza fiadà
La soa tazza l’è on cadin
-Mangia, mangia, Ballottin!-
la ghe dis la soa padròna
che l’è òrba, ma l’è bòna
Poeu le ciappa tra i sò brasc
e la borla giò ‘me ‘n strasc!
Grazie Paola!!!
“Te saludi bella tosa”