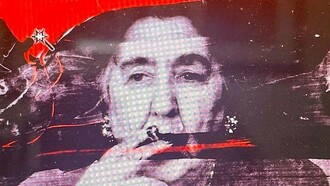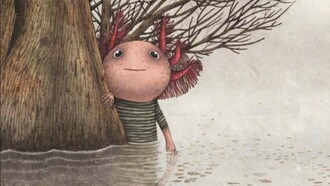Preso il potere, quale sarebbe la prima cosa che fareste? Oltre a liberarvi, fisicamente e non, di eventuali avversari, s’intende.
Ottaviano aveva le idee ben chiare alla fine della guerra civile che lo aveva visto contrapposto a Marco Antonio e Cleopatra: tenere il potere stretto e non fare la fine del suo prozio, assassinato quando credeva di avere le spalle coperte.
Ottaviano per il resto della sua vita fu sempre molto cauto a come si presentava al pubblico, consapevole che l’opinione del popolo contava, e in questo la propaganda lo aiutava: Ottaviano si presentava come il restauratore dei mores romani, difensore della Repubblica e primus inter pares, anche se, a conti fatti, il potere lo esercitava solo lui.
In questo contesto, si rivelò di importanza fondamentale il circolo di Mecenate, amico di Ottaviano e terzo uomo più potente dell’Impero, dopo lo stesso Ottaviano e Agrippa. Il circolo era composto da artisti e letterati, tra cui spiccavano Orazio e Virgilio. A loro venne affidato il compito di elogiare il regime augusteo attraverso la cultura, in modo che ai Romani risultasse meno indigesto il governo, in pratica, di un uomo solo.
Il ruolo maggiore lo ebbe Publio Virgilio Marone, che oltre che autore delle Bucoliche e le Georgiche, fu colui che rifondò il genere epico a Roma con la sua Eneide. Nelle Bucoliche sono trasfigurati in linguaggio poetico i precetti di vita propri della filosofia epicurea ("vivi appartato", "vivi in segreto"), che spinsero il poeta a evadere dalla realtà dolorosa della vita sociale in un mondo individualistico, privo di bisogni e ambizioni, quale appunto quello dei suoi pastori.
Abbiamo un primo superamento dell’epicureismo virgiliano ne Le Georgiche. L'epicureismo è superato in una nuova e più complessa sensibilità che nasce dalla comprensione per l'uomo, le sue passioni, e i suoi doveri: è una sensibilità più umile nel rispetto delle tradizioni che sostengono le fatiche dei campi, e insieme più superba, perché quelle fatiche assumono il carattere di un epos, l'oscuro epos del tenace contadino.
L’Eneide è però il vero capolavoro di Virgilio. Prima di lui, c’era stato Quinto Ennio con i suoi Annales, di cui sono sopravvissuti pochi frammenti, ma che per il linguaggio astruso e la lunghezza, era considerato obsoleto già all’epoca. L’Eneide doveva rispondere a un doppio bisogno: da un lato, esaltare la gens Iulia, dall’altro fornire un poema nazionale al pari dell’Iliade e dell’Odissea per i greci.
Il libro che maggiormente servì alla propaganda augustea, fu il libro VI. Il Libro Vi dell’Eneide, data la sua posizione centrale, fa da cerniera tra i due nuclei tematici del poema: il viaggio alla ricerca di una nuova patria (e da cui Virgilio trae come modello l’Odissea di Omero) e la guerra contro Turno e i Rutoli. Il VI libro è incentrato sul viaggio che Enea compie nel Regno di Plutone. Giunto a Cuma, presso Napoli, l’eroe fa visita alla Sibilla, la celebre profetessa che gli rivela le difficili prove del futuro e gli mostra la via per l’oltretomba.
Qui Enea si reca per incontrare il padre: si imbatte prima in Palinuro (che invoca la sepoltura), Didone, che di fronte a lui ostenta un muto disprezzo, e gli eroi della guerra di Troia. Anchise, infine, gli illustra la teoria della reincarnazione e gli presenta i grandi uomini del futuro di Alba e di Roma, molti dei quali legati alla gens Iulia.
Interessante è notare l’emergere, nella descrizione di Anchise sulla rinascita delle anime, la concezione orfico-pitagorica dell’anima e dell’aldilà. Utilizzando un termine improprio, si può dire che qui Virgilio canonizza il passaggio dalla filosofia Epicurea (sicuramente presente in alcune egloghe delle Bucoliche) a quella, più misterica e spirituale, pitagorica.