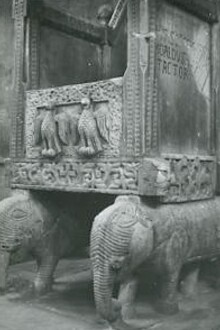Nel 1130, l’arcivescovo di Bari, Angelo, ricevette una bolla pontificia da Anacleto II, con la quale gli venivano conferiti a vita la chiesa di San Sabino in Canosa e il monastero di Ognissanti nei pressi di Bari. Il documento affidava inoltre ad Angelo il compito solenne di consacrare Grimoaldo Alferanite come Principe di Bari, confermando i privilegi già accordati alla Chiesa barese dai predecessori dell’antipapa.
Un elemento notevole è la data topica della pergamena che riporta “Bari”. I documenti papali, infatti, sono solitamente redatti e datati a Roma o in Laterano. Tale anomalia suggerisce non solo una presenza fisica di Anacleto in Puglia, ma anche una strategia politica volta a rafforzare il suo potere nei territori meridionali durante lo scisma che lacerava la Chiesa.
Oltre alla data topica un altro elemento interessante è dato dagli elementi estrinseci del documento – la formulazione, le formule tipiche, la struttura e la tipologia di scrittura – che ricalcano quelli propri della cancelleria pontificia, il che lascia supporre che, nonostante lo scisma e il contesto periferico, si cercasse di mantenere una forma documentaria canonica e autorevole. Ci si potrebbe dunque domandare se esistesse, almeno in forma temporanea o straordinaria, una vera e propria cancelleria papale itinerante, in grado di accompagnare il pontefice nelle sue peregrinazioni e di garantire la continuità e la legittimità dell’azione amministrativa anche lontano da Roma.
Alla morte di papa Onorio II, nel febbraio del 1130, la Chiesa si trovava in una condizione di profonda instabilità istituzionale e politica. Il suo pontificato, pur contraddistinto da una certa fermezza nella gestione dei rapporti con il nascente potere normanno nel Mezzogiorno e da un tentativo di equilibrio tra l’Impero e le grandi famiglie romane, non era riuscito a sanare le tensioni all’interno del collegio cardinalizio né a definire un chiaro e condiviso meccanismo di successione papale. L’assenza di una procedura elettiva unitaria aprì la strada a giochi di potere tra le fazioni aristocratiche, le quali finirono per monopolizzare il conclave e spaccarlo in due schieramenti contrapposti.
Questo vuoto di autorità, lasciato da un pontificato più amministrativo che carismatico, preparò il terreno allo scisma che si sarebbe consumato immediatamente dopo la sua scomparsa, evidenziando la fragilità dell’unità ecclesiale in un’epoca in cui la dimensione politica del papato prevaleva su quella spirituale.
Fu così che, nel medesimo febbraio del 1130, il collegio cardinalizio si spaccò: una minoranza elesse Gregorio Papareschi, che assunse il nome di Innocenzo II, mentre la maggioranza – sostenuta da potenti famiglie romane come i Pierleoni – proclamò papa Pietro Pierleoni, che prese il nome di Anacleto II. Da questa doppia elezione nacque uno degli scismi più gravi del XII secolo.
Questa frattura non fu solo religiosa, ma soprattutto politica. Innocenzo II fu riconosciuto dal Sacro Romano Impero, dalle monarchie di Francia e Inghilterra, e dall’Europa settentrionale. Il suo principale sostenitore fu Bernardo di Chiaravalle, che ne promosse l'autorità presso le corti europee e l’imperatore Lotario II. Anacleto II, al contrario, cercò appoggio nell’Italia meridionale e nel Regno di Sicilia, dove i Normanni vedevano in lui un alleato utile per affermare la propria influenza sugli affari ecclesiastici.
In tale contesto, la Puglia – e in particolare Bari – assume un ruolo strategico. La città, sede arcivescovile e nodo politico normanno, offriva ad Anacleto un'importante base di legittimazione. La bolla a favore dell’arcivescovo Angelo va dunque letta come strumento per consolidare alleanze locali e affermare un modello alternativo di autorità pontificia, in contrapposizione alla centralità romana incarnata da Innocenzo II.
Il contrasto tra i due papi rifletteva, infatti, una più ampia dialettica tra il Nord e il Sud dell’Europa cristiana, tra il potere imperiale e quello normanno, tra una visione universalista della Chiesa e un uso più politico e territoriale del potere ecclesiastico.
Nonostante l’iniziale isolamento, Innocenzo II riuscì gradualmente ad affermarsi, anche grazie alla continuità con l’eredità della riforma gregoriana, riaffermando il primato romano e promuovendo un forte impulso alle riforme ecclesiastiche. Alla morte di Anacleto II nel 1138, lo scisma si concluse ufficialmente con il Concilio Lateranense II del 1139, che condannò i sostenitori dell’antipapa e confermò definitivamente Innocenzo II come unico pontefice legittimo.
La bolla di Anacleto II è quindi molto più di un semplice documento amministrativo: essa testimonia una frattura profonda che coinvolse non solo le alte gerarchie ecclesiastiche, ma anche i poteri locali, i territori e le alleanze dinastiche. La sua datazione a “Bari” evidenzia il tentativo di Anacleto di radicare il proprio potere nel Sud, utilizzando la concessione di benefici e l’assegnazione di funzioni religiose e politiche come strumenti di legittimazione.
In sintesi, il documento barese del 1130 rappresenta un esempio concreto di come lo scisma papale non fu soltanto una lotta tra due figure religiose, ma il riflesso di un conflitto geopolitico più ampio, che toccava l’equilibrio dei poteri in Europa e i rapporti tra autorità spirituale e potere temporale.