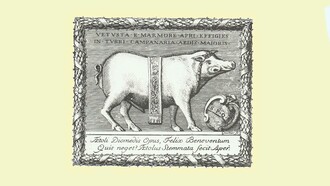Come il battito d’ali di una farfalla a Pechino possa provocare una tempesta a New York.
Giugno 1816, Villa Diodati, lago di Ginevra, Svizzera.
Un gruppo di eleganti ed infreddoliti ospiti vi si è rifugiato a causa del protrarsi di un insolito maltempo con piogge incessanti e temperature estremamente rigide per il periodo.
L’anfitrione è una celebrità: lord George Gordon Byron, VI barone di Byron, nobile, poeta e libertino, caduto in disgrazia e fuggito dall’Inghilterra, dove l’aria si è fatta per lui irrespirabile.
Soprattutto il suo ambiente aristocratico, infatti, sempre più intriso di un’emergente mentalità evangelica e pietista, intollerante e bigotta, che porrà i presupposti per quell’età vittoriana che permeerà la cultura inglese nei decenni futuri, detesta la vita sregolata e licenziosa del poeta, costringendolo infine ad un volontario esilio che durerà per il resto della sua vita perché Byron non tornerà mai più in Inghilterra.
Durante il suo lussuoso peregrinare, trovandosi in Svizzera nel giugno di quell’anno, ha dunque affittato un luogo che si confaceva al suo stile di vita opulento e decadente, Villa Diodati appunto, dove aveva soggiornato anche Milton, e ospita un gruppo di amici: la giovane Mary Wollstonecraft Godwin, allora diciannovenne, il futuro marito di Mary, Percy Bysshe Shelley, la sorellastra di Mary, Claire Clairmont amante di Byron e il dr John William Polidori, medico personale del padrone di casa e a sua volta scrittore e poeta.
Come abbiamo accennato, il celebre gruppo si era rifugiato a Villa Diodati per le tempeste che flagellavano il paese e, rinchiusi là dentro, si era messo a leggere antologie di racconti del gotico e del fantastico, temi tanto di moda in quel periodo. Un po' per gioco e forse anche per noia Byron propose allora agli amici, tutti colti ed amanti delle lettere, di inventare un racconto dell’orrore, una gotica sfida letteraria da svolgersi mentre erano reclusi in attesa che il sole tornasse a scaldare la terra.
La diciannovenne Mary, futura signora Shelley, non riusciva però a trovare l’ispirazione. Lei stessa, anni dopo, scrisse di quei giorni che precedettero la creazione di quel romanzo che la rese immortale: "Nell’estate del 2016 visitammo la Svizzera e diventammo vicini di Lord Byron. Ma quella si rivelò un’estate umida e inclemente, e una pioggia che non finiva mai ci confinava spesso in casa per giorni". Una notte da tregenda, l’ennesima lacerata dal brontolio del tuono e squarciata dai fulmini, sognò di uno scienziato che riusciva a rianimare un cadavere mediante scariche elettriche divenendo il creatore di un terribile mostro. Al mattino annunciò agli amici di aver finalmente trovato l’ispirazione per il suo racconto e così, tra fulmini e tempeste, era nato il mito di Frankenstein.
Quello però che né Mary Shelley né i suoi amici potevano sapere era che quell’anno, il 1816, passerà alla storia come l’anno senza estate e che il maltempo eccezionale che li teneva prigionieri in quella villa sul lago di Ginevra stava in realtà flagellando da mesi tutto l’emisfero boreale, causando carestie e catastrofi che si protrarranno per il resto dell’anno. Soprattutto in Nordamerica si verificarono copiose nevicate fuori stagione: a giugno si verificarono bufere di neve nel New England e nel Canada orientale con numerose vittime, a luglio e ad agosto ghiacciarono laghi e fiumi in Pennsylvania e almeno tre gelate colpirono il New England distruggendo i raccolti.
Anche in Europa le cose non andavano meglio. Le nevicate e le gelate tardive distrussero i raccolti facendo schizzare alle stelle il costo della farina e degli ortaggi, e dando il via a saccheggi e rivolte da parte di una popolazione che stava risollevandosi a fatica dalle distruzioni delle guerre napoleoniche. In Italia si verificarono precipitazioni di neve rossastra ed incredibili, fantastici tramonti ed albe psichedeliche infiammarono i cieli d’Europa come testimoniano gli inquietanti paesaggi marini di Turner.
Ma cosa poteva avere innescato una simile serie di eventi climatici così estremi in un lasso di tempo così ridotto? Si dice che il battito d’ali di una farfalla in Asia possa scatenare una tempesta in America, e pur sembrando paradossale, è invece proprio ciò che avvenne, anche se l’esplosione del vulcano Tambora, nell’isola indonesiana di Sumbawa, non fu propriamente un battito d’ali di farfalla.
Infatti, nell’aprile dell'anno precedente, il 1815, l’anno di Waterloo e del Congresso di Vienna, il monte Tambora, uno stratovulcano fino allora dormiente, esplose causando il più grande evento eruttivo che la storia umana abbia registrato. Fino ad allora era stata una magnifica montagna che si innalzava dalle cangianti acque del mare di Flores per 4300 metri, i fianchi rigogliosi ricoperti d’antica jungla primordiale ipertrofica per via del terreno vulcanico ricco di nutrienti e delle copiose piogge monsoniche. Era nota fin dai tempi antichi con il nome di Aram, la più alta montagna insulare del pianeta e la quindicesima per altezza in assoluto ed era un importante punto di riferimento per chi navigasse in quelle acque.
È considerato uno dei più pericolosi vulcani esistenti e si trova esattamente lungo la cintura di fuoco nella zona di subduzione innescata dal movimento della placca australiana che scorre sotto quella della sonda, dando origine ad una delle zone più instabili della Terra, come hanno tragicamente dimostrato le devastanti eruzioni dei vulcani Toba, Krakatoa, Samalas-Rinjani e il Tambora stesso.
Nell’aprile del 1815, dopo tre anni in cui si erano verificati molteplici segnali premonitori come scosse telluriche, esplosioni ed emissioni di cenere e fumo dalla sommità, il Tambora diede inizio ad una delle poche eruzioni VEI (Volcanic Explosivity Index) di grado 7 su 8, che la memoria storica abbia registrato. Il 10 aprile ebbe inizio la fase culminante dell’eruzione con il collasso del cono sommitale e le successive esplosioni parossistiche. Si udirono mostruosi boati, i più forti che mai si siano generati in epoca storica e che vennero uditi distintamente fino a 3350 km di distanza a Nong Khai in Thailandia e a Vientiane in Laos.
Piogge di pomice rovente e flussi piroclastici seguiti da uragani, causati dai violenti spostamenti d’aria fredda che riempivano lo spazio lasciato libero dall’enorme bolla d’aria calda che saliva verso la stratosfera, sradicarono e bruciarono ogni cosa. I regni di Tambora, Pekat e Sanggar, che si trovavano alle pendici del vulcano, vennero cancellati dalla faccia della Terra e con essi, si stima, dalle 10 alle 12.000 vittime dirette dell’eruzione a cui si sommano, nell’intera Indonesia, almeno altre 100.000 per gli effetti indiretti dell’evento.
L’esplosione del Tambora scagliò nell’atmosfera più di 100 km cubi di roccia e polveri, oltre a 400 milioni di tonnellate di gas serra creando per alcuni anni uno schermo al calore solare che, soprattutto nel 1816, generò gli eventi climatici estremi che abbiamo descritto e che causarono, come scrisse lo storico John D. Post :"l’ultima grande crisi di sopravvivenza del mondo Occidentale".
Il totale dei morti a causa degli sconvolgimenti climatici che misero in ginocchio l’emisfero boreale si stima ammontino a più di 200.000 e il maestoso cono vulcanico del Tambora era stato mutilato tanto che dai 4.300 metri di altezza originari si era ridotto agli attuali 2.850 metri.
Un battito d’ali piuttosto fragoroso dunque, anche se insignificante in rapporto ad altre convulsioni che hanno squassato la Terra negli eoni passati solo che questa volta, tra quel battito d’ali e la tempesta, c’eravamo noi uomini a testimoniare, noi, che a differenza degli innumerevoli esseri viventi spazzati via da quei passati cataclismi, sentiamo tutto ma come ogni altra vita siamo poco più di niente.