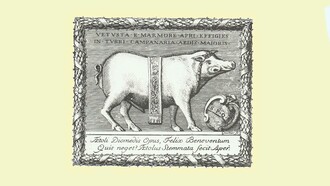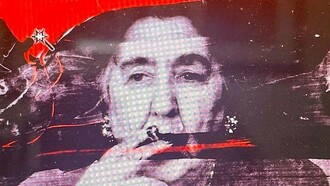Quando Epimenide di Creta nel VI secolo a. C. disse “I cretesi sono mentitori” non immaginava di dare avvio a un dibattito che avrebbe impegnato fior fiore di intellettuali nei secoli a venire. L’affermazione appare perfettamente legittima a un comune ascoltatore, che interpreta la frase come:
Nella generalità dei casi i cretesi sono bugiardi, ma non in questo caso, perché io, anche se sono cretese, ora sto dicendo il vero.
Ma i logici e i filosofi, usi a spaccare il capello in quattro, sostengono che Epimenide intendeva affermare “Tutti i cretesi, me compreso, dicono il falso”. I logici, dopo un ampio dibattere, hanno convenuto che la frase deve essere considerata falsa. Infatti, si danno due casi. Se la frase è vera, Epimenide è un bugiardo e dunque è falsa. Se la frase è falsa, non tutti i cretesi mentono, ma allora Epimenide ha mentito. In entrambi i casi, la frase è falsa. Si tratta di un’autocontraddizione, ma non di un vero paradosso, cioè un’affermazione che è allo stesso tempo vera e falsa.
Al contrario, la frase ‘Io mento’ è un paradosso, perché il parlante si riferisce a un fatto reale (il fatto di mentire), ma lo fa con una frase (che è un fatto) che nelle sue intenzioni va considerata una non-menzogna. Dunque, siamo di fronte a un fatto e alla sua negazione. La proposizione è allo stesso tempo vera e falsa. È questo un autentico paradosso. Confesso che ho dovuto pensare a lungo per afferrare la differenza tra questa formulazione e quella precedente. E talvolta mi sono perso. Alla fine, per convincermi, mi sono chiesto: potrebbe un giudice rigoroso accusare di menzogna un imputato che dichiara di mentire? Invito il lettore a tentare una risposta. Se non vuole arrovellarsi può fare un atto di fede oppure leggere il libro di P. Odifreddi, C’era una volta un paradosso. Storie di illusioni e verità rovesciate, Einaudi, 2001.
La versione del paradosso che più mi piace è quando esso viene scomposto in due proposizioni, del tipo:
La frase seguente è falsa.
La frase precedente è vera.
La sensazione è quella di un circuito che intrappola il lettore: la prima frase rimanda alla seconda, che rimanda alla prima, senza mai atterrare su un terreno solido, dove puoi distinguere la verità dalla falsità. Possiamo chiamare ultraciclo questo circuito senza uscita.
Si potrebbe pensare che tutte queste sottigliezze non ci riguardino. In realtà, il paradosso del mentitore svela la problematica relazione tra linguaggio e logica, verità ed esperienza, con una varietà di implicazioni pratiche con cui dobbiamo fare i conti. Il paradosso fa capolino ogni volta che una comunicazione è intrinsecamente contraddittoria, come ha ben messo in evidenza Gregory Bateson con la teoria del doppio vincolo. Un esempio è l’ordine "sii spontaneo". Se la persona che riceve l’ordine non è spontanea sbaglia perché disobbedisce all'ordine; se è spontanea, comunque non soddisfa l’ordine perché la sua spontaneità è stata imposta. Chi riceve un messaggio contraddittorio non ha via d’uscita: qualunque risposta è sbagliata. Ci troviamo anche qui prigionieri dell’ultraciclo, con un doppio vincolo pratico che paralizza l’azione.
La scuola è un esempio di istituzione che può creare situazioni di doppio vincolo. Gli insegnanti devono continuamente fare i conti con il doppio vincolo: valorizzare la individualità degli allievi e favorire lo sviluppo dei loro talenti, e allo stesso tempo spingere gli allievi a cooperare tra loro e a dare valore alla coesione sociale.
Nella vita aziendale il doppio vincolo si manifesta abbastanza spesso: quando il capo invita i dipendenti a esprimere critiche, ma poi si mostra ostile verso chi esprime dissenso; oppure quando si esorta i dipendenti a essere creativi, ma poi impone un rigoroso rispetto delle regole aziendali.
Il paradosso è un tratto caratteristico delle organizzazioni, e si manifesta con il perseguimento di obiettivi opposti: aprirsi al mondo esterno, e allo stesso tempo difendere i propri confini; incentivare la libera esplorazione di nuove opportunità, e mantenere un rigido controllo sulle attività; avere attenzione al lungo periodo, e non perdere di vista i risultati di breve periodo. E così via.
Poiché il paradosso non può essere evitato, le aziende hanno elaborato pratiche per non restare intrappolate. In buona sostanza, cercano di allocare gli obiettivi conflittuali in aree e ruoli diversi. Ad esempio, ai livelli alti della gerarchia aziendale l’indicazione sarà di prestare attenzione al lungo periodo, mentre a chi opera a livelli più bassi viene indicato di concentrarsi sulla produttività immediata; i ricercatori possono sperimentare, mentre gli ingegneri devono concentrarsi sull’operatività quotidiana. Un’altra possibilità sta nel privilegiare uno degli obiettivi in una fase della vita dell’impresa, per poi virare su quello opposto in una fase successiva.
Quella che preferisco è la soluzione di Sancio Panza. Divenuto governatore dell’isola di Baratteria, un forestiero gli sottopone la seguente questione (Cervantes, Don Chisciotte, II, 51):
Se uno passa su questo punto da una riva all'altra deve prima dichiarare con giuramento dove va e quel che va a fare. Se giura il vero, sia lasciato passare, ma se mente, sia impiccato sulla forca qui innalzata senza alcuna remissione.
Ora accadde che un tale invitato a giurare, dichiarò:
Giuro che passo da qui per andare a morire su quella forca laggiù, e non per altra ragione.
I giudici che dovevano decidere la sorte dell’uomo dissero:
Se quest'uomo lo lasciamo passare liberamente, ha giurato il falso e secondo la legge deve morire; ma se noi l’appicchiamo, siccome egli ha giurato che passava per andare a morire su quella forca, allora ha detto la verità, e secondo la stessa legge, avendo giurato la verità, deve essere lasciato libero.” Il forestiero concluse: “Ora, si domanda alla Signoria Vostra, signor governatore, che cosa faranno i giudici di quest'uomo?”
Dopo una ponderata riflessione, Sancio fornisce il proprio parere:
Perché se la verità lo salva, la menzogna lo condanna, e quindi il mio parere è che rispondiate a quei signori che vi hanno mandato che siccome le ragioni di condanna e di assoluzione qui si bilanciano, lo lascin passare liberamente, perché è sempre meglio far del bene che del male; e questo lo sottoscriverei di mio pugno, se sapessi firmare.
È difficile non concordare con Sancio: quando devi scegliere, e la ragione non t’aiuta, privilegia sempre la vita. Confortati dalla saggezza di Sancio Panza, potremmo allora azzardare una soluzione alla prigione dell’ultraciclo: svincolarsi dal piano esclusivamente logico e aprirsi ad altre ragioni che la pura ragione non può offrire.