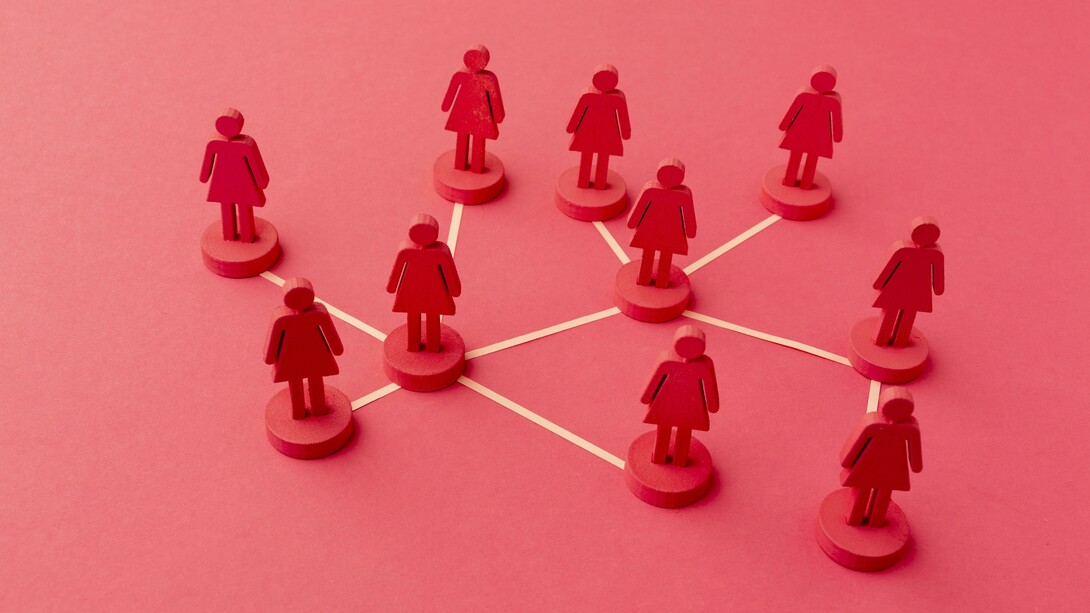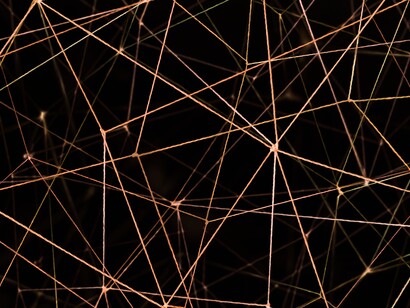Il cambiamento decisivo compiuto negli ultimi trent’anni è consistito nel riconoscere che la Natura (…) è “inesorabilmente non lineare”. I fenomeni non lineari dominano il mondo inanimato molto più di quanto avessimo immaginato, e sono un aspetto essenziale degli schemi a rete dei sistemi viventi. (…) L’esplorazione di sistemi non lineari compiuta nei decenni scorsi ha avuto un impatto profondo sulla scienza nel suo insieme, costringendoci a dare una nuova valutazione di alcune nozioni di base sui rapporti fra un modello matematico e il fenomeno che quel modello descrive. Una di queste nozioni riguarda la nostra interpretazione dei concetti di semplicità e complessità.
Nel mondo delle equazioni lineari eravamo convinti che i sistemi descritti da equazioni semplici si comportassero in modo semplice, mentre quelli descritti da equazioni complicate si comportassero in modo complicato. Nel mondo non lineare – che, come cominciamo a scoprire, comprende gran parte del mondo reale – semplici equazioni deterministiche possono produrre comportamenti di ricchezza e varietà inattese.
(Fritjof Capra, La rete della vita)
È difficile definire cosa sia la complessità. Non perché manchino definizioni, ma perché ogni tentativo di delimitarla rischia di tradirne la natura. La complessità sfugge alle definizioni nette, si sottrae alle classificazioni rigide e proprio per questo, spesso, viene confusa con la complicazione — come se i due termini fossero sinonimi o intercambiabili. Ma non lo sono. E chiarire la differenza tra complesso e complicato non è solo un esercizio linguistico: è un passo essenziale per cambiare il nostro modo di pensare, decidere, agire.
Una via utile per iniziare questa distinzione passa dall’etimologia. Complicato deriva dal latino cum plicum, “con pieghe”: l’immagine è quella di un foglio ripiegato più volte, che può essere spiegato, disteso, reso leggibile. Un oggetto complicato, per quanto articolato, rimanda a qualcosa che può essere decifrato interamente, purché lo si analizzi nel modo corretto. È la logica del rompicapo: c’è una soluzione, anche se non è immediata.
Complesso, invece, deriva da cum plexum, “con nodi”, intrecciato. L’immagine cambia radicalmente: non più la piega da spiegare, ma il nodo che tiene insieme, l’intreccio che costruisce senso proprio nel modo in cui connette gli elementi. Pensiamo a un tessuto, o a un tappeto: ciò che ne fa un disegno non sono i singoli fili, ma le relazioni che li uniscono. Se sciogliamo i nodi, se separiamo ogni filo dagli altri, non otterremo una versione semplificata del sistema, ma la sua dissoluzione. La visione d’insieme non si lascia ricostruire partendo dai frammenti isolati. Non è la somma delle parti, ma qualcosa che emerge dalle loro interazioni.
È questa la prima lezione della complessità: alcune realtà possono essere comprese solo mantenendo l’intreccio che le costituisce. La conoscenza non procede più per scomposizione e ricomposizione, ma per esplorazione delle relazioni. Serve un cambio di sguardo: non più focalizzarsi solo sugli elementi, ma sui legami che li uniscono, sulle retroazioni, sulle dipendenze reciproche, sulle dinamiche che si generano nel tempo.
Questa distinzione non è astratta. Ha ricadute concrete, quotidiane. I problemi complicati, infatti, si affrontano con un approccio analitico: si scompongono in parti più semplici, si esaminano una per una, si individuano le disfunzioni, si procede per correzioni puntuali. È il metodo che ci ha permesso di costruire ponti, progettare macchine, sviluppare tecnologie sofisticate. Se un’automobile non funziona, ad esempio, si cerca il pezzo guasto, lo si sostituisce, e il sistema torna operativo. Il problema è complicato, ma risolvibile, e la soluzione è spesso replicabile.
Ma quando ci troviamo di fronte a situazioni complesse, questa logica non basta più. I problemi complessi non si lasciano ridurre a componenti isolate. Sono sistemi dinamici, in continua trasformazione. Ogni azione che compiamo dentro di essi modifica il sistema stesso, genera effetti che si propagano nel tempo e nello spazio, produce conseguenze non sempre prevedibili. Per affrontarli, è necessario adottare un duplice sguardo: da un lato sistemico, capace di cogliere le connessioni, le dipendenze, le configurazioni globali; dall’altro emergenziale, capace di immaginare gli sviluppi possibili, le traiettorie inaspettate, le forme che il sistema potrebbe assumere.
Prendiamo il caso di una malattia. Anche quando colpisce un organo specifico, non è sufficiente intervenire localmente: l’organo è inserito in una rete di relazioni fisiologiche, biochimiche, psicologiche. Curare non è solo eliminare il sintomo, ma comprendere come l’intero organismo reagisce all’intervento, come si riorganizza, quali equilibri si alterano, quali ne emergono di nuovi. E questo vale ancora di più se si guarda alla malattia in relazione al contesto: alla vita della persona, alle sue condizioni emotive, sociali, ambientali. Nessun organo è separato o separabile dagli altri.
Il problema nasce quando si affrontano sistemi complessi con strumenti pensati per problemi complicati. È l’errore più frequente: quello di ridurre la complessità alla somma delle sue parti, nella speranza di renderla più gestibile. Si cerca il “colpevole”, il “pezzo rotto”, l’errore da correggere, e si agisce come se si fosse di fronte a un ingranaggio da riparare. Ma questo approccio, per quanto rassicurante, è spesso inefficace. Anzi, può generare danni: produce effetti collaterali inattesi, innesca reazioni a catena, peggiora la situazione nel medio e lungo periodo. Le soluzioni rapide, in contesti complessi, sono spesso scorciatoie che portano lontano dalla comprensione.
Occorre allora un’altra attitudine, un altro modo di pensare. La complessità non è caos, non è disordine, non è imprevedibilità totale. Al contrario, è un ordine che emerge: un ordine non imposto, ma generato dalle relazioni tra le parti. In un sistema complesso, le connessioni non sono casuali, né completamente determinate: si organizzano in configurazioni ricorrenti, danno vita a pattern, a trame di senso che possiamo riconoscere, studiare, abitare. È una logica della forma più che della funzione, della relazione più che dell’oggetto, del processo più che dello stato.
Per questo, accogliere la complessità significa accettare l’incertezza, non come fallimento della conoscenza, ma come sua condizione. Significa sviluppare una sensibilità nuova: saper vedere ciò che si genera nelle interazioni, ascoltare i segnali deboli, intuire le direzioni in cui un sistema si sta muovendo, anche quando non è ancora visibile l’esito. Non si tratta di rinunciare a capire, ma di cambiare modo di comprendere.
Affrontare la complessità diviene un atto di intelligenza e di umiltà: richiede di abbandonare l’illusione del controllo totale, per aprirsi all’esplorazione, alla co-evoluzione, alla possibilità che le cose si trasformino anche grazie al nostro stesso intervento. E forse è proprio questa la sfida più radicale: imparare a pensare con il mondo, non solo sul mondo.