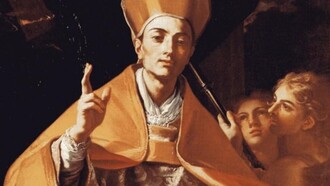Il grano è un simbolo fondamentale nella storia dell’uomo, le sue origini sono mistiche e risalgono a tempi antichi. Ci sono testimonianze archeologiche che attestano la coltivazione del grano nel passato; infatti, sono stati rinvenuti rudimentali aratri - in Egitto, in Mesopotamia e in Palestina - di ottomila anni fa. Proprio grazie al grano era possibile sfamare la popolazione anche in periodi difficili di carestia e per questo è diventato il simbolo di abbondanza e fertilità.
Il chicco di grano che muore e consente la nascita di una nuova vita richiama alla resurrezione e l’antico Egitto legandolo ad Osiride, dio degli inferi e della fertilità, che insegnò al suo popolo i segreti dell’agricoltura. Era importante e necessaria la sua ciclicità che lo lega ad un altro personaggio antico con una forte connessione con la terra, è Persefone che con i suoi sei mesi di vita sulla terra e sei nell’oltretomba veniva associata al ciclo del grano che viene seminato in autunno e che germoglia in primavera.
Il grano diventa un simbolo che attraversa i tempi e i luoghi. Nella Bibbia il chicco di grano che germoglia simboleggia la vita eterna e la resurrezione per diventare l’alimento di cui l’anima ha bisogno. L’anima ha bisogno di speranza e questo la lega al ciclo di vita che il grano continua ad avere negli anni.
Il grano è il simbolo della fertilità perché è una delle prime “piante domestiche” il cui uso per scopi alimentari ha innescato grandi cambiamenti nelle culture di tutto il mondo. La sua coltivazione ha dato la possibilità a molte popolazioni di progredire e di svilupparsi creando attorno ad esso una venerazione che si estende da secoli. Il ciclo del grano viene celebrato e si è fuso con riti religiosi che hanno un significato profondo che resta immutato nei secoli. Durante i mesi estivi la celebrazione ha il suo apice con la celebrazione da parte della comunità contadina di un rinnovato senso di appartenenza e coesione sociale.
Ancora oggi in molti comuni italiani esiste un modo antico per onorare il simbolo della resurrezione e della fertilità. A Flumeri, Fontanarosa, Foglianise, Jelsi, Mirabella Eclano, San Marco dei Cavoti e Villanova del Battista, comuni situati nell’Appennino tra la Campania e il Molise. La celebrazione del grano avviene attraverso spettacoli, macchine spettacolari realizzate da artigiani locali esperti nell’intrecciare gli steli di grano.
A Foglianise, provincia di Benevento, la festa del grano ha origini nel 1482 le cui fonti narrano di una “festa dell’Abbondanza” con riti dedicati alla mietitura e al raccolto. Questa festa si lega al culto di San Rocco che intercede per la popolazione alla librazione dell’epidemia che colpisce la popolazione e le cui reliquie arrivarono a Foglianise nel 1728. Anno nel quale venne realizzato il primo carro dedicato a San Rocco al quale era consacrata una cappella al Casale Cautani risalente al 1500.
Il giorno di San Rocco, 16 agosto, i carri di grano ricevono la benedizione dinanzi ad essa. La cappella però era inizialmente dedicata a San Sebastiano ma con l’arrivo della pestilenza venne trasformato in lazzaretto e successivamente dopo l’intercessione di San Rocco che liberò il paese dalla peste venne ad esso dedicata. Al suo interno è conservata una statua policroma dedicata al santo. La scultura è del XVII secolo ed è opera della scuola napoletana e rappresenta il simbolo della processione; infatti, fa parte del corteo e viene ricoperta di doni, soprattutto ex voto sia in oro che in argento.
Importante documento relativo alla festa del grano è il Libro del Cannaruto, forse denominato così a causa della golosità dell’autore. In esso sono riportate con precisione le offerte fatte al santo durante l’anno ma anche durante i festeggiamenti. Sono riportate anche le spese sin dal 1730, in esso c’è un’introduzione in cui viene spiegata la festa che si tiene in onore di san Rocco.
Le processioni in onore di san Rocco inizialmente erano costituite da un gruppo di fanciulle che procedeva nel corteo con sul capo delle ceste piene di spighe. I carri invece portavano i sacchi di grano adornati con mazzetti di spighe e festoni di granturco venivano trainati da buoi. Il corteo, una volta arrivato alla cappella di san Rocco, si inginocchiava per ricevere la benedizione del sacerdote.
Il primo carro dedicato a san Rocco viene realizzato con intrecci di grano ed era alto circa 25 m poi si sono evoluti e sono diventate delle vere e proprie opere d’arte. I carri sono realizzati da mani sapienti che hanno fatto dell’intreccio della paglia un’arte. Quelle che sono tecniche per la produzione di oggetti quotidiani vengono usate per realizzare le sculture che compongono i carri. Il carro nasce da un ex voto che ringrazia dell’abbondante raccolto ma chiede intercessione affinché lo sia anche il prossimo. I carri che sfilano a Foglianise sono circa 30 e accanto ad essi sfilano donne con vestiti popolari e ognuno viene preceduto da un covone o da ceste che ricordano l’antica tradizione della festa.
Gli eventi in onore dello “spirito del grano” sono molti e sono riconducibili alla superstizione che vuole far sopravvivere l’anima che vive nei campi e che dovrà affrontare ogni anno un nuovo ciclo di vita. Questa festa ha un sapore antico e mistico ma resta un modo per la comunità di stringersi in gruppo e affrontare il nuovo ciclo agricolo nel miglior modo possibile. La comunità aiuta a superare le difficoltà e facendo parte di una comunità ci si carica di una forza che non è solo la propria ma è quella di tutta la comunità.
Bibliografia
M. Zampelli, San Rocco a Foglianise, articolo su Fogliapress.
F. Zampelli, La festa del grano: Foglianise si veste d’oro, articolo in Eroica Fenice, 2023.
U. Fantasia, I cereali nell’antica Gracia e l’approvvigionamento granario dell’Atene classica, Università degli Studi di Parma, Italia.
H. Sanità, Campanili di grano: rituali festivi e ipotesi patrimoniali UNESCO lungo l'Appennino meridionale, ed. Il Mulino, Bologna 2021.
La festa del grano di Foglianise, cenni storici.