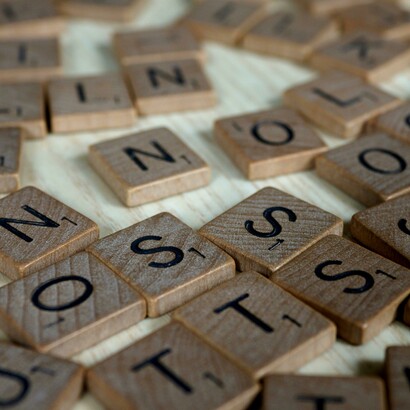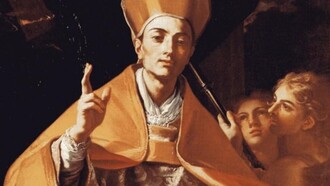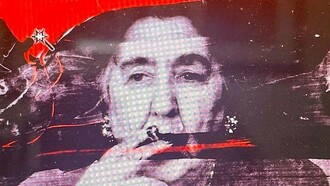Nel 1961 Fritz Leiber scrisse The Silver Eggheads, un romanzo di fantascienza tradotto in italiano col titolo Le argentee teste d’uovo nella collana dei Classici Urania. L’autore immagina un prossimo futuro in cui le opere letterarie sono composte elettronicamente da mulini-a-parole. Ecco una conversazione in cui un padre spiega al figlio di cosa si tratta:
Padre: Ecco qua, figliolo. Guardalo. No, no, non devi appoggiarti a questo modo. Figlio: È grande, papà.
Padre: Sì, è grande. È un mulino a parole, figlio, una macchina che scrive libri di narrativa. […]
Figlio: È un robot, papà?
Padre: No, non è un robot come l'elettricista o il tuo insegnante. Un mulino a parole non è una persona come lo è un robot, sebbene entrambi siano fatti di metallo e funzionino grazie all'elettricità. Un mulino a parole è come un calcolatore elettronico, ma manipola le parole non i numeri. E come la grande macchina che gioca a scacchi o che fa i piani di guerra, ma fa le sue mosse in un romanzo invece che su una scacchiera o su un campo di battaglia. Ma un mulino a parole non è vivo come un robot e non può muoversi e andare in giro. Può solo scrivere libri di narrativa. […] Vi sono infiniti modi di raccontare una vicenda. […] Il modo dipende dalle parole che vengono scelte. Ma una volta che è stata scelta una parola, le altre devono adattarsi a quella. Devono avere lo stesso tono o la stessa atmosfera e devono adattarsi alla catena di suspense con precisione micrometrica… te lo spiegherò più tardi.
Siamo nel 1961 e già Leiber immagina una macchina che manipola parole con precisione micrometrica: “una volta che è stata scelta una parola, le altre devono adattarsi a quella”. Alcuni anni più tardi, nel 1967, Italo Calvino tiene una conferenza dal titolo Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), pubblicato nella raccolta di saggi Una pietra sopra, Einaudi, 1980. dove afferma:
“I cervelli elettronici, se sono ancora lungi dal produrre tutte le funzioni d’un cervello umano, sono però già in grado di fornirci un modello teorico convincente per i processi più complessi della nostra memoria, delle nostre associazioni mentali, della nostra immaginazione, della nostra coscienza. Shannon, Weiner, Von Neumann, Turing, hanno cambiato radicalmente l'immagine dei nostri processi mentali. Al posto di quella nuvola cangiante che portavamo nella testa fino a ieri e del cui addensarsi o disperdersi cercavamo di renderci conto descrivendo impalpabili stati psicologici, umbratili paesaggi dell'anima, - al posto di tutto questo oggi sentiamo il velocissimo passaggio di segnali sugli intricati circuiti che collegano i relè, i diodi, I transistor di cui la nostra calotta cranica è stipata.
Sappiamo che, come nessun giocatore di scacchi potrà vivere abbastanza a lungo per esaurire le combinazioni delle possibili mosse dei trentadue pezzi sulla scacchiera, così - dato che la nostra mente è una scacchiera in cui sono messe in gioco centinaia di miliardi di pezzi - neppure in una vita che durasse quanto l'universo s’arriverebbe a giocarne tutte le partite possibili. Ma sappiamo anche che tutte le partite sono implicite nel codice generale delle partite mentali, attraverso il quale ognuno di noi formula di momento in momento i suoi pensieri, saettanti o pigri, nebulosi o cristallini.”
Calvino comprende che “la numerabilità e la finitudine stanno avendo la meglio sull’indeterminatezza dei concetti”, che il processo in atto “è quello d’una rivincita della discontinuità, divisibilità, combinatorietà, su tutto ciò che è corso continuo, gamma di sfumature che stingono una sull'altra”, e annota: “L'uomo sta cominciando a capire come si smonta e come si rimonta la più imprevedibile di tutte le sue macchine: il linguaggio”.
Prevede che la macchina computazionale, non quella empirica degli anni Sessanta ma la macchina potenziale già implicita nei presupposti di numerabilità e combinatorietà, può dare forma a ogni manifestazione del linguaggio, e si chiede “Quale sarebbe lo stile di un automa letterario?” Ovviamente, il primo stile sarebbe quello classico, perché ogni macchina diligente la prima cosa che fa è seguire le regole. Ma niente impedisce alla macchina di fare esperimenti e utilizzare il caso per destrutturare le regole, comportandosi così come una avanguardia letteraria. Allora la macchina sarà in grado di fare letteratura.
Non sorprende questa conclusione. Anzi, Calvino sottolinea “ho sempre saputo che le cose stavano così”, perché “la letteratura come la conoscevo io era un'ostinata serie di tentativi di far stare una parola dietro l'altra seguendo certe regole definite, o più spesso regole non definite né definibili ma estrapolabili da una serie di esempi o protocolli, o regole che ci siamo inventate per l'occasione, cioè che abbiamo derivate da altre regole seguite da altri”. E, in virtù del fatto che lo scrittore esplicitamente o implicitamente segue delle regole, Calvino afferma: “Lo scrittore quale è stato finora già è macchina scrivente, ossia è tale quando funziona bene: quello che la terminologia romanzesca chiamava genio o talento o ispirazione o intuizione non è altro che il trovar la strada empiricamente, a naso, tagliando per scorciatoie, là dove la macchina seguirebbe un cammino sistematico e coscienzioso, ancorché velocissimo e simultaneamente plurimo.”
L’inevitabile risultato è quello di Leiber: “ciò che sparirà sarà la figura dell’autore, … l’autore questo personaggio anacronistico, portatore di messaggi, direttore di coscienze, dicitore di conferenze alle società culturali.” Ed ecco la provocazione finale: “Scompaia dunque l'autore - questo enfan gâté - per lasciare il suo posto a un uomo più cosciente, che saprà che l'autore è una macchina e saprà come questa macchina funziona.”
Dopo aver affermato che “la letteratura è tutta implicita nel linguaggio” e che una cosa non si può sapere se le parole ‘per dirla e pensarla’ non sono usate in quella posizione e disposte in quella successione, Calvino prova a ribaltare il ragionamento domandandosi: e se la battaglia che la letteratura conduce non sia invece accettare la sfida di uscire fuori dai confini del linguaggio, del già detto, dell’indicibile, dei tabù, del rimosso? nel dare voce all’inconscio sociale e individuale che è rimasto non detto?
Dunque, ecco la conclusione:
La letteratura è sì gioco combinatorio che segue le possibilità implicite nel proprio materiale, indipendentemente dalla personalità del poeta, ma è gioco che a un certo punto si trova investito d'un significato inatteso, un significato non oggettivo di quel livello linguistico sul quale ci stavamo muovendo, ma slittato da un altro piano, tale da mettere in gioco qualcosa che su un altro piano sta a cuore all'autore o alla società a cui egli appartiene. La macchina letteraria può effettuare tutte le permutazioni possibili in un dato materiale; ma il risultato poetico sarà l'effetto particolare d’una di queste permutazioni sull'uomo dotato d’una coscienza e d’un inconscio, cioè sull'uomo empirico e storico, sarà lo shock che si verifica solo in quanto intorno alla macchina scrivente esistono i fantasmi nascosti dell'individuo e della società.
Dal saggio di Calvino sono passati poco meno di sessant’anni, e la macchina letteraria ha fatto passi da gigante. Oggi non solo è in grado di produrre catene di ragionamenti complessi con un rigore irraggiungibile anche per il più dotato degli umani, ma genera testi le cui regole elusive sono apprese estraendole dai milioni di testi disponibili.
Eppure, la conclusione di Calvino ci indica ancora qualcosa di fondamentale, dell’esistenza di un quid umano che la macchina scrivente non può imitare perché, semplicemente, non detto. Infatti, i mulini delle parole e le macchine letterarie possono solo costruire testi a partire dal già detto: nulla sanno di ciò che, qui e ora, agita l’inconscio individuale e collettivo, e che solo un soggetto umano - in quanto esclusivo membro di quel mondo, unica antenna in grado di percepirne i segnali - può portare alla luce in un testo.
In definitiva, se l’umano vuole continuare ad affermare una propria distintiva utilità nell’era dei mulini a parole, ciò che gli è richiesto è una più profonda consapevolezza della propria identità individuale e collettiva, insieme alla competenza di dare voce, in un linguaggio appropriato, ai segnali più sfuggenti e mutevoli di quella identità.