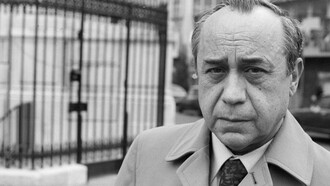Nel 1990 a Benevento, precisamente in contrada Cellarulo area molto vicina al centro storico, sono iniziati i lavori di costruzione per una nuova tangenziale. In quest’area le fonti storiche sono diverse e indicano un’area urbana o suburbana caratterizzata dalla presenza di impianti per la produzione della ceramica. I lavori vennero sospesi per il ritrovamento di reperti, si doveva verificare cosa nascondeva questa porzione di città. Inizialmente l’ipotesi più accreditata era di un sito per la produzione della ceramica soprattutto per la presenza di materiale ceramico rinvenuto anche in altre occasioni.
Quello che emerse dai primi sbancamenti creò lo spunto per proporre la costruzione di un parco archeologico-naturalistico e di sottoporre questo progetto all’attenzione della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della provincia di Benevento.
Le campagne di scavi sono diverse una tra il 2004-2006 un’altra 2008-09 con a capo la Soprintendenza e fiancheggiata dal Dipartimento di Studio delle Componenti culturali del territorio della Seconda Università di Napoli nell’ambito del Progetto P.O.R.
Le ricerche hanno portato alla luce molte informazioni, la zona era abitata sin dal III secolo a. C. e il suo abbandono avvenne dopo il III secolo d.C. Inizialmente venne considerato un quartiere industriale, distinto dalla città abitata perché il suo impianto stradale era longitudinale e in contrasto con quello della città antica, già conosciuta, che si estende sul colle della Guardia.
Sono emerse strutture di una vera e propria cittadina abitata e fortificata, erano presenti diversi piani di posa di edifici le cui fondazioni risalgono al 268 a.C. La cittadina era protetta da una cinta muraria ancora visibile che inglobava una torre con pianta rettangolare e una porta dalla quale passava la strada proveniente dal Molise e dalle altre regioni del Sannio. La strada passava su quello che nei testi viene chiamato pons maior, cioè, Ponte Fratto che dopo il medioevo crollò e non venne più ricostruito.
Le nuove informazioni rafforzano l’idea che il primo insediamento della città sorgeva sulla confluenza dei due fiumi, Sabato e Calore, e che lì erano collocate le industrie e i depositi che consentivano di commercializzare con le altre città. La presenza di una banchina fluviale, di cui oggi si capiscono i resti, conferma la posizione strategica della zona.
Lo studio di quest’area ha consentito una ricostruzione delle trasformazioni subite dal capoluogo sannita prima dell’arrivo dei Longobardi dando la possibilità di capire la vera storia della città e la sua evoluzione urbanistica. Cambiamento già iniziato con lo spostamento della vita cittadina dalla pianura vicino al fiume al colle che consentiva una maggiore difesa.
L’ipotesi fatta sull’abbandono di Cellarulo(ora Parco Archeologico Cellarulo, n.d.r.) viene confermata, la causa è una possibile esondazione che colpì l’area nel II secolo d.C. e che causò il crollo di diverse strutture.
Probabilmente le strutture erano già in condizioni precarie a causa dei terremoti che colpirono la zona e queste due calamità portarono alla creazione di depositi alluvionali. Questa situazione causò lo spostamento delle attività industriale presso il ponte della Maurella, sempre sul fiume Calore, vicino al luogo in cui oggi si vede sorgere il ponte detto Vanvitelliano. Le attività però non erano così grandi ma in questo caso le scoperte archeologiche fatte lasciano pensare a poche industrie con banchina per lo spostamento delle merci.
La cinta muraria rinvenuta a Cellarulo era costituita da blocchi quadrati di tufo e in alcuni tratti si capisce che questi erano stati asportati completamente per farne materiale da riciclo, l’asportazione completa è dimostrata dai resti di limo argilloso di origine fluviale presente nei luoghi in cui prima vi erano i conci di tufo. Le mura avevano anche una porta d’ingresso che aveva una struttura raddoppiata, cioè, era costituita da due aperture separate e da un elemento portante. Questo tipo di porta consentiva sia per rinforzare la difesa della città ma anche di rinforzare la struttura di cui facevano parte. Dagli scavi ne è emersa anche una torre difensiva quadrangolare che però sembra crollate a causa di un terremoto precedente forse tra il I o il II secolo d.C.
Le mura hanno dato molte informazioni e hanno consentito di fare delle ipotesi sull’impianto urbanistico originario della città. La tipologia costruttiva delle mura venute alla luce a contrada Cellarulo risulta la stessa delle mura che ancora oggi circondano la città antica ed è per questo che gli studiosi hanno ipotizzato che le mura difensive di Benevento non erano solo quelle che vediamo ma che avevano un’estensione molto importante. Questo rendeva la città molto grande e le mura proteggevano sia il colle della guardia sia la parte pianeggiate di Cellarulo.
Le mura sono state trasformate nei secoli successivi fino ad assumere l’assetto che si vede dalle diverse viste storiche della città. Le mura hanno subito diverse ricostruzioni e demolizioni nei secoli ma gli storici concorda sul considerare quelle esistenti il risultato di un progetto difensivo che vedeva al centro del loro interesse la parte abitata dai cittadini. La cinta muraria ristretta della città risale per la maggior parte al IV secolo e al suo interno si è svolta la storia cittadina.
Sulle mura che circondano Cellarulo ci sono varie ipotesi e oltre a quella di mura lunghe tutto ‘abitato della città c’è l’ipotesi che questa contrada presentasse delle sue fortificazioni perché l’idea era quella di proteggere la zona suburbana di vocazione industriale. Considerando la lunghezza delle mura da Cellarulo fino alla zona in cui è collocata la chiesa Santa Sofia risulta difficile pensare che fosse tutto protetto da mura ed è per questo che l’ipotesi della separazione tra le diverse zone con le relative mura sembra la più plausibile.
Cellarulo dopo l’abbandono avvenuto nel III secolo d.C. tornò ad essere frequentata nel IV secolo e nell’alto medioevo, ma non come luogo di vita cittadina ma come cava da cui reperire materiale da costruzione. La strada basolata mostra tracce di spoliazione e una strada secondaria risulta rialzata in ciottoli e sempre con materiale di spoglio. Oggetto di spoglio sono stati anche altri importanti monumenti come l’anfiteatro di cui oggi ne resta una piccola traccia e la cui ricostruzione mostra l’importanza del centro abitativo in cui sorgeva.
Insieme a Cellarulo rimasero fuori dalla città anche altri elementi che potevano minare la difesa della città. Oltre all’anfiteatro rimasero fuori altri pezzi di storia come il ponte Leproso e la Porta San Lorenzo che divennero zone extraurbane.
La struttura urbana che oggi vediamo è quella che gli storici chiamano la Civitas Nova cioè la porzione di città recuperata da Arechi II, per ragioni difensive, nel VII secolo d.C.
Nel 2015 la città di Benevento ha subito una devastante alluvione che ha spazzato via il parco e tutto ciò che era al suo interno. Oggi il parco Cellarulo è abbandonato a sé stesso, risulta chiuso anche se i due ingressi sono stati forzati dando la possibilità a chiunque di entrare. Sono state fatte diverse petizioni, diverse proteste, ma ancora non si vede nessuna reazione concreta. È difficile capire perché la nostra storia e la nostra eredità sia rimasta chiusa dietro un cancello per tutti questi anni.
La nostra storia non deve essere dimenticata, la nostra eredità deve essere portata alla luce, dobbiamo salvaguardare il nostro patrimonio culturale e bisogna farla rivivere perché la storia della nostra città. Non avere cura per la propria storia è come non avere cura di se stessi e questo non porterà a migliorare le condizioni di una città che ha tanto da offrire ma che viene completamente ignorata.
Bibliografia
M. Rotili, Archeologia postclassica; Benevento nella tarda antichità dalla diagnostica archeologica in contrada Cellarulo alla ricostruzione dell’assetto urbano, Arte Topografica Editrice, Napoli, 2006.
M. Rotili, Nuovi rinvenimenti a Benevento, Atti del IX Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo. A cura di S. Gelichi, All’insegna del Giglio, Firenze 2012.
M.Rotili, Considerazioni su Benevento nella tarda antichità, in Aristocrazie e società fra transizione romano-germanica e alto medioevo, a cura di M. Rotili e C. Ebanista, Tavolario Edizioni, Napoli, 2015.
L. Notari, Finestre del cielo: guida alle edicole votive di Benevento nel perimetro delle Mura Longobarde, ed. il Chiostro, Benevento, 1999.
L. Santoro, La Rocca dei Rettori e la cinta fortificata di Benevento, estratto da Studi in onore di Roberto Pane, Istituto dell’architettura dell’università di Napoli, Napoli, 1971.
M. Rotili, Benevento e la provincia sannitica, Roma, 1958.
M. Rotili, Benevento Romana e Longobarda, l’immagine urbana, Banca Sannitica, Ercolano, 1986.
M. Rotili, Architettura e Scultura dell’alto medioevo a Benevento, Fratelli Lega, Ravenna, 1967.
M. Rotili, Architettura e Scultura dell’alto Medioevo a Benevento, in Archeologia del paesaggio medievale: studi in memoria di Riccardo Francovich, a cura di Stella Patitucci Uggeri. Ed. All’insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo (FI), 2007.
Civiltà cittadina - Gli Statuti locali e gli antichi mestieri, Ed. Masone, Benevento, 1988.
G. De Antonellis, Benevento città murata, Cinta, Porte, palazzi, torri, campanili, Club di Autori indipendenti, Castellammare di Stabia, 2015.
G. Mongelli, Storia di Benevento e dintorni, Ed. Gennaro Ricolo.
V. Mazzacca, Mura e sentieri: Antiche mura di Benevento, San Lorenzo Maggiore, Benevento, 1994.
P. Rende, Storia ed Urbanistica della Benevento romana e medievale attraverso l’uso della fotografia aerea, 2015.
R. Parisi, Iconografia di una città pontificia: Benevento in età moderna e contemporanea, in Iconografia delle città in Campania, a cura di C. De Seta, A. Buccaro, Electa, Napoli, 2007.
S. Rapuano, Benevento e la trasformazione della città, ricerche archeologiche a Cellarulo, ed. Il Poligrafo, Milano, 2018.