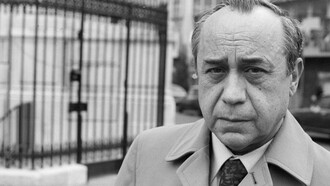La vita inaspettata, onirica, contraddittoria.
La vita con le emozioni i paradossi e le coincidenze.
Quella che sfugge al pieno controllo.
La mente con i suoi sogni.
L’inconscio che intesse il tangibile.
La vita è un'opera surrealista?
Nato a Parigi nella prima metà del Novecento, il Surrealismo si affacciò alla letteratura per poi espandersi alle arti visive, contaminando ogni forma d’espressione a partire dallo sguardo onirico e rivoluzionario. Le premesse furono riportate sulla rivista Littérature fondata nel 1919 da André Breton insieme a Louis Aragon e Philippe Soupault, gruppo di intellettuali reduci dallo spirito sovversivo dadaista.
All’interno del Manifeste du Surréalisme pubblicato dallo stesso Breton nel 1924, ne fu esplicitata la definizione di denominazione.
Egli affermava:
Il surrealismo si fonda sull’idea di un grado di realtà superiore connesso a certe forme di associazione finora trascurate, sull’onnipotenza del sogno, sul gioco disinteressato del pensiero. Tende a liquidare definitivamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi ad essi nella risoluzione dei principali problemi della vita.
All’interno del manifesto furono riportati i fondamenti su cui poggiava l’intera linea di pensiero. Complici le teorie Freudiane sul sogno, la sessualità, la valorizzazione della psiche: si venne a costituire un quadro a sfavore della razionalità, la logica.
Un quadro esaltante l’inconscio, l’automatismo psichico, la libera associazione delle idee e ciò che fino a quel momento era stato lasciato represso.
Tale correlazione era in grado di conferire validità all’artefatto soprattutto quando esso nasceva dal fortuito, dall’istantaneo e dal casuale.
A percorrere questo binario espressivo ci furono personalità come: Dorothea Tanning, René Magritte, Pablo Picasso, Max Ernst, Man Ray, Joan Mirò, Salvador Dalì.
L’arte apriva un cassetto innovativo, consentendo presa di coscienza e vantaggio alla sua ambivalenza: selvaggia ed infantile.
Il Surrealismo, innalzante la necessità di un viaggio di ritorno interiore, eleva, attraverso i suoi ideali, la dimensione d’esperienza pre-logica.
Esperire il quotidiano contiene in sé un inevitabile accoglimento della sfera onirica, costituente l’elemento pulsante del movimento di discussione.
Ciò è rilevabile in testi del tempo ma anche nelle diversificate figurazioni irrazionali rappresentanti una trascrizione fedele della realtà interiore.
N. Fabre affermava:
Durante il sonno il nostro inconscio esprime quello che non sappiamo o quello che non osiamo dire a noi stessi: i nostri desideri, i nostri tormenti, le nostre angosce I sogni camuffano le informazioni dell’inconscio dietro immagini banali o, al contrario, straordinarie, al fine di proteggerci dalla crudezza delle pulsioni. Ma se il nostro bisogno di controllo prende il sopravvento, allora ci rifiutiamo, inconsciamente, di lasciarci sorprendere da certe rivelazioni che potrebbero spaventarci.
Platone nella Repubblica diceva che in ognuno di noi risiedono dei pensieri orribili, selvaggi, sregolati e questo è messo in evidenza dai sogni.
La mente si esplicita come un laboratorio surrealista che, con la sua componente inconscia, il più delle volte, coordina i fili delle azioni quotidiane e come una protagonista silenziosa ed apparentemente non visibile, costituisce il percorso umano sotto lo sguardo inconsapevole. La poetica del Surrealismo si equipara ad una filosofia che trova la forza di emergere nella natura umana, ieri come oggi.
Ancor prima di volgere gli occhi al mondo, impone una necessità: guardare oltre la punta dell’Iceberg, affinché si comprenda ciò che in evidenza sfugge.
Nel processo di immersione, si scende a patti con la parte sommersa del nostro io più profondo: valorizzando i processi creativi automatici, non sottoposti a censura o a volontà estetiche, ma finalizzati alla manifestazione di un abisso.
Il Surrealismo svolge un perverso gioco con il tempo: lo spezza, lo ripiega, lo sospende. Il presente è sottoposto ad improvvise irruzioni del passato, il passato guarda al futuro ed il domani cammina all’indietro.
Se si dovesse comparare la complessità umana non sarebbe difficile intercettare una matrice surrealista. Bellezza e dolore, ordine e caos, ambivalenza nella verità.
Si parli della sessualità come di una dimensione fluida che discosta le classificazioni dalle attitudini. Con i suoi desideri e le pulsioni, essa costituisce una forza psichica profonda spesso non riconciliata totalmente con la coscienza.
Inattesa, irrazionale, contraddittoria, prende forma decontestualizzandosi a partire da un odore o da un tenue sguardo ed è in grado di costruire un potente cortocircuito emotivo. Atto non fissabile, trasformativo, intimamente poggiato su imprevedibili significazioni ed in quanto tale, surrealista.
“Qualsiasi scoperta che muti la natura, la destinazione di un oggetto o di un fenomeno – scrisse Breton – costituisce un fatto surrealista”.
La vita percorre binari imprevisti in diversificati angoli temporali: sogniamo ad occhi aperti nella creazione di scenari alternativi a partire da abissi interni.
Costruiamo colonne a partire da mattoncini intuitivi.
Occupiamo le nostre vite e ci fermiamo per casuali lapsus.
Nella distrazione razionale limitiamo la nostra non concettualizzabile natura.
Percorrere la strada di casa, riconoscere dei volti, conoscerne di nuovi costituisce un collage mentale di personalità a cui ci si affaccia in maniera imprevedibile.
Un oggetto dimenticato sul marciapiede innesca istanti d’infanzia che avevamo dimenticato di ricordare. Un libro sulla panchina contiene un titolo, la cui sequenza di parole, inspiegabilmente resta in testa per ore. La frase di un passante che ascoltata per caso finisce per salvare la vita ad un amico.
Ogni giorno si diversifica a partire dall’incongruenza.
In ogni momento riaffiora un angolo del nostro essere di cui ci sfugge la presenza.
Nel non visibile, l’esistenza si rivela.