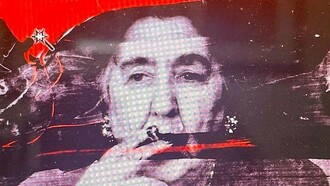Elephas indus culices non timet.
(Motto di Domenico Malatesta)
I Malatesta, che tanto avevano ossessionato Ezra Pound, mi hanno sempre stupito e incuriosito per il loro nome e la loro variegata araldica; la fascia a scacchiera, l’elefante indiano, le tre teste barbute (le prime due in posizione spesso variata), la rosa radiante e molte altre. L’araldica esprime in sintesi i carismi spirituali e i talenti di una stirpe e quelli dei Malatesta appaiono estremamente originali, singolari. La stessa architettura delle molte rocche malatestiane appare riconoscibile nel suo stile austero, dorico, semplice, tendente al circolare. Anche le origini “mitiche” della stirpe come autocelebrata appaiono stupefacenti: Scipione l’Africano e la sua Gens Cornelia.
Detto questo, cosa può connettere questa aristocrazia di origine montefeltrina all’immaginario del Santo Graal? In primo luogo, la più probabile origine germanica della stirpe: da Azzo di Lotaringia, esponente di una stirpe presente in Lorena e in Svevia che sono i territori tipici più pertinenti e di riferimento per il successo e la perpetuazione della saga graalica. Oltre a questo la loro unione con gli Atti di Sassoferrato con Isotta data in sposa a Sigismondo Pandolfo Malatesta. Gli Atti a loro volta sono antica famiglia longobarda estremamente feconda e importante perché da essi derivano sia gli Aleramici-Monferrato che i Canossa i cui territori andavano da Mantova fino a Perugia e Chiusi, termine meridionale dell’antica Lotaringia palatina.
Gli antenati di Matilde di Canossa ebbero a che fare con Carlo Magno e il racconto del miracoloso ritrovamento delle reliquie di Longino, poi inumate nella Basilica di Sant’Andrea in Mantova. Il vescovo Liutprando di Cremona nella sua opera Antapodosis ricorda che la Lancia di Longino era custodita da un conte longobardo di nome Sansone e poi passò a Enrico l’Uccellatore in cambio di un feudo in Svevia. Vediamo come sia possibile quindi ricostruire un humus aristocratico-simbolico-mitografico che sottolinea una possibile valenza spirituale-rituale dei Malatesta quali custodi-difensori di un retaggio graalico. Questo spiegherebbe più in profondità la loro importanza per la Chiesa e per il governo della Romagna (nome di origine bizantino: la terra dei Romani): Rimini quale baluardo per Ravenna e i Malatesta quali garanti del “corridoio bizantino” che connetteva l’Esarcato/Pentapoli alla Roma dei Papi.
Se possiamo immaginare una dama di celebre bellezza quale custode del Graal possiamo pensare degnamente a Isotta degli Atti o a Dorotea Malatesta. A questo aggiungiamo due dettagli molti suggestivi e allusivi: una miniatura e un particolare di un affresco. La miniatura in questione mostra Pandolfo Malatesta da Pesaro che si avvicina a una dama allegorica incoronata, con mantello picchiettato e brandente una lunga spada con la mano destra la quale offre al nobile con la sinistra un grande e ricco recipiente trilobato dal contenuto enigmatico (Angelo Turchini, I Malatesta. Signori di Rimini e di Cesena; P.G.Pasini, I Malatesti e l’arte; Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane).
Il secondo dettaglio è la presenza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, a cavallo di un bianco destriero, nel corteo della Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli a Palazzo Medici Riccardi in Firenze. Affresco magnifico e ricco di elementi simbolici. Il tema iconologico dei Re Magi appare assolutamente intimo con il tema graalico per vari motivi tra cui la spiritualità ancestrale e paradigmatica di Melchisedek e l’immagine dei recipienti dei Re orientali nei loro simbolici doni al Dio infante, già implicitamente graalici.
Approfondisce questo tema, tra gli altri studiosi, Mario Moiraghi nel suo saggio: La scoperta del vero santo Graal. I Malatesta tennero sempre rapporti di difesa militare a favore di Firenze, divenendo talvolta anche comandanti generali della città del giglio. Oltre a ciò possiamo sottolineare altri aspetti come i colori alchemici del loro stemma (bianco, nero, rosso e giallo) e la connessione anche con Ravenna, ad esempio con Malatesta della Penna e le sue relazioni con la Chiesa di Ravenna, una delle città più graaliche d’Italia. A lungo contesa fra Chiesa di Roma, Costantinopoli e i Longobardi, le vicende di Ravenna furono sempre al centro di scontri di “geopolitica spirituale”, fattore spiegabile simbolicamente con la custodia di un retaggio graalico.
Lo stesso “corridoio bizantino” che collega Roma con Ravenna si spiegherebbe nella sua importanza con la pretesa romana di custodire un Graal che invece la corte di Costantinopoli e gli stessi Imperatori germanici volevano rimanesse a Ravenna. Così potrebbe spiegarsi anche la tradizionale indipendenza dei Vescovi di Ravenna sia rispetto al Papa di Roma che all’Imperatore orientale a partire da Galla Placidia e da Giustiniano, come fossero i primi custodi del Graal, in questa logica simbolica.
La vicenda di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, immortalata da Dante nel canto quinto dell’Inferno, va riletta in senso rituale-arturiano-graalico, in quanto Galeotto è un cavaliere della Tavola Rotonda e la caduta carnale di Paolo rappresenta un fallimento nel rito iniziatico della prova d’amore cortese che è uno dei passaggi rituali che anche Perceval sperimenta, vincendo, nella veglia notturna amorosa con Biancofiore nel primo romanzo graalico, quello di Chretien de Troyes. Come Galeotto fu istruttore di Lancillotto in questa prova, così Paolo riveste un ruolo simile a Lancillotto e Francesca un ruolo di “dama graalica”.
Ricordiamo che i romanzi graalici-arturiani vanno colti anche nella loro essenza di romanzi “della crisi della cavalleria” in quanto il loro tema centrale è dato dal languore-malattia del “Re del Graal” o “re magagnato” la cui colpa in relazione al Graal è allusa come colpa di caduta carnale. La vicenda tra Paolo e Francesca quindi va reinterpretata quale tentativo di ricostruire una “cavalleria graalica” tramite l’alleanza di due famiglie entrambe di origine germanica. Lo stemma dei Da Polenta dopotutto essendo un’aquila rosso fuoco richiama archetipalmente la Fenice, emblema graalico secondo il Parziwal.
La “Cerca” è difficile proprio perché occorre risalire la corrente del tempo decrittando genealogie, contesti storici, araldiche e sottili intrecci. Ci vuole pazienza, umiltà, tempo, attenzione. E qualche segnaletica quale filo di Arianna! Certamente i Malatesta restano in ogni caso tra le antiche famiglie italiche più affascinanti, riservate e misteriose come origine e carismi.









![Emblema: OCVLVS NON VIDIT, NEC AVRIS AVDIVIT. (“Nessun occhio ha visto e nessun orecchio ha udito [ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano]”; 1 Cor 2,9). Da: “Amoris Divini Emblemata Studio Et Aere Othonis Vaenii Concinnata”, Anversa, Officina Plantiniana (Balthasar Moretus), 1660](http://media.meer.com/attachments/3678a1b5ee9bbae40ba10f366bb599cc8ceeb4f0/store/fill/330/186/9cce82b450624bd0e0458251067bc048c0af9db7f35a91ad7176f7df63d9/Emblema-OCVLVS-NON-VIDIT-NEC-AVRIS-AVDIVIT-Nessun-occhio-ha-visto-e-nessun-orecchio-ha-udito-cio.jpg)