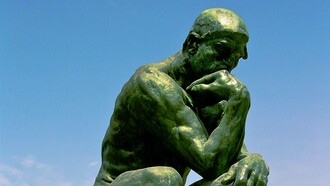Manfred Eigen ha vinto il premio Nobel per la chimica nel 1967 “per i suoi studi sulle reazioni chimiche estremamente veloci”. Nel 1975 scrive insieme a Ruthild Winkler il libro Il gioco, tradotto in italiano da Adelphi nel 1986, il cui sottotitolo è Le leggi naturali governano il caso. Il lettore che si aspetta un libro sulle leggi della probabilità rimarrebbe deluso, perché il punto di vista degli autori è tutt’altro. Nella prefazione affermano:
Nel mondo in cui viviamo ogni evento assomiglia a un grande gioco del quale all'inizio sono fissate solo le regole. Soltanto queste sono accessibili a una conoscenza obiettiva. Il gioco stesso non è identificabile né con l'insieme delle sue regole né con la catena dei casi che danno forma al suo specifico sviluppo. Non è né l'uno né l'altro, perché è contemporaneamente tutti e due, e ha infiniti aspetti: tanti, per la precisione, quanti sono gli interrogativi che gli si pongono.
Noi consideriamo il gioco come quel fenomeno naturale che, nella sua dicotomia di caso e necessità, è alla base di ogni evento.
Si tratta di un programma decisamente impegnativo: assumere il gioco, con l’unità indissolubile di regole e caso, come matrice interpretativa dei multiformi aspetti della realtà, dal mondo naturale alla creazione estetica. In qualsiasi gioco in cui caso e regole siano ben amalgamati, il caso genera continuamente nuove possibilità, mentre alle regole spetta il compito di assorbire le novità e di canalizzarle entro un quadro di coerenza formale. Lasciamo da parte la domanda su chi siano i giocatori. Possiamo considerarli entità astratte dotate della capacità di utilizzare le regole disponibili per trarre il massimo vantaggio dal caso (o per minimizzarne il danno).
Gli autori illustrano i principi del mondo vivente attraverso semplici giochi che prevedono un foglio quadrettato, un insieme di gettoni colorati e dadi di vario tipo. È stupefacente verificare come, variando l’insieme di regole suggerite, essi siano in grado di assorbire il caso e di instradarlo verso la generazione di forme complesse. I cristalli di neve sono un ottimo esempio della varietà e complessità di forme generate dal concomitante intervento di regole e caso. Durante il processo di cristallizzazione, le forze attrattive agiscono sulle molecole dando origine alla forma finale.
Un fiocco di neve è costituito da un miliardo di miliardi di molecole d’acqua, ognuna con un proprio orientamento spaziale. È sufficiente una variazione nell’orientamento di una piccolissima percentuale di molecole, ed ecco che il processo di formazione del cristallo prende una via diversa.
Tra i tanti giochi suggeriti, quello che qui ci interessa è il gioco dell’iperciclo, che spiega la formazione di strutture complesse. Eigen e Winkler spiegano il gioco nel modo seguente. Dovete disporre di quattro gettoni di diverso colore, che qui chiameremo A, B, C e D. Ogni gettone rappresenta un ciclo semplice, capace di riprodursi autonomamente. Un esempio è costituito da cicli in cui gli elementi seguono una logica di complementarità: l’elemento A+ (ad esempio, un acido nucleico) catalizza la formazione dell’elemento complementare A-, che a sua volta catalizza la formazione di A+. Si genera così il processo ciclico A, che si autosostiene nel tempo.
La popolazione iniziale sulla scacchiera è composta da una distribuzione casuale di gettoni di vario colore. Ora introduciamo una nuova regola. Dobbiamo immaginare che A+, mentre induce la formazione di A-, rilasci nell’ambiente un residuo (ad esempio, una molecola) che accelera la formazione del ciclo B. Analogamente, B accelera la formazione di C e C quella di D. Fin qui il processo è lineare, ma se D accelera la formazione di A, si forma un ciclo di cicli, cioè un iperciclo: A → B → C → D → A → … Ecco le regole del gioco (p. 206 del libro di Eigen e Winkler):
Usiamo una scacchiera di 8 per 8 caselle con l'indicazione delle coordinate e i rispettivi dati ottaedrici. Si richiede una riserva sufficientemente grande di pedine dei quattro diversi colori. All'inizio del gioco si collocano sulla scacchiera 16 pedine per ogni colore, e così tutte le caselle risultano occupate. Si lanciano poi i dadi per decidere in modo alternato l'eliminazione e il raddoppio. Al primo tiro si allontana la pedina che si trova nella casella sorteggiata, poi si tira ancora. La pedina sorteggiata questa volta può essere raddoppiata solo se in una delle caselle del vicinato ortogonale si trova una pedina che ha un colore “precedente nello spettro” secondo il seguente schema: il rosso A “precede” il giallo B, il giallo B “precede” il verde C, il verde C “precede” il blu D e infine il blu D “precede” il rosso A. La nuova pedina avrà lo stesso colore della pedina sorteggiata e andrà nella casella che si era liberata nel tiro precedente. I due tiri vengono sempre ripetuti in modo alternato.
Il semplice modello di Eigen è un colpo di genio. Spiega l’evoluzione delle molecole complesse, che diventeranno i mattoni fondamentali delle forme viventi, quando ancora non sono in funzione i meccanismi di variazione e selezione del modello evoluzionistico. Non vi è alcun limite nella formazione di ipercicli. Più ipercicli possono diventare i mattoni di ipercicli di complessità superiore. Inoltre, un iperciclo complesso può contenere al proprio interno una pluralità di ipercicli intrecciati tra loro.
Infine, la teoria dell’iperciclo mette in luce una differenza fondamentale tra le finalità della macchina iperciclica della vita e quelle delle macchine artificiali progettate dall’uomo. Mentre queste ultime sono solo un mezzo per produrre qualcosa (un prodotto, un servizio) da immettere nell’ambiente, la macchina dell’iperciclo è interessata solo a riprodurre sé stessa, utilizzando le risorse ambientali. Non è una differenza di poco conto, perché l’ottica dell’iperciclo cambia in modo sostanziale la nostra visione del mondo.
Pensate a un’organizzazione d’impresa. Nei manuali universitari di progettazione organizzativa si insegna che l’organizzazione è un sistema socio-tecnico finalizzato a produrre qualcosa che ha valore per un destinatario esterno. E se invece l’organizzazione venisse pensata come un iperciclo che deve sostenere sé stesso, e quello che noi consideriamo destinatario fosse solo un anello di un iperciclo più ampio? Anche i lavoratori assumono un altro ruolo.
Non sono più risorse da vincolare alle necessità di un processo di trasformazione lineare, ma anelli di un iperciclo, che rinnovano continuamente sé stessi come esseri umani e come lavoratori mediante la partecipazione a una varietà di ipercicli.
Vale la pena ricordare che, come ogni modello, anche quello dell’iperciclo ha sollevato interrogativi nella letteratura scientifica. I critici ne hanno evidenziato i limiti in termini di stabilità, vulnerabilità ai replicatori parassiti e difficoltà sperimentali. Tuttavia, al di là della sua applicazione alla genesi della vita, ciò che interessa qui è il valore formale e concettuale del modello: l’iperciclo ci offre una grammatica per pensare sistemi complessi in cui elementi cooperano, si riproducono e si sostengono reciprocamente. Un paradigma circolare, ricorsivo, capace di suggerire configurazioni alternative rispetto alla linearità causale e funzionale che domina molti nostri schemi interpretativi.
Pensare per ipercicli non significa solo comprendere i processi di auto-organizzazione dei sistemi viventi, ma anche adottare un criterio etico per progettare i nostri sistemi sociali, economici e produttivi. In un mondo segnato da crisi ecologiche e rotture sistemiche, l’iperciclo suggerisce che la sopravvivenza non dipende dalla massimizzazione dell’efficienza o del profitto, ma dalla capacità di ogni sistema di rigenerarsi in equilibrio con ciò che lo circonda. È una logica della coesistenza, non dell’estrazione; della continuità, non dell’espansione. Forse è da qui che può iniziare una nuova forma di responsabilità.
A partire da questa prospettiva, l’iperciclo può essere esplorato anche come principio operativo per il design di sistemi complessi, ambienti di apprendimento, strutture organizzative e pratiche di governance adattiva. Il suo valore non risiede solo nella spiegazione di fenomeni biologici primitivi, ma nella capacità di offrire una grammatica ricorsiva per pensare reti cooperative, relazioni interdipendenti e processi di rigenerazione. In questo senso, l’iperciclo può dialogare con altri modelli sistemici – come l’autopoiesi di Maturana e Varela, le ecologie mentali di Bateson o le dinamiche di feedback nei sistemi adattivi complessi – diventando un riferimento utile non solo per la descrizione, ma anche per l’azione trasformativa.