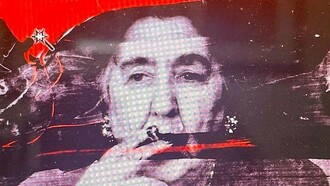Se dovessi scegliere una lettura dalla forza magnetica che ha caratterizzato il primo Novecento la mia scelta non porrebbe dubbi. Nel cuore pulsante della poesia russa, due figure femminili si stagliano con un incredibile fascino ancora oggi intatto: Anna Achmatova (1889–1966) e Marina Cvetaeva (1892–1941). Diverse per stile, temperamento e destino, ma accomunate da un’urgenza espressiva che seppe attraversare guerre, rivoluzioni e tragedie personali, le due poetesse rappresentano il vertice di una stagione lirica irripetibile, in cui la parola poetica si caricava di verità esistenziale e responsabilità storica.
Anna Achmatova, raffinata e dolente, fu la voce della resistenza interiore nel tempo della repressione staliniana. Cresciuta a Tsarskoe Selo, l’antica residenza imperiale, si legò al movimento Acmeista, rivendicando una poesia concreta e nitida, lontana dalle nebbie simboliste. La sua figura divenne presto leggendaria perché le sue liriche amorose si trasformarono in testi civili, in “testimonianze” del dolore collettivo, come accade nell’indimenticabile Requiem, scritto in segreto durante il Terrore sovietico.
Marina Cvetaeva, invece, fu una creatura di fuoco e abisso. Spirito irrequieto e nomade, visse tra Russia, Praga, Berlino e Parigi, sempre in lotta con la povertà e con se stessa. La sua poesia arriva ai lettori in maniera viscerale e appare immediatamente visionaria e pregna di urgenza. Risente dell’influenza del simbolismo, ma lo trascende per profonda emotività e originalità formale.
Tragicamente segnata dal suicidio della figlia e da un’esistenza in esilio, Cvetaeva rientrò in URSS nel 1939, solo per ritrovarsi braccata dal sospetto e dalla miseria. Nel 1941, durante l’evacuazione causata dall’invasione nazista, si tolse la vita. Achmatova e Cvetaeva hanno avuto due destini simili seppur differenti e con sofferenza sono rimaste nella storia come stelle fisse nel cielo della letteratura mondiale.
Per iniziare a conoscere Anna Achmatova e Marina Cvetaeva, possiamo partire da alcune poesie molto rappresentative, in grado di offrire una sintesi affidabile della loro voce poetica, dei temi centrali e del contesto in cui scrissero.
Per quanto riguarda Anna Achmatova Canzone della ultima riunione (1911) è una poesia giovanile ma già matura, in cui l'amore perduto è descritto con sobrietà e precisione emotiva. Qui lo stile acmeista è presente in maniera nitida, diretta, sensuale ma controllato.
La Musa (1924) riflette invece sul rapporto con l’ispirazione poetica, personificata in una figura misteriosa che si presenta anche nei momenti più tragici. Si tratta di una meditazione sulla poesia come vocazione e destino. Una pubblicazione postuma fondamentale è invece Requiem (1935–1940), opera che ci spiega la tragedia collettiva russa attraverso una risposta coraggiosa alle purghe staliniane attraverso il racconto in forma lirica del dolore delle madri, delle mogli, dei prigionieri.
L’ultima rosa (1961) è una delle poesie della vecchiaia, segnata dalla nostalgia e dalla consapevolezza del tempo. Quest’opera è importante perché ci fa scoprire la voce sobria e disincantata della poetessa, voce ancora intensamente viva.
Per quanto riguarda Marina Cvetaeva il nostro viaggio nel suo mondo può cominciare con Mia poesia (1913), autoritratto lirico e manifesto della sua poetica. Qui la scrittrice rivela la sua voce potente, passionale, capace di una musicalità unica. Il testo afferma la centralità della parola come rivelazione e destino.
In Poema della Montagna (1916) è la complessità dell’intreccio a prevalere, l’intensità, la visione e lo slancio introducono una tensione unica verso l’assoluto e colpisce quella che potremmo definire una verticalità spirituale.
Versi a Blok (1921) è una dedica al poeta simbolista russo Aleksandr Blok, dichiarazione d’amore poetico e dialogo appassionato circa la sua eredità culturale. Il testo è ardente e vibrante, la lettura imperdibile.
La mia madre e la mia musica (1935) ci parla di famiglia, memoria e arte, laddove il legame tra vita vissuta e forma poetica diventa profondo, impossibile da spezzare.
Poema della fine (1924) alterna versi lirici e dialogati con una struttura drammatica. Questo testo è accessibile e perfetto se vogliamo conoscere questa gigantesca figura culturale che ha segnato la letteratura del primo Novecento.
Per rendere la lettura ancora più gradevole consigliamo le traduzioni a cura di Serena Vitale per la Cvetaeva e Renata Pisentini o Luciano Canfora per la Achmatova. Chi ha la possibilità e ha studiato la lingua russa può affiancare alle traduzioni il testo russo originale per lasciare intatta e cogliere in pieno la musicalità.
Perché dovremmo leggerle oggi, nei nostri tempi in cui la cultura è così bistrattata?
Entrambe le poetesse hanno scritto in un secolo dominato da repressioni politiche, guerre mondiali, esilio, fame, censura. Eppure non hanno mai piegato la loro arte, la loro parola poetica al potere o al silenzio forzato. Achmatova è rimasta in Russia durante il Terrore staliniano per testimoniare ciò che avveniva, anche a costo di non pubblicare. Cvetaeva ha scritto versi infuocati sull’amore e sulla perdita, ma anche sulla patria, pur trovandosi in esilio, anche nella disperazione. La nostra epoca è segnata da diverse e nuove forme di censura, l’informazione è manipolata, viviamo pericolose crisi di identità e la loro fedeltà all’arte è un esempio nitido di resistenza, o, come è di moda dire oggi, di resilienza.
Achmatova e Cvetaeva, quindi, non scrivono solo di Russia o di poesia, più in generale non è sbagliato affermare che indagano l’essere umano, andando a toccare punti cruciali come le ferite lancinanti, le passioni più sentite, gli abissi più profondi. Achmatova, a mio parere, riesce a dire l’indicibile, soprattutto quando ci racconta il suo senso della perdita, l’attesa asfissiante o l’importanza della memoria.
E il tutto in pochi eleganti versi. La Cvetaeva trasforma il tumulto interiore in ritmo e senza mai doversi scusare per l’intensità. Chi siamo, cosa sopportiamo nella nostra quotidianità, come affrontare le sconfitte e i desideri che non si avverano, ma anche quelli che realizziamo, ecco cosa possiamo imparare leggendo le loro poesie, per avere l’impressione chiara che a prescindere dal contesto storico queste verità varranno per sempre.
Anche sul piano formale, Achmatova e Cvetaeva si pongono su due poli opposti ma complementari.
Anna Achmatova è maestra della chiarezza, della sobrietà e della precisione. La sua poesia, influenzata dal simbolismo, ma sempre ancorata al reale, è fatta di versi brevi, taglienti, spesso narrativi, sempre limpidi. Usa metafore essenziali, musicalità trattenuta, immagini domestiche o storiche che vibrano di emozione contenuta. È la poetessa dell’ellissi, dell’allusione, della parola giusta al posto giusto. Dietro l’apparente semplicità, ogni verso è cesellato come in una miniatura. Marina Cvetaeva, al contrario, scrive come in preda a un incendio. Il suo stile è esplosivo e sperimentale. Usa versi spezzati, ritmi irregolari, enjambement vertiginosi, giochi fonici, assonanze, neologismi, inversioni sintattiche.
La sua lingua è un flusso continuo, con salti logici e lirici che sfidano il lettore.
Scrive con tutto il corpo, con una musicalità quasi sciamanica. A volte la sua voce sembra cantare, altre urlare, altre ancora sussurrare in un’altra dimensione. Achmatova è il ferro lucidato, Cvetaeva è il fuoco che forgia. Insieme, sono la dimostrazione che la poesia russa femminile del Novecento ha saputo spaziare dalla geometria alla vertigine.
In un ambiente letterario e politico dominato dagli uomini, Achmatova e Cvetaeva non cercarono di imitare i modelli maschili, ma si affermarono con la forza, il talento e la singolarità. Non pretendevano un posto nella storia, lo conquistarono con il sacrificio della scrittura. Achmatova fu censurata, ma sopravvisse all’oblio imposto. Cvetaeva fu marginalizzata, accusata di egocentrismo e incompresa, eppure ha lasciato una voce inconfondibile e inimitabile. Questo è l’insegnamento più grande per noi che proviamo a scoprirle oggi.
Un insegnamento per chi ha intenzione di scrivere, per chi cura la passione per la letteratura e la creazione sedendosi ogni giorno solitario per diverse ore in una scrivania a inventare il proprio percorso, la propria storia.
A prescindere dalle possibilità di pubblicare, dalle logiche di mercato, dalle bizze editoriali degli addetti ai lavori. Inoltre, anche nei nostri tempi in cui si fa fatica a riconoscere pienamente l'autonomia femminile, le due poetesse russe rimangono esempi radicali di libertà e creazione. Leggerle oggi è un esercizio di bellezza, di amore e immersione nella lingua, di comprensione della forza evocativa che ha la parola così maltrattata quando si presenta nuda e viva.
La poesia ci aiuta a trovare la bussola quando siamo in crisi, ci consola, ci chiarisce quando dentro di noi è buio, il silenzio non è vuoto, l’amore è una ferita che parla, la memoria è resistenza. Achmatova e Cvetaeva sono i nostri fari, sono degli specchi, sono delle sopravvissute. E ci insegnano come diventarlo. Quanto vale questo per chi vuole diventare uno scrittore? Per chi sente il sacro fuoco ardere dentro?
È una lezione cruciale che le poetesse ci danno. Chi oggi scrive - poesia, narrativa, o semplicemente parole - lo deve fare utilizzando parole vere. Scrivere, per loro, non era un lusso né un hobby, ma un’urgenza. Un dovere interiore. Una forma di testimonianza. Lo facevano in un tempo in cui pubblicare era quasi impossibile. Come detto Achmatova venne silenziata dal regime, espulsa dall’unione degli scrittori e per anni non poté pubblicare nulla. Cvetaeva visse l’esilio, la povertà estrema, il disprezzo dei critici e l’isolamento più feroce.
Eppure scrivevano. Che grande verità! Che parole meravigliose! Musica per le orecchie di chi vive la passione vera. Eppure scrivevano. Eccome. Anche se nessuno avrebbe letto. Anche se rischiavano tutto.
Sicuramente nel mondo, visti i tanti conflitti aperti, visti i tanti regimi che limitano la libertà dell’individuo, ci sono scrittori, intellettuali e letterati che si vedono colpiti in quella che possiamo considerare una delle libertà più importanti per l’essere umano, quella di espressione. E rischiano la vita per poterla difendere. E per loro le poetesse russe sono sicuramente un esempio. Ma pensiamo più in piccolo, pensiamo a noi che viviamo nell’agio e abbiamo la pretesa di essere pubblicati, con supponenza pensiamo che il mondo dell’editoria sia corrotto, che per essere riconosciuti bisogna seguire logiche che riguardano nepotismo e favoritismi. Quanto di più lontano possiamo trovare rispetto alla passione che deve ardere? Perché la passione deve ardere a prescindere.
Achmatova e Cvetaeva non cercavano consensi, editori, algoritmi, cercavano verità. La parola, per loro, era l’ultima difesa contro la disumanizzazione.
Non siamo sotto il terrore staliniano, questo è poco ma sicuro. Ma oggi viviamo un altro tipo di silenzio, quello dell’indifferenza. E, sì, l’industria editoriale è chiusa, i like sostituiscono la lettura, la sensazione che scrivere non serva a niente è reale, in molti cullano il sogno dello scrittore ma in pochi si appassionano ai libri. E questa realtà in Italia è ancora più terribile. Eppure, proprio in tal direzione, Achmatova e Cvetaeva sono modelli radicali, perché ci mostrano che scrivere ha senso anche quando il mondo dice il contrario.
Che la parola può resistere alla marginalità, all’esilio, al disinteresse. Che la poesia non ha bisogno di permessi per esistere. Leggerle, oggi, significa soprattutto questo: ricordare che scrivere è un atto di libertà. E che, a volte, chi scrive parla prima per chi verrà dopo.
Se vogliamo intraprendere questo viaggio e conoscere queste due eroine della letteratura potremmo scoprire una passione in grado di accenderci. E per questo sarebbe interessante capire come continuare questo viaggio anche dopo aver conosciuto la Achmatova e la Cvetaeva. Potremmo quindi addentrarci nella poesia italiana seguendo i fili di quattro poetesse che, in modi diversi, raccolgono e trasformano una tensione interiore molto simile.
Per esempio Antonia Pozzi è una lettura da scoprire assolutamente, con i suoi versi scritti tra le montagne e l’ombra della morte, parla con una voce pudica e limpida che però scava a fondo nel dolore e nella solitudine. La sua poesia è un diario dell’anima che non riesce a trovare pace nel mondo.
Amelia Rosselli, più tormentata e intellettuale, frantuma la lingua come Cvetaeva frantumava il verso, facendo della lacerazione personale e storica una forma espressiva. La sua poesia è un grido stilizzato, insieme furia e geometria.
Patrizia Cavalli, più vicina a noi nel tempo, rovescia il registro, la sua apparente leggerezza è solo l’altra faccia della vertigine. La quotidianità, nei suoi versi, diventa specchio della vulnerabilità, del desiderio e della perdita.
Mariangela Gualtieri, infine, porta la poesia verso un’apertura spirituale, quasi sacra, la sua parola cerca l’origine, il canto primitivo, l’ascolto profondo della vita e della natura. In ognuna di loro, come in Achmatova e Cvetaeva, la poesia è necessità e non un ornamento, è solo e semplice sopravvivenza.