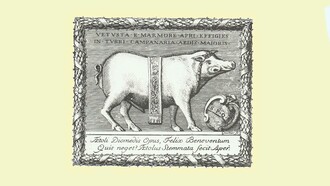Questo brano si sarebbe potuto intitolare “L’amore, la morte e Beethoven” perché in realtà sono questi i tre fili conduttori del racconto. Un racconto che riprende il titolo di una famosa sonata di Beethoven e che, attraverso la parola, ne vuol riecheggiare i timbri e i toni alti. Un racconto che, apparentemente, di musica non tratta, ma è lei la vera protagonista, “la causa di tutto”.
“Sono Pozdinysev… ho ucciso mia moglie”: così si rivolge il viaggiatore del treno ai suoi interlocutori, così ha inizio la lunga confessione dell’uomo, il suo monologo, il suo personalissimo dramma.
La sonata a Kreutzer1 (1855) apre (e chiude) la sua storia in un treno dove un gruppo di persone -tra cui il narratore- chiacchiera animatamente circa l’amore, la passione, il matrimonio. Dalla discussione emerge chiaramente quanto sia difficile definire l’amore. L’amore che cos’è? “[…] è la preferenza esclusiva accordata a un uomo o a una donna rispetto a tutti gli altri” vi si legge. Ma questa preferenza quanto dura? Ė raro, sostiene Pozdnysev (il protagonista assoluto della storia) che duri per tutta la vita. La disillusione e lo sconforto lo portano a considerare l’amore eterno come inesistente, come qualcosa che “capita solo nei romanzi, mai nella vita”.
L’infelice esperienza personale di un matrimonio senza amore, senza complicità, senza affetto alcuno lo conduce a una serie di riflessioni pessimistiche che egli estende all’umanità tutta, in quanto ritiene che la propria vicenda non sia un unicum, ma il paradigma dell’esistenza di ogni uomo. Un’esistenza infelice quella di ognuno di noi perché fondata, sotto tutti i punti di vista, sul diritto di proprietà.
Anche l’amore che dovrebbe essere un continuo uscire da sé, un continuo completarsi e sacrificarsi (un sacrificio piacevole), obbedisce alle regole della schiavitù: di volta in volta, l’uomo e la donna si scambiano i ruoli di servo e padrone. La donna, relegata al ruolo di oggetto, viene “acquistata” e a ciò è educata sin dall’infanzia, si vendica utilizzando la propria potenza erotica e asservendo l’uomo.
Il protagonista sostiene, infatti, che la donna seduce e fa innamorare in virtù del suo aspetto, del suo vestito e dei suoi ornamenti. Da nubile cura il proprio fisico per conquistare, da sposata continua a farlo per mantenere vivo il matrimonio. I legami fra un uomo e una donna, aggiunge Pozdnysev, si basano sull’attrazione fisica e la sensualità che da essa scaturisce è avvicinabile all’istinto animale. Ė qualcosa di molto brutale, come tale viene riconosciuta, ma è comunque imprescindibile ed essenziale.
La sessualità viene vista (e vissuta) dal protagonista come un medicinale da somministrare regolarmente, come un rito da perpetuarsi per la salvaguardia della salute fisica dell’uomo (dell’uomo, si badi bene, non della donna).
Una sessualità che rimane viva nonostante le liti, i rancori, gli sgarbi perché è puro istinto da soddisfare. Non è fonte di complicità intellettuale, agisce solo a livello fisico, come tale si libera e va consumata, voracemente, brutalmente, anche fra sconosciuti (lo si può notare ne La sonata a Kreutzer, ma soprattutto ne Il diavolo).
L’intensità dell’atto sessuale non misura quella affettiva, è sconvolgimento dei sensi che momentaneamente nasconde le insoddisfazioni di una coppia, ma una volta conclusasi, li fa riemergere più forti, più potenti, più ossessivi di prima. La vita coniugale si rivela ben presto un’altalena logorante di sentimenti, un odi et amo che ottenebra la ragione, che svilisce la natura umana.
Perché, si chiede Pozdnysev, tra marito e moglie si litiga continuamente per poi buttarsi nei baci, nelle carezze? È abominevole, è assurdo costringerla all’amore anche quando sta male, quando aspetta un figlio solamente perché è una funzione necessaria dell’uomo. Fare ciò significa privare la donna della sua dignità, negarle qualsiasi possibilità di scelta, ammazzarla e:
Pensavano che io l’avessi uccisa quella volta, col coltello, il cinque ottobre. Non è stato allora che la uccisi, ma molto prima. Precisamente allo stesso modo che tutti loro la stanno uccidendo ora; tutti, tutti.2
L’omicidio della propria moglie si è perpetuato negli anni attraverso liti, incomprensioni, mancanza di affetto, di rispetto, di disattenzioni, di considerazione. È stata uccisa giorno per giorno, lentamente, lentamente. Ella veniva considerata dal marito un oggetto da prendere, da lasciare, da dimenticare; come oggetto era costretta a subire tutto quanto fosse stato di gradimento al proprio uomo.
Passiva e in silenzio aveva sopportato fino a quando… Fino a quando la musica (e un musicista) entrarono nella sua casa.
Ecco, proprio lui con la sua musica è stato la causa di tutto.3
Ai figli, unica attenzione e fonte al contempo di sofferenza e conforto per la donna, si sostituì, a poco a poco, l’interesse per la musica e per quel musicista dai “languidi occhi a mandorla”, dalle “belle labbra sorridenti”, dal “viso di una bellezza volgare”: unici piaceri di una vita matrimoniale triste e tormentata.
Egli suonava e al massimo grado aveva quello che si dice stile… Mia moglie sembrava interessata solamente alla musica ed era molto semplice e naturale. Io invece, anche se fingevo un grande interesse per la musica, fui incessantemente tormentato per tutta la sera dalla gelosia.4
E ancora:
[…] per l’influenza che sulle nature sensibili esercita la musica (e il violino in particolare), non solo era destinato a piacerle, ma senza dubbio, senza il minimo indugio, l’avrebbe conquistata, piegata, rigirata, l’avrebbe ridotta in suo potere e avrebbe fatto di lei ciò che avesse voluto.5
Il marito è, ora, spettatore di una scena che mai avrebbe immaginato. Sua moglie è radiosa, felice, è bella come forse non lo era mai stata. È guardata, desiderata da altri uomini e in particolare dal musicista con cui si è instaurata una confidenza che solo la musica può dare poiché arte che si esercita in due.
La gelosia dell’uomo nasce nel momento in cui questa confidenza sboccia, per poi divenire ossessione, solo per il motivo che un altro uomo possa possedere il corpo della moglie facendo tutto quello che lui ha sempre fatto: conquistarla, piegarla, rigirarla, ridurla in suo potere e fare “di lei ciò che avesse voluto”.
Il musicista è, nel pensiero di Pozdnysev, il suo alter ego e come tale ritenuto in grado di assoggettare la moglie, di poterla muovere, piegare, spostare come una cosa, sicura che ella (come ha sempre fatto con lui) non vi si opponga. Ma anche un uomo qualunque che fosse giunto lì portando la “novità” e spezzando la routine di un matrimonio stanco e logoro sarebbe stato in grado di ammaliare la donna o è stata stregata dalla musica?
Cos’è la musica [-si chiede Pozdnysev-] e perché fa l’effetto che fa? Dicono che la musica costituisca una forma di elevazione dell’anima: è assurdo, falso! Agisce, agisce terribilmente: lo dico per quanto mi riguarda, ma non certo come elevazione dell’anima! Agisce non come forma di elevazione o di svilimento, ma come forma di eccitazione dell’anima. Come dirvi? La musica mi costringe a dimenticare me stesso, la mia situazione reale, mi trasporta in un’altra situazione che non è la mia: sotto l’effetto della musica mi sembra di sentire ciò che propriamente non sento, di comprendere ciò che non comprendo, mi sembra di potere ciò che non posso.6
La musica agisce nel protagonista come un ipnotizzatore che fa emergere sensazioni ed emozioni nuove rendendolo onnipotente: è in grado di sentire, comprendere, fare tutto come se fosse un altro se stesso a guidarlo nel viaggio delle note.
Su di me, almeno, questa cosa -la musica- ha agito in modo terribile; è stato come se in me si aprissero dei sentimenti e delle possibilità, così mi sembrava, del tutto nuovi che fino a quel momento mi erano sconosciuti.7
La musica è una droga che trasporta l’uomo in una situazione non reale costringendolo a dimenticare se stesso per entrare, invece, in simbiosi con l’autore di quella determinata musica.
Quella, la musica, mi trasporta subito direttamente nella condizione interiore in cui si trovava colui che l’ha scritta. Mi fondo interiormente con lui, mi trasporto da una condizione all’altra, ma perché lo faccio non lo so.8
In uno stato di totale incoscienza, l’uomo è ubriacato dal suono di quelle magiche note; lui è lì, seduto ad osservare la moglie e il musicista che eseguono La sonata a Kreutzer, ma è come se corpo e anima fossero disgiunti: essa si libra, è eccitata, entra in comunione con l’autore, Beethoven. Egli è stato in grado di risvegliare nell’uomo brividi e turbamenti fino ad allora ignoti; la sua musica lo ha inebriato a tal punto da non renderlo padrone di sé, non è lui che pensa, non è lui che agisce.
La musica lo trasporta in una nuova dimensione, in una nuvola di pura eccitazione dove c’è spazio unicamente per l’esaltazione, per l’affermarsi della non-ragione, per il potere, per la libertà. Un potere e una libertà che lo fanno sentire felice ([…] la coscienza di questa nuova condizione mi rendeva molto felice 9), ma che durano il tempo di una sonata.
La sonata a Kreutzer e il presto, in particolare, sono stati un potente eccitante, una carica di adrenalina che ha celato sentimenti preesistenti per farne affiorare di sconosciuti. Ha dato all’uomo inaspettate emozioni e un nuovo, forte benessere tanto che:
per la prima volta con sincero piacere gli strinsi la mano e lo ringraziai di aver suonato. Allo stesso modo egli salutò definitivamente anche mia moglie e il loro congedo mi parve perfettamente naturale e sobrio. Era tutto perfetto. Sia io che mia moglie eravamo molto soddisfatti della serata.10
Ma ecco che, improvvisamente, a causa di una partenza di Pozdnysev e di una lettera di sua moglie in cui si diceva che Truchacevskij il musicista era passato a prendere gli spartiti, il demone della gelosia si insidiò prepotentemente in lui consumandogli a poco a poco la ragione. La gelosia è una “bestia rabbiosa” (La bestia rabbiosa della mia gelosia emise un ruggito dalla sua tana e stava per saltar fuori, ma io, che temevo quella belva, lo rinchiusi velocemente11) che morde voracemente l’animo oscurando il senno per rendere l’uomo simile ad un animale ferocissimo che, uscendo prepotente dalla sua tana, afferma il predominio del territorio sugli altri.
La gelosia è un tarlo che rode ossessivamente, cui non si vorrebbe dare ascolto, ma è più forte della volontà, di tutto perché è in ogni angolo della mente, in ogni pensiero. Pozdnysev è in balia di un’ardente gelosia: ripensa alla sera in cui i due avevano eseguito La sonata a Kreutzer certo che tra loro fosse nato qualcosa di più di una semplice comunione di interessi, qualcosa di oltraggioso poiché “tra loro c’era il vincolo della musica, della più raffinata lascivia sensuale”.12
Ciò che fa più male al protagonista è rimanere nel dubbio: sarà vero o meno quanto ha supposto? Il non poter arrivare alla verità, congiunto a una folle gelosia sono veleno per l’uomo, sono fonte di un tormento malato che lo conducono a un vero e proprio stato schizofrenico: egli è sdoppiato, da una parte c’è l’amore, dall’altro l’odio per la moglie:
La sofferenza maggiore era nell’incertezza, nel dubbio, nello sdoppiamento, nel non sapere se avessi dovuto odiare o amare mia moglie.13
Credo però che la gelosia, così prepotente, acuta, feroce, abbia oscurato anche i sentimenti più sinceri che mai erano venuti a galla neppure alla sua coscienza. È solo in questo momento di follia che l’uomo non sa se amare la moglie. Egli, prima d’ora, non l’ha mai dichiarato, neppure a se stesso. In realtà il presunto amore nasce, come si è visto, dall’ossessione che un altro abbia usurpato il suo possesso, che possa usufruire di un qualcosa che è sempre stato suo: la proprietà è infranta. Il senso di impotenza, amore e rabbia scaturiscono dalla consapevolezza che si è persa una cosa, la più fedele delle cose, perché è stato un altro -più forte- a prenderla.
Non si accetta di aver perso… Ma, signor Pozdnysev, questa non è gelosia di un amore, ma di un oggetto. La gelosia, esplosa in tutta la sua furia e cattiveria, non poteva che culminare nel gesto più aberrante: l’assassinio di sua moglie, vissuto dal protagonista come una catarsi, come la fine delle sue “sofferenze”. Il senso di colpa non esiste e di conseguenza neanche il pentimento, e la vigliaccheria e l’egoismo sono talmente grandi da non consentire neanche il suicidio.
La vista della moglie gonfia e livida gli produce un senso di disgusto (“Non c’era più nessuna bellezza ed in lei vidi qualcosa di schifoso”14), ma poi:
Io guardai i bambini, il suo viso rovinato dai lividi e per la prima volta dimenticai me stesso, i miei diritti, il mio orgoglio, per la prima volta vidi in lei un essere umano. E mi parve così insignificante ciò che mi aveva ferito, tutta la mia gelosia e così fondamentale mi parve invece quello che avevo fatto io, che avrei voluto cadere col viso sulla mano e dirle «Perdonami». Ma non ebbi il coraggio.15
Tolstoj, raccontando l’uxoricidio attraverso la prospettiva dell’assassino, entra completamente nella sua psicologia, cogliendo tutte le sfaccettature di una mente pericolosa, ossessionata e di un’ossessione che si trasforma in truce follia. È mirabile il modo in cui lo scrittore ci consegna questa confessione dove viene resa benissimo l’oscillazione degli stati d’animo, senza mai cedere a momenti di commozione o di pietà verso la moglie uccisa.
Una confessione che è una vile giustificazione per ciò che ha fatto. L’assassino presenta agli ascoltatori sul treno la sua storia come un dramma, una sofferenza sua personale e non di chi ha ucciso, di chi ha voluto come vittima. Sul treno, che vedo come emblema di un viaggio nei meandri della mente, le parole di Pozdnysev si perdono e non sappiamo che sensazioni inducano in chi lo ascolta. Sono lui e le sue parole ad abitare quello spazio. E non sappiamo neppure quale sarà il suo destino dopo questa lucida e terrificante ammissione.
Dedico questo mio articolo, al di fuori di ogni retorica, a tutte le donne vittime di femminicidio, quelle note e quelle vittime anche di realtà sommerse.
Note
1 Kreutzer Rodolphe: violinista, compositore, direttore d’orchestra francese (1766-1831).
2 Lev Tolstoj, La sonata a Kreutzer, Edizioni Garzanti, Milano 1996, p. 36.
3 Lev Tolstoj, Op. cit.,p. 55.
4 Lev Tolstoj, Op. cit.,p. 61.
5 Lev Tolstoj,Op. cit., p. 62.
6 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 69.
7 Lev Tolstoj,Op. cit., p. 70.
8 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 69.
9 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 70.
10 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 71.
11 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 10.
12 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 72.
13 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 76.
14 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 88.
15 Lev Tolstoj, Op. cit., p. 88.