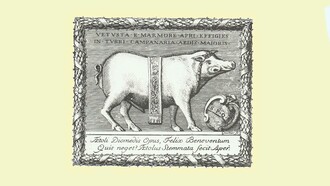Io vi dico che bisogna avere il caos dentro di sé per generare una stella danzante.
(Friedrich Nietzsche)
Non vi sono dubbi: la gente, almeno in Occidente, detesta gli insetti. Vengono associati a sporcizia e miseria e sono temuti perché si ritiene che possano essere veicolo di malattie, quando non incutono vero e proprio terrore per le dolorose punture che gli esemplari di alcune specie, in effetti, possono infliggere.
Solo pochi iniziati li amano.
Quando, da bambini, nelle scampagnate o nelle gite fuori porta ci si imbatteva in uno scarabeo o in una farfalla, come stregati si rimaneva immobili a guardare quelle piccole creature che sembravano appartenere a un altro mondo ma poi, dopo qualche secondo, quasi tutti fuggivano strillando e solo alcuni, pochissimi, sentivano l'incanto e avrebbero amato quei piccoli esseri per tutta la vita.
Forse l'unica eccezione a questa regola riguarda le lucciole perché anche se sono insetti tutti le amano.
Chiunque poi abbia avuto la fortuna di vederle nelle notti d'estate, soprattutto da bambino, non dimenticherà mai la magia di uno spettacolo naturale così coinvolgente. Ancora adesso, quando posso, nelle notti di tarda primavera o di inizio estate, inseguo il loro straordinario concerto di luce che compare prima in pianura poi lungo i pendii delle colline per finire, a luglio inoltrato, sulle montagne e sento ancora attorno a me danze di fate e di folletti o forse di antichi dei dimenticati che ballano al ritmo misterioso e ipnotico delle verdi luci fluttuanti nel nero giaietto delle notti senza luna.
Ma se, come diceva Leonardo, un grande amore può nascere solo dalla conoscenza di ciò che si ama, allora dobbiamo smettere un attimo di sognare e fermarci ad osservare, con uno sguardo più scientifico, questa straordinaria creatura senza che ciò la privi della sua malia.
La lucciola, nome scientifico Lampyris Noctiluca (Linnaeus 1767), è un insetto appartenente all'ordine dei Coleotteri e alla famiglia dei Lampyiridae. È diffusa, con le sue varie specie, in tutta l'Eurasia al di sotto del circolo polare. La specie più comune nelle nostre regioni è caratterizzata da uno spiccato dimorfismo sessuale: il maschio, colui che anima le notti estive, è in grado di volare; mentre la femmina, attera, può solo rimanere a terra emettendo però una luce verdolina fissa che può durare diverse ore, intanto che i maschi sfarfallando nelle zone più umide e scure della notte emettono lampi di luce.
Come si può facilmente intuire questa danza di luce ha uno scopo ben preciso: il richiamo sessuale. Le femmine, infatti, più rare, si posizionano in un'area sopraelevata rispetto al suolo e libera da erbe alte o altro che possa nasconderle ed emettono una luce continua cercando di attrarre così i maschi, molto più numerosi, che volano nei dintorni.
Il fenomeno stupefacente che caratterizza le lucciole, la loro capacità di emettere quella bellissima luce verde, è chiamato bioluminescenza ed è frequente soprattutto tra le creature marine, specialmente tra quelle che abitano la notte eterna delle profondità oceaniche. La luce viene prodotta grazie alla luciferina, una sostanza chimica che le lucciole accumulano in alcuni segmenti dell'addome e che in presenza di ossigeno e grazie ad un enzima chiamato luciferasi, si ossida generando quella caratteristica spettrale luce verde che è fredda perché l'energia liberata dalla reazione si manifesta totalmente in luce con pochissimo calore residuo, quindi con un'efficienza energetica vicinissima al 100% , meta agognata ma non ancora raggiunta persino dai nostri più avanzati sistemi di illuminazione.
Anche le lucciole, però, con la loro romantica magia, non sfuggono alla legge della macelleria universale che vuole che tutte le creature, anche le più leggiadre, vivano recando morte e rovina le une alle altre, come per un'oscura vendetta. Infatti, allo stadio larvale (che dura circa tre anni) sono spietate cacciatrici di lumache; le uccidono iniettando loro una sorta di veleno costituito da enzimi digestivi, che predigeriscono la vittima che poi viene successivamente risucchiata in tutto o nelle sue parti offese, e in questo caso viene poi lasciata andare malamente sconciata. Mentre gli adulti, che vivono solo poche settimane, non si nutrono affatto e muoiono dopo l'accoppiamento.
Proprio il loro stile di vita e le loro abitudini alimentari rendono le lucciole estremamente sensibili a pesticidi e lumachicidi di cui, nei decenni passati, si è fatto largo uso in agricoltura e in effetti, per molti anni, non se ne vedeva più nessuna ad allietare le sere estive nelle nostre campagne. Poi, miracolosamente, con il diffondersi di un'agricoltura sempre più "biologica" e sostenibile, con rigide limitazioni all'uso di insetticidi e altri veleni ambientali, sono lentamente ricomparse e ora sono tornate ad illuminare con il loro incantesimo le notti estive segno, che la natura, se non viene irrimediabilmente intossicata, ha straordinarie capacità di ripresa.
Piccole luci in basso nell'oscurità delle foreste della notte e piccole luci in alto, nel raso nero del cielo. Chissà che non stesse ammirando proprio questo spettacolo Ermes Trismegisto quando, come narra la leggenda, incise con punta di diamante su una lastra di smeraldo le parole: "Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per compiere i miracoli della cosa una" ponendo così con la sua Tabula Smaragdina le basi dell'Alchimia, la sapienza del mondo antico. Perché, forse, la pietra filosofale ovvero l'oro alchemico dei filosofi è nascosto nel mistero di una notte d' estate, dove chi sapesse davvero vedere con lo spirito ciò che vede con gli occhi potrebbe raggiungere la luce sfavillante delle galassie restando sdraiato nell'ombra, sotto i semplici rami di un frassino o di un carpino.