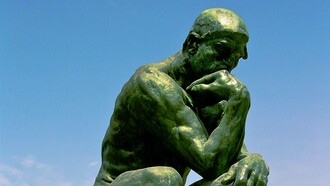Eleusi, città costiera della Grecia (Attica), affacciata sul Golfo Saronico (o Golfo di Egina), di fronte all’Isola di Salamina, a circa 20 km a Nord-Ovest di Atene, era famosa nell’antichità non soltanto per aver accolto la nascita del grande tragediografo Eschilo (525-455 circa a.C.), ma soprattutto per l’importante Santuario dedicato a Demétra (Δημήτηρ, la “Madre-Terra”, corrispondente a Ceres, la “Cerere” latina, dea dell’agricoltura), nonché per i culti misterici che vi si celebravano in onore della stessa dea e della figlia Persèfone (o Core, Κόρη, la Proserpina latina), attestati sino alla fine del IV secolo d.C., quando cessarono in seguito all’invasione dei Goti di Alarico, alla cui devastazione sono sopravvissuti purtroppo soltanto alcuni resti, attuali rovine del sito archeologico.
Tali riti religiosi e “segreti”, di antichissima origine pre-ellenica (Eleusi era area di culto già in epoca micenea intorno al XV secolo a.C.), erano collegati con i culti agrari della fertilità, finalizzati ad ottenere la protezione divina sui raccolti. Le fonti informative più antiche risalgono all’Inno a Demétra (tradizionalmente attribuito ad Omero e databile al VII-VI secolo a.C.), che narra il mito del ratto di Persèfone da parte di Ade, signore dell’oltretomba, e la ricerca di Demétra che, peregrinando incessantemente, giunge infine ad Eleusi dove insegna agli abitanti le tecniche agricole (in particolare, quelle relative alla coltivazione dei cereali) ed istituisce e rivela i Misteri.
Secondo il racconto tradizionale, Ade, re degli Inferi, aveva rapito Persèfone (Kόre, letteralmente “vergine”, “fanciulla”) mentre raccoglieva fiori; Demétra, dopo aver vagato per tutta la Grecia nella vana ricerca della figlia, aveva fatto in modo che la Terra, maledetta, non producesse più frutti e, di conseguenza, Zeus, per rimediare alla situazione di carestia, aveva disposto che la fanciulla divina ritornasse dalla madre; tuttavia, Persèfone, per disattenzione (o perché tentata da Ade), aveva assaggiato quello che viene definito nell’inno omerico “il chicco dolcissimo di melagrana”, ma, avendolo fatto negli Inferi, a causa di ciò era rimasta legata definitivamente al regno dei morti; da allora, Persèfone aveva trascorso una parte dell’anno (metà o 2/3) in compagnia della madre sulla Terra (che in questo periodo produceva fiori e frutti) e la parte residua insieme ad Ade nel mondo sotterraneo (allorquando la Terra rimaneva sterile ed improduttiva).
I culti misterici di Eleusi erano, insieme a quelli dionisiaci, i più importanti e famosi del mondo antico: al pari dei grandi Giochi panellenici di Olimpia, essi rappresentavano per i Greci una delle principali manifestazioni della loro identità culturale e, pertanto, in epoca classica (V-IV secolo a.C.) erano aperti a tutti gli abitanti delle pόleis greche, a condizione che non fossero “barbari” e, che, pertanto, parlassero la lingua greca, e non fossero “impuri” (macchiati da crimini o sacrilegi), indipendentemente dalla condizione sociale e giuridica (erano ammessi, infatti, anche gli schiavi, gli stranieri e le donne); la partecipazione ai Misteri rappresentava un rito di passaggio comunitario, che al contempo rafforzava i legami interpersonali e i rapporti tra i diversi gruppi sociali all’interno della collettività cittadina; inoltre, coinvolgeva una problematica soteriologica relativa all’aldilà, in quanto gli iniziati al culto mistico nutrivano l’aspettativa di poter acquisire una condizione privilegiata dopo la morte.
Uno dei simboli del Misteri eleusini, insieme alla spiga di grano, era la torcia ardente utilizzata da Demétra per fare luce nell’oscurità degli Inferi alla disperata ricerca della figlia, allusione alla medesima ricerca che gli iniziati avrebbero dovuto compiere nella loro esperienza diretta dei riti: i Misteri, pertanto, possono essere considerati una grandiosa metafora di rinascita e rigenerazione continua, della perpetuità del cosmo che si esprime nelle forme del nascere e del morire, quali principi metafisici e necessari della trasformazione, ovverosia nomi ed aspetti di una ciclicità della vita eterna ed indistruttibile, al pari di quanto avviene nel ciclo biologico della natura; in definitiva, l’aspirazione dei Misteri era dunque acquisire l’immortalità per la propria ψυχή, la psyché, la propria “anima”, il proprio “spirito vitale”, grazie all’intuizione, alla rivelazione ed al passaggio attraverso le forze segrete di nascita e di morte che governano l’universo.
Anche il mondo romano conosceva bene ed apprezzava positivamente i Misteri eleusini, come risulta attestato, ad esempio, da Cicerone che, nell’opera filosofica-politica De legibus (Libro II, XIV, 36), databile intorno al 53-51 a.C., confessa di avere conseguito l’iniziazione e così si esprime nell’ambito di un dialogo con l’amico Attico, notoriamente amante della cultura greca:
(…) la tua Atene mi sembra abbia dato origine a molti ed egregi princìpi umani e religiosi, e li abbia introdotti nella vita umana, ma poi non vi fu nulla di meglio di quei misteri, dai quali, venuti fuori da vita rozza ed inumana, siamo stati educati ed addolciti alla civiltà, e, quindi, si chiamano iniziazioni, perché abbiamo conosciuto i princìpi della vita nella loro vera essenza; e non soltanto abbiamo appreso il modo di vivere con gioia, ma anche quello di morire con una speranza migliore. (…).
Ogni anno, in primavera, nel mese di Antesterione (o mese dei fiori, Febbraio-Marzo) venivano celebrati, innanzitutto, i “Piccoli Misteri”, che avevano luogo nel sobborgo ateniese di Agrai, sulle rive del fiume Ilisso: essi avevano una funzione “catartica” ovvero di purificazione preliminare, culminante con un sacrificio solenne a Demétra e Persèfone e con abluzioni degli “iniziandi” nel corso d’acqua; in seguito a tali riti, i partecipanti diventavano mýstai, “iniziati” ai misteri (“coloro che attendono di vedere e di rivelare”), ed erano pertanto ammessi ai “Grandi Misteri”, che si svolgevano in autunno, nel mese di Boedromione (Settembre-Ottobre), probabilmente per esorcizzare l’arrivo dell’inverno, duravano almeno una settimana e consentivano di acquisire lo status di epόptai, “veggenti” (“coloro che hanno la visione”).
Le “Grandi Feste Eleusine”, inoltre, avevano anche una particolare ricorrenza quadriennale, allorquando venivano celebrate in modo ancora più splendido, in quanto si svolgevano contestualmente alle gare agonistiche dei Giochi panellenici.
L’ambiente dedicato alle iniziazioni, il Telestérion, del quale rimangono soltanto alcune vestigia, era un grande edificio quadrato, un salone - circondato da un’alta gradinata dove sedevano gli iniziati, sempre mantenuto nella massima riservatezza e segretezza-, che ospitava la parte più importante delle celebrazioni, la “visione”, consistente in una sacra rappresentazione delle vicende mitiche di Demétra e Persèfone, curata dal sacerdote principale, lo hierophántes, “colui che mostra gli oggetti sacri” (quali erano, in particolare, le statue delle dee e le spighe di grano, simboli dei doni divini all’umanità), scelto in relazione alla sua prestanza fisica, all’autorevolezza ed al timbro della voce, adatto ad illustrare i riti ed alla recitazione delle formule iniziatiche (i legόmena).
I Misteri eleusini erano affidati ad alcune famiglie locali (in particolare, gli Eumolpidi, che selezionavano lo “ierofànte”, e i Kerykes, o Cerici, che fornivano un “araldo sacro” ed un “tedòforo”, portatore di torcia), discendenti dai fondatori dei riti arcaici, le quali mantennero le proprie prerogative anche quando, in progresso di tempo, l’area di Eleusi passò sotto il dominio politico di Atene che, naturalmente, era molto interessata sia alla protezione del Tempio, sia al controllo del culto, sia all’amministrazione dei beni e delle ampie ricchezze del Santuario.
Sotto quest’ultimo aspetto, è interessante evidenziare che il patrimonio templare di Eleusi, come avveniva negli altri Santuari greci di maggiore importanza (quali, ad esempio, Delfi, Delo, Olimpia), era costantemente alimentato da offerte votive e da altre, svariate fonti di entrata; inoltre, in epoca classica (V-IV secolo a.C.), venne fissata una quota di 15 dracme per l’iniziazione, quale contributo monetario che verosimilmente andava ad integrare oppure a sostituire l’offerta in natura tipica dell’età arcaica: pertanto, la Cassa “sacra” del Santuario era senza dubbio molto ricca e ben provvista, se si tiene conto che i partecipanti ai Misteri eleusini erano diverse migliaia in ciascun anno di celebrazione.
I culti misterici di Eleusi risultano testimoniati non soltanto dalle fonti archeologiche, epigrafiche, storiche e letterarie, ma anche dalla documentazione numismatica, in particolare dalla monetazione ènea risalente al IV secolo a.C., che riproduce immagini tipicamente associate alla mitologia ed ai rituali di celebrazione, come si può riscontrare analizzando, ad esempio, il seguente, splendido esemplare:
La moneta, coniata in ottimo bronzo (rame 89% + stagno 11%), con peso di circa 3,60 grammi x circa 2 cm di diametro, databile intorno al 340-335 a.C. circa, riproduce al dritto un uomo che, seduto su un carro alato, trainato da serpenti (o da draghi), tiene nella mano destra due spighe di grano; al rovescio, viene raffigurato un maiale in piedi su un bastone mistico (oppure su un fascio di ramoscelli); nel campo in alto, al di sopra del maiale, leggiamo l’iscrizione etnica in caratteri greci ΕΛΕΥΣΙ (ELEUSI); in “esergo” (campo in basso), compare un “bucranio” (cranio o teschio di bue), elemento decorativo molto diffuso.
La figura maschile riportata al dritto della moneta viene interpretata, di solito, come Trittòlemo, eroe eleusino (o divinità eleusina) oppure, nella leggenda più antica, re di Eleusi, legato al mito di Demétra: infatti, la dea, come ricompensa per l’ospitalità ricevuta, gli diede il grano, gli insegnò a coltivarlo e gli donò un carro alato affinché potesse percorrere il mondo diffondendo l’agricoltura tra i vari popoli.
Il maiale, riportato al rovescio della moneta, era il tipico animale sacrificale che veniva immolato nelle celebrazioni: infatti, tra i riti preparatori all’iniziazione, era previsto anche un bagno in mare, presso la baia del Fàlero (area portuale di Atene), con un’apposita prova di “tuffo” in acqua stringendo tra le mani un porcellino, destinato poi al sacrificio in onore di Demétra e Kore nel loro Santuario. A ciò faceva seguito una cerimonia di purificazione, durante la quale venivano oscillati, a ritmo di musica, fasci di rami simili a quelli raffigurati sulla moneta.
Il Santuario eleusino di Demétra, grazie alla sua supremazia spirituale ed alla conseguente, grande rilevanza acquisita nel mondo greco, poteva, verosimilmente, disporre di un privilegio di Zecca, ovverosia di un autonomo diritto di coniazione che avrebbe autorizzato a battere moneta propria; d’altra parte, la costante ingerenza di Atene nella vita politica di Eleusi, progressivamente annessa come “demo” attico, l’intimo collegamento e controllo tra il centro cittadino ed il borgo rurale tramite la “via sacra” che accoglieva la processione religiosa, la preminenza del sistema monetario ateniese, nell’ambito del quale nello stesso periodo storico del IV secolo a.C. risulta attestata la contemporanea fabbricazione di monete in bronzo realizzate con moduli molto simili (in fattura, peso e dimensioni) a quelli di Eleusi, sono alcuni elementi che fanno propendere per una coniazione - a cura sempre della stessa Zecca di Atene - anche delle monete di bronzo di Eleusi che, pertanto, possono essere considerate un sotto-insieme della moneta ateniese.
Gli studiosi di numismatica antica si sono interrogati spesso sulla funzione economica di queste monete e, in particolare, sul loro utilizzo esclusivo nell’ambito delle Feste di Demétra, che ne limiterebbe la natura e la valenza a monete cosiddette “festive”, spendibili soltanto all’interno del circuito chiuso e ristretto del “Festival” religioso; oppure, viceversa, si è ipotizzato che potessero avere un’ulteriore circolazione anche all’esterno, nell’ambito del sistema monetario generale all’epoca vigente, senza rimanere soltanto semplici monete locali, e poi eventualmente “sacre” e commemorative, una volta terminate le celebrazioni religiose.
La tematica della moneta “festiva” appare, senza dubbio, affascinante e degna di ulteriori approfondimenti, anche perché è stata finora poco studiata dagli specialisti e non risulta isolata ma coinvolge inoltre gli altri Santuari di importanza panellenica, quali in particolare Delfi ed Olimpia che, durante l’epoca classica ed ellenistica, e quindi per ben 500 anni circa, coniarono monete associate alle loro Feste ed ai loro Giochi.
La monetazione eleusina risulta prodotta esclusivamente in bronzo e, pertanto, evidenzia un limitato valore intrinseco, cosicché si potrebbe ritenere di essere di fronte a moneta “spicciola” e “festiva”, denaro di piccolo taglio utile a soddisfare essenzialmente le limitate esigenze di spesa che partecipanti e visitatori si trovavano ad affrontare durante il periodo di celebrazione dei misteri (ad esempio, gli acquisti di cibo e di offerte votive, ivi compreso il maialino sacrificale), tanto più che il numero preponderante di monete è stato rinvenuto proprio nella concentrata area del recinto sacro del Tempio.
D’altra parte, alcuni studi, supportati da ricerche archeologiche, da resoconti di scavo e dall’analisi di “tesoretti” monetali rinvenuti, hanno però messo in luce una tendenziale circolazione dei “bronzi festivi” eleusini insieme ai “bronzi civici” di Atene, verosimilmente per regolare transazioni su piccola scala; infatti, la moneta eleusina è stata spesso ritrovata, oltre il confine sacro del Santuario, sia ad Atene, sia altrove (ad esempio, a Corinto), in aree commerciali ed in piccoli siti di deposito (non di natura votiva), mentre è stata riscontrata poco presente in siti funerari, in depositi votivi, in inventari templari.
Alla luce di tali evidenze, sembrerebbe che le monete festive di Eleusi mantenessero, anche al di fuori dei Misteri, un carattere economico, e quindi natura di effettivo mezzo di scambio o di strumento di tesaurizzazione, senza essere necessariamente “de-monetizzate”, ritirate e scartate dalla circolazione per essere conservate soltanto come oggetti sacri, simbolici e commemorativi, oppure come semplici offerte votive agli dei.