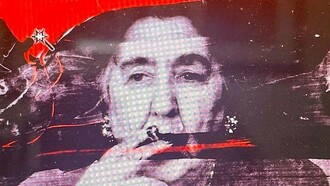Si potrebbe raccontare il pensiero complesso attraverso tre immagini: il serpente egizio ouroboros del XIV secolo a.C.; la litografia di Escher Mani che disegnano del 1948; e la rappresentazione taijitu del Tao risalente all’anno 1000. Esse illustrano, con forza simbolica e chiarezza concettuale, tre principi fondanti della visione complessa del mondo: il ciclo, l’iperciclo e l’ultraciclo.
L’ouroboros è il serpente che si morde la coda, figura arcaica di un tempo circolare senza inizio né fine. Il più antico esemplare conosciuto è inciso su una lamina d’oro nel sarcofago del giovane faraone Tutankhamon. In quel caso gli ouroboroi sono due, a cingere la testa e i piedi di una divinità mummiforme: secondo gli egittologi, simboleggiano la fusione fra Ra, divinità del mondo solare, e Osiride, signore del regno sotterraneo. L’ouroboros ha avuto lunga fortuna nel pensiero esoterico e alchemico, incarnando idee di rinascita, eternità, ritorno ciclico, perfezione. Ma, più in generale, richiama una visione del mondo strutturata in forma di ciclo.
Ogni cultura, arcaica e moderna, rigenera la propria identità attraverso riti collettivi che celebrano la forza ordinatrice della ciclicità: i riti contadini legati all’andamento della natura, quelli religiosi, civili, funerari, tutti convergono nella stessa logica simbolica. Il ciclo è memoria che ritorna e, nel ritornare, dà forma e senso al presente.
Ben prima che il tempo lineare imponesse la catena infinita di cause ed effetti, l’umanità ha riconosciuto nel mondo un ordine scandito dal ritorno: giorno, notte e ancora giorno; nascita, morte, rigenerazione. In ogni cultura tradizionale, la ciclicità è la grammatica originaria della natura. Non stupisce che l’ouroboros sia una delle immagini archetipe con cui l’homo sapiens ha cercato di comprendere la realtà. Il sole che ritorna ogni mattina, accolto dallo stupore del nostro antenato con l’esclamazione ra, accende nella giovane mente umana l’intuizione che dietro l’apparente disordine del mondo agisca un principio di affidabile regolarità.
Nel pensiero complesso, il ciclo assume un valore insieme epistemico e pragmatico: serve a comprendere il mondo e ad agire su di esso. Il concetto che connette la dimensione filosofica del ciclo alla pratica scientifica e tecnologica è quello di retroazione (feedback): l’informazione sull’effetto B è utilizzata per modificare la causa A. I feedback negativi riducono le deviazioni e producono stabilità; quelli positivi amplificano gli scarti, introducono disordine e innescano nuovi processi. La scienza del controllo – la cibernetica – si è concentrata in gran parte sui feedback negativi, per rendere stabili e prevedibili i cicli delle macchine e ridurre l’errore nei flussi informativi.
Già prima della cibernetica, l’idea di feedback negativo aveva avuto applicazioni tecnologiche. Il regolatore automatico della pressione nelle macchine a vapore, inventato da James Watt nel 1787, ne è un esempio celebre. Risale all’antichità l’invenzione della valvola a galleggiante per regolare il flusso dell’acqua, applicata a orologi idraulici da greci, romani, arabi e artigiani medievali.
La potenza del feedback negativo sta nell’idea che la stabilità di un processo non si ottiene irrigidendolo in vincoli esterni, che prima o poi si logorano, ma inserendo nel sistema una forza reagente, proporzionale alle deviazioni e attivata dalla stessa forza agente. Ne deriva un’intuizione decisiva: l’integrità di un sistema si costruisce attraverso un equilibrio dinamico di forze. Ciò che a uno sguardo superficiale appare come entità inerte, se pensato come “cosa-ciclo” rivela un’intensa vita interiore. La stabilità è una costruzione mentale, una necessaria finzione che maschera una rete fitta di azioni e reazioni – ed è questa rete che rende possibile pensare, parlare, vivere nel mondo.
Il pensiero complesso scava dentro il concetto di ciclo e ne disvela le potenzialità. Edgar Morin lo pone a fondamento della sua epistemologia, mostrando che ogni entità organizzata è composta da cicli auto-organizzanti che si intrecciano e interagiscono, inclusi in cicli ancora più ampi. Anche nei sistemi sociali, nessuna attività collettiva sarebbe sostenibile senza la chiusura ciclica dello scambio informativo. Eppure, si continua a progettare processi lineari, al massimo con esili ritorni di informazione.
I biologi Maturana e Varela definiscono la vita come un ciclo operativo chiuso, che continuamente riproduce sé stesso attraverso le strutture materiali delle molecole, delle cellule, dei tessuti. Fritjof Capra e altri teorici della complessità hanno mostrato che la vita è un tessuto in cui la materia vivente e quella inerte si rigenerano incessantemente attraverso una trama di cicli annidati.
Uno dei concetti più rilevanti nello studio della complessità è quello di ciclo attrattore, sviluppato nella dinamica dei sistemi non lineari. Ogni processo di questo tipo tende a una delle tre configurazioni stabili, dette appunto attrattori: un punto fisso, un ciclo regolare o un ciclo definito “strano attrattore”. Quest’ultimo ha la particolarità di percorrere un’orbita quasi stabile, ma mai identica, senza incrociare mai la stessa traiettoria. Lo strano attrattore è un segno distintivo della complessità.
Walter Freeman, studiando le aree cerebrali coinvolte nel riconoscimento degli odori negli animali, ha mostrato che in assenza di riconoscimento l’attività neurale è caotica, mentre nel momento del riconoscimento si organizza secondo uno strano attrattore. Questi e altri esperimenti suggeriscono che le abilità cognitive possano emergere come configurazioni cicliche dell’attività cerebrale. L’identità, allora, è la trascrizione linguistica di una rigenerazione continua: materiale, sociale, immateriale.
Insomma, benché il pensiero lineare della causa-effetto continui a dominare il nostro agire, non possiamo prescindere dal pensiero ciclico. Anzi, direi che esso è oggi più che mai necessario per comprendere e abitare un mondo complesso.
Mi accorgo, però, di aver dedicato tutto questo spazio al solo ciclo, senza nemmeno accennare all’iperciclo e all’ultraciclo. Vorrà dire che ne parlerò nei prossimi articoli.
Riferimenti
Capra, F., The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems, Anchor Books, 1996.
Freeman, W. J., The physiology of perception. Scientific American, 264(2), pp. 78–85, 1996.
Maturana, H. R., & Varela, F. J., Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, D. Reidel Publishing Company, 1980.
Morin, E., On Complexity (R. Postel, Trans.), Hampton Press, 2008 (Opera originale pubblicata nel 1990).