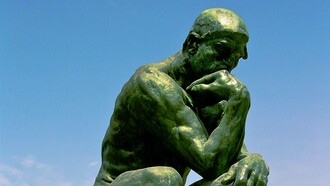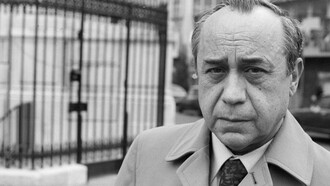Nel contesto informativo attuale, la distinzione tra fatto e falsità è sempre meno netta. Vi sono ragioni ideologiche radicate nel discorso postmodernista, che ha cercato di convincere prima il mondo dell’accademia e quindi le persone comuni che la realtà è solo questione di punti di vista e non esiste una verità oggettiva. Basta guardarsi intorno per capire a cosa conduce un pensiero del genere, ed è quindi facile capire perché i cosiddetti filosofi postmodernisti si siano tanto accaniti contro il pensiero religioso in cui, pur con tutte le sue limitazioni, la distinzione tra vero e falso, giusto e sbagliato semplicemente non è negoziabile.
Si può descrivere la condizione dell’informazione odierna ricorrendo all’esempio del fast-food. L’attrattiva del fast-food risiede in due elementi: costa poco ed è veloce. Per realizzare queste caratteristiche, le catene di fast food ricorrono ai seguenti espedienti:
Usano materie prime ed ingredienti di bassa qualità, in modo da contenere i costi.
Usano metodi di lavorazione standardizzati, in modo da velocizzare la produzione e mantenere costante e prevedibile il costo della lavorazione.
In più, le combinazioni di ingredienti e additivi sono studiate per incoraggiare il cervello a rilasciare dopamina. In altre parole, nessuno degli ingredienti da solo crea dipendenza, ma la loro combinazione può provocare effetti simili a quelli di una dipendenza. Uno studio del 2023 di 281 studi condotti in 36 paesi ha rilevato che le combinazioni di carboidrati raffinati e grassi presenti negli alimenti ultra-trasformati producono un “effetto sovra-additivo sui sistemi di ricompensa del cervello”, con tassi di dipendenza (~14% negli adulti, 12% nei bambini) simili a quelli di sostanze legali come l'alcol o il tabacco.
Per l’informazione il meccanismo è simile e le tattiche di ingaggio sono quasi equivalenti. L’informazione oggi, specie quella che viene spacciata come tale sui social media, è costruita in base a due criteri:
Velocità: il contenuto deve essere prodotto e diffuso rapidamente e consumato il più velocemente possibile.
Impatto emotivo: il contenuto è studiato per aggirare la riflessione critica e puntare direttamente a scatenare una risposta emotiva di avversione o di sostegno.
Diversi studi confermano che l’informazione diffusa sui social media segue logiche simili a quelle della pubblicità: è progettata per essere consumata rapidamente e suscitare una risposta emotiva immediata. La velocità di diffusione è favorita da algoritmi che premiano l’engagement istantaneo, mentre contenuti con linguaggio moralizzante o carico di emozioni—soprattutto rabbia o indignazione—hanno maggiore probabilità di essere condivisi (Brady et al., 2017). Il risultato è un ambiente informativo che tende ad aggirare la riflessione critica, privilegiando reazioni impulsive, come confermato anche da ricerche sul sovraccarico cognitivo e sulla neurobiologia delle emozioni (Bright, 2021; Lieberman, 2013).
Oggi più che mai è necessario tenere presente che i social media, quali che essi siano, così come le testate di informazione più tradizionali come giornali e reti televisive non pubbliche sono soggetti privati il cui scopo è generare un utile e che rispondono a degli azionisti, non a coloro che consumano i contenuti da essi prodotti e diffusi. In maniera simile, anche se meno evidente, gli organi di informazione nazionali devono rapportarsi con il potere politico, perciò è opportuno esercitare cautela anche nei confronti delle versioni ufficiali dei fatti, senza per questo cadere dalla padella alla brace lasciandosi tendare dalle teorie cospirazioniste più fantasiose.
La capacità di valutare l’attendibilità di ciò che leggiamo, ascoltiamo o vediamo è diventata una competenza civica fondamentale. Sebbene la diffusione di informazioni false non sia un fenomeno nuovo, la velocità e la portata con cui oggi circolano pongono problemi che un tempo non esistevano.
Misinformazione e disinformazione: una distinzione necessaria
Con "misinformazione" si intende un contenuto inaccurato o fuorviante diffuso senza intento ingannevole. Spesso deriva da un’incomprensione, da un’errata interpretazione dei dati, o da un’opinione personale presentata come se fosse un fatto. Al contrario, la "disinformazione" è creata e diffusa deliberatamente allo scopo di ingannare. È comunemente impiegata per fini politici, ideologici o economici.
Questa distinzione è utile per decidere come reagire. Un amico che condivide in buona fede una raccomandazione sanitaria superata non si trova nella stessa situazione di una rete organizzata che diffonde affermazioni false per minare la fiducia pubblica. Tuttavia, entrambe contribuiscono alla confusione generale e meritano attenzione.
Come riconoscere contenuti inaffidabili
La disinformazione più efficace tende a imitare i tratti dell’informazione attendibile. Raramente si presenta come qualcosa di evidentemente assurdo: è proprio questa somiglianza che la rende insidiosa. Tuttavia, alcuni segnali possono aiutare a riconoscerla.
Il primo riguarda l'autorevolezza della fonte. I contenuti affidabili sono generalmente firmati da autori identificabili o pubblicati da organizzazioni con regole editoriali trasparenti. Quotidiani, enti pubblici e istituti di ricerca rendono facilmente reperibili i propri criteri redazionali, la propria struttura e le fonti di finanziamento. Al contrario, siti anonimi o poco trasparenti meritano cautela.
Il secondo criterio è la presenza di prove verificabili. Un’affermazione solida dovrebbe essere accompagnata da fonti attendibili: documenti, dati, citazioni da esperti riconosciuti. I contenuti che si basano su impressioni soggettive, toni emotivi o generalizzazioni non soddisfano questo standard.
È utile anche osservare il tono generale. Quando un testo sembra concepito per generare allarme, indignazione o paura, è opportuno sospettare un intento manipolatorio. L’uso di linguaggio enfatico, di slogan ripetuti o di immagini forti è tipico di chi cerca di aggirare la valutazione razionale.
Infine, è importante chiedersi se ciò che si legge corrisponde in modo troppo perfetto alle proprie convinzioni. Se un’informazione conferma completamente una visione preesistente, senza apportare nuovi elementi o sfumature, è possibile che stia facendo leva sul cosiddetto “bias di conferma”. Molti contenuti disinformativi dividono il mondo in modo netto, raffigurando una parte come totalmente giusta e l’altra come completamente in torto.
Come verificare un’informazione: strumenti e strategie
Non è necessario essere giornalisti o scienziati per valutare l’attendibilità di un contenuto. Esistono metodi semplici e strumenti accessibili a tutti.
Uno dei più efficaci è la ricerca inversa delle immagini. Molta disinformazione utilizza fotografie autentiche, ma decontestualizzate. Utilizzando strumenti come Google Lens o TinEye si può verificare dove e quando un’immagine è apparsa per la prima volta. Spesso un’immagine attribuita a un evento attuale proviene da una situazione completamente diversa, sia nel tempo che nello spazio.
Anche cercare l’affermazione su testate giornalistiche affidabili può essere utile. Se una notizia apparentemente importante compare soltanto su blog sconosciuti o account social non verificati, è prudente sospettare. Se invece è riportata da più fonti autorevoli, è più probabile che sia fondata.
Esistono inoltre siti dedicati alla verifica dei fatti. Tra i più noti a livello internazionale vi sono Snopes, FactCheck.org, PolitiFact ed EUvsDisinfo. In Italia svolgono un ruolo analogo piattaforme come Open.online e Pagella Politica. Questi portali spesso pubblicano anche le fonti su cui si basano, consentendo al lettore di farsi un’opinione autonoma.
È utile anche la cosiddetta “lettura laterale”: invece di restare sul sito in questione, si apre una nuova scheda e si cerca chi sia l’autore o l’organizzazione che ha prodotto il contenuto. Questo permette di valutare se la fonte è conosciuta, se ha precedenti nella diffusione di contenuti fuorvianti o se è espressione di un’agenda particolare.
In sintesi, la strategia più efficace è confrontare più fonti. Se solo un sito o una pagina social sostiene un certo fatto, mentre altre fonti autorevoli lo contraddicono o ignorano del tutto, è opportuno dubitare.
Caso studio: una narrazione dell’estrema sinistra sull’Ucraina
Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, alcuni ambienti dell’estrema sinistra hanno sostenuto che la responsabilità principale del conflitto fosse della NATO. Secondo questa interpretazione, l’espansione dell’alleanza verso est avrebbe provocato la reazione russa, violando promesse fatte dopo la Guerra Fredda e minacciando la sicurezza di Mosca.
Questa lettura si è diffusa in ambienti critici verso le politiche occidentali, su social network, riviste e blog. In certi casi è stata presentata come analisi geopolitica realista o come posizione anti-imperialista.
Pur partendo da un tema reale — l’allargamento della NATO è effettivamente oggetto di dibattito storico e politico — questa narrazione tende a semplificare e distorcere. Ignora, ad esempio, il ruolo attivo dell’Ucraina, la volontà popolare espressa nel sostenere un percorso europeo, e le azioni russe già compiute nel 2008 (Georgia), nel 2014 (annessione della Crimea) e nel Donbass. Non considera, inoltre, le dichiarazioni pubbliche del presidente Putin, che ha messo apertamente in discussione l’identità e la legittimità dell’Ucraina come Stato.
Secondo analisi condotte da istituti come Chatham House e Carnegie Europe, l’adesione dell’Ucraina alla NATO non era in programma nel breve termine. Non vi era un pericolo immediato. La persistenza di questa narrazione, nonostante tali evidenze, mostra un uso strumentale di elementi parziali per costruire una visione unilaterale. Il fatto che media russi abbiano attivamente rilanciato queste argomentazioni suggerisce che si tratti almeno in parte di una forma di disinformazione.
Caso studio: una falsa affermazione dell’estrema destra sui vaccini COVID-19
Durante la campagna vaccinale globale contro il COVID-19, una delle affermazioni più diffuse in ambienti dell’estrema destra e in circuiti complottisti sosteneva che i vaccini contenessero microchip per tracciare la popolazione. La voce si è diffusa ampiamente su Telegram, Facebook e YouTube, accompagnata da immagini di siringhe, schemi tecnici falsificati e video manipolati.
L’origine della teoria va ricercata in un fraintendimento (o deliberata distorsione) di progetti legati alla digitalizzazione dei dati sanitari, sostenuti da enti internazionali e filantropi come Bill Gates. Alcuni articoli scientifici su tecnologie nanometriche sono stati estrapolati e usati come “prove” di un presunto complotto.
La realtà è che non esiste alcuna tecnologia che consenta l’inserimento di un microchip funzionante tramite una comune siringa. Le autorità sanitarie internazionali (OMS, EMA, CDC) hanno smentito ripetutamente e in modo chiaro tali affermazioni.
Tuttavia, la teoria si è rivelata efficace proprio perché ha fatto leva su timori profondi: la perdita del controllo sul proprio corpo, la diffidenza verso lo Stato e la paura della sorveglianza. In alcuni casi, le stesse persone che diffondevano la voce vendevano anche “kit disintossicanti” o rimedi alternativi, traendo profitto dalla disinformazione.
Il carattere coordinato della diffusione, la ripetizione sistematica dei messaggi e la loro monetizzazione rendono questo un esempio tipico di disinformazione deliberata.
Condividere con cautela
Gran parte della misinformazione si diffonde attraverso utenti comuni che agiscono in buona fede. Una persona può condividere un contenuto pensando che sia utile, senza rendersi conto che è falso o decontestualizzato.
Per questo motivo, rispondere in modo pacato e non accusatorio è spesso più efficace. Quando si tratta di amici o familiari, una conversazione privata accompagnata da fonti attendibili è preferibile a una smentita pubblica. Il tono fa la differenza: gentilezza e chiarezza hanno maggiori probabilità di convincere rispetto all’ironia o al rimprovero.
Un'abitudine utile è prendersi un momento prima di condividere qualcosa. Domandarsi: conosco questa fonte? È verificabile? È progettata per provocare una reazione emotiva?
Conclusione
La circolazione di informazioni false o fuorvianti non è un problema marginale. Ha un impatto concreto sul dibattito pubblico, sulle decisioni politiche e sulla fiducia nelle istituzioni. Anche se le cause strutturali della disinformazione—economiche, tecnologiche, politiche—non possono essere risolte dal singolo, le scelte individuali restano significative.
Non si tratta di controllare ogni affermazione o correggere ogni errore. Un approccio prudente, informato e rispettoso alla condivisione delle informazioni contribuisce a costruire uno spazio pubblico più affidabile.