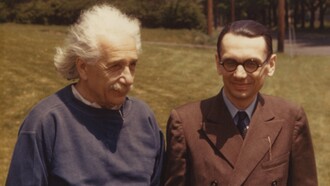Giuseppe Pontiggia nasce il 25 settembre del 1934. È biondo, ha gli occhi azzurri ed è un gigante sin da neonato: pesa ben 5 chili e mezzo. Cresce in un ambiente colto: il padre nutriva un amore sconfinato per i libri che raccoglieva in una stanza chiamata “la libreria” (e che fu in parte venduta alla morte dell’uomo per far fronte all’indigenza economica della famiglia). La madre era casalinga e amava tanto il teatro. A otto anni circa una brutta polmonite lo colpisce ed è costretto a rimanere a letto per un mese. Per non annoiarsi, comincia a leggere, anzi a divorare libri. La lettura è, infatti, per lui un’esperienza di felicità e fonte di immaginazione. Così, leggendo quei libri d’avventura, le pagine si trasformano in gioco: il cugino Ezio impersona Sandokan e lui Yanez.
Alla morte del padre, nel 1943, la famiglia Pontiggia si trova in grosse difficoltà economiche e lui riesce a trovare un impiego in banca a soli 17 anni, essendo riuscito, oltre che per bravura anche per necessità, ad ottenere prima la Maturità. Quest’esperienza ritornerà nelle pagine de La morte in banca, suo primo romanzo, quasi un romanzo esistenziale e di formazione. Qui viene trasmesso al lettore l’amore per lo studio e per il sapere del protagonista Carabba, alter ego dell’autore che riuscì a conciliare il lavoro in banca con gli studi universitari.
L’amore per la lettura e la conoscenza non abbandonerà mai Giuseppe (Peppo per gli amici) Pontiggia, bibliofilo incallito, tanto che decise di fare il Professore di Lettere in una Ragioneria delle Scuole Serali per avere tutto il tempo per dedicarsi ai suoi amati libri.
Privo di qualsiasi interesse materialistico, a lui non importava guadagnare tanto: si accontentava del suo piccolo stipendio perché intanto la vera ricchezza risiedeva nei suoi studi e nel desiderio costante di accrescere il suo sapere. Questi saranno i punti cardine della vita e delle opere che sono un riflesso, uno specchio fedele della sua immensa passione per la cultura. L’amore per i libri, Pontiggia lo conserverà sempre: aveva così tanti volumi, antichi e moderni, che fu costretto a farsi costruire delle librerie alte fino al soffitto in modo da poterli contenere tutti.
Passavano gli anni e i libri aumentavano, così Peppo fu costretto ad abbattere un muro divisorio del suo appartamento per metterlo in comunicazione con un altro e stiparlo di libri e giornali. Un appartamento enorme di fogli di carta, rigorosamente catalogati (alcuni messi in vere e proprie teche). È normale che non avesse potuto leggere le sue migliaia di libri, ma per lui già il fatto di averli, toccarli, sfogliare e sbirciare le pagine significava conoscerli.
L’amore per lo studio e la conoscenza è una caratteristica fondamentale di tutte le sue opere, non solo di narrativa, a partire dal suo primo romanzo La morte in banca del 1952 ed edito nel 1959. È un romanzo breve (a cui vennero aggiunti cinque racconti che fanno da corollario) con protagonista il diciassettenne Carabba, alter ego dell’autore, eccelso negli studi e che per stringenti necessità economiche si impiega in banca.
Il narratore racconta la vita del giovane Carabba in banca come tomba dell’anima e delle aspirazioni, uniformando tutti negativamente sia a livello umano che professionale. Contemporaneamente a questa morte c’è la vita: le letture, l’amore sconfinato per lo studio e il forte rapporto con la madre, depositaria di tutte le confidenze. È il mondo dei travet (termine spregiativo per caratterizzare gli impiegati), al centro della narrazione. I travet sono oggetto di indagine, di speculazione psicologica e morale, e la banca il luogo della morte collettiva.
Già in questo romanzo, emergono tutte le caratteristiche future della singolare narrativa di Pontiggia: la fusione di tensione etica, di esiti umoristici, patetici, comici, amari e tragici. La molteplicità dei registri linguistici e dei punti di vista, la ricchezza dei significati e dell’autobiografismo, l’attenzione all’ironia, alla comicità, ai paradossi e ai dialoghi sono la cifra della sua altissima e geniale letteratura che si basa sul concetto di chiarezza linguistica, ossia la genuinità: il valore di un testo si esprime attraverso la chiarezza. E più un testo è chiaro, maggiori e molteplici sono i suoi significati.
La chiarezza formale (e quella contenutistica) abbracciano tutta la sua vasta produzione: Pontiggia si è cimentato in ogni genere, dai romanzi ai saggi, dagli articoli per i giornali alla narrativa per l’infanzia (Cichita la scimmia parlante). Produzione che ha delle caratteristiche univoche:
Compiutezza armonica.
Importanza del ritmo nella sua prosa.
Ricchezza dei toni.
Ricchezza dei registri linguistici.
Pontiggia è riuscito a creare uno stile suo particolarissimo ed eterogeneo, a seconda dei temi trattati e dei generi affrontati, a partire anche dai suoi modelli letterari, in primis i classici greci e latini a cui deve la lezione della brevitas. Ma anche Manzoni, Collodi, Svevo, Majakovski, Joyce, Kafka (a cui si rifà per l’anonimia dei personaggi de La morte in banca e L’arte della fuga), Hemingway (modello supremo per i dialoghi). E ricorda, ancora, il grottesco di Vargas Llosa e per la struttura di Nati due volte e Prima persona, il Cortazar di Rayuela.
Portando tutte le sue influenze letterarie nelle sue opere, ha creato qualcosa di estremamente innovativo e inedito nel panorama letterario italiano, a partire dall’utilizzo dell’ossimoro in alcuni suoi titoli, come Il raggio d’ombra (come può un’ombra, realmente, avere un raggio luminoso?), romanzo a suspence del 1983 - non l’unico nella sua ampia produzione - ispirato a un episodio di tradimento politico avvenuto nel 1927.
Il valore politico e civile è presente in ogni suo scritto, in maniera più o meno velata a seconda dei casi. E l’analisi della società nei suoi molteplici aspetti (a volte davvero spietata) è sempre affrontata col ricorso al grottesco, alla comicità, all’umorismo, all’ironia, alla satira. Seppur trattando di argomenti tragici o drammatici, Pontiggia non si abbandona mai al pessimismo, non si crogiola mai nella sofferenza o nella disperazione quando -nei suoi romanzi- affronta anche tematiche autobiografiche dolorosissime.
E nella vita di Peppo Pontiggia la tragedia è una costante. Ciò che lo segnerà per sempre è l’omicidio del padre da parte dei partigiani. La tragedia intima e personale di Pontiggia è inscritta in una tragedia storica e universale. Due partigiani gli spararono sotto casa. Le motivazioni non furono mai chiarite, ma collegate alle cariche pubbliche ricoperte dal padre. Fu anche podestà di Monguzzo, ma mai un fervente fascista. Anzi, rientrò disgustato dalla guerra in Albania. Al fratello Giampiero fu riferito che all’interno del Comitato di Liberazione Nazionale si parlava di “errore”. “Comunque quel delitto ha cambiato radicalmente la nostra vita” dirà Giuseppe Pontiggia a Rossana Dedola1.
Nel 1955 la falce della Morte colpisce nuovamente la famiglia Pontiggia: la sorella Elena, non ancora ventenne, si suicida. Giuseppe e il fratello Giampiero, per lenire il dolore materno, non ne sveleranno mai la causa. Troppo grande il loro amore per la madre per permetterle di essere straziata da un nuovo, devastante lutto.
E la tragedia familiare si impossessa per l’ennesima volta di Peppo quando, alla nascita di suo figlio Paolo, per un errore medico dovuto all’utilizzo del forcipe al momento del parto, il bimbo diventerà tetraplegico. Al figlio, e alla disabilità in generale, è dedicato il romanzo Nati due volte (2000, vincitore del Premio Campiello 2001), con un titolo estremamente simbolico. Romanzo autobiografico, commovente, sul rapporto tra un padre e un figlio gravemente disabile e dove la disabilità è affrontata da prospettive sempre diverse. Un lungo dialogo col figlio visto con oggettiva considerazione.
Pontiggia non potrà mai indugiare nella retorica, nella rassegnazione e nella commiserazione e infatti, anche qui, c’è quella perfetta fusione ed impeccabile equilibrio di registri che troviamo altrove: la satira, la comicità, il grottesco, lo humour, la malinconia, il patetico, la commozione, il tragico, la compassione per l’essere umano.
Nati due volte mette anche spietatamente a nudo la società dei “normali disabili” che seguono la vacuità di modelli di perfezione, con l’ossessione per il culto del corpo e dell’immagine, come se la vita fosse una continua gara (emanazione dell’Italia contemporanea, “ipocrita, arruffona e ignorante, torpida e cinica” 2). Ed ecco che ritorna il suo caro valore civile della letteratura all’interno di un dramma familiare eterno.
È il gioco del e col destino che lui ha più volte “messo in scena”, a partire da Il giocatore invisibile (1978), attraverso la metafora degli scacchi, gioco di cui non si può conoscere lo svolgimento, al pari degli eventi dell’esistenza. E bisogna saper perdere, accettare le sconfitte dettate dal Fato. Bisogna imparare che dalla morte (intesa non solo fisicamente) può nascere la vita.
Pontiggia, come si è detto, ha sempre trasformato la tragedia in ironia, autoironia, comicità, grottesco etc. Non si è mai piegato al pessimismo perché è proprio il dramma più profondo a generare l’ironia con tutte le sue declinazioni. La pura ironia non può nascere che dal dolore più devastante. Dolore e ironia: un’unica medaglia. Senza le sue grandi tragedie, molto probabilmente, non avremmo la sua grandiosa narrativa e saggistica, un immenso unicum in tutta la Letteratura italiana.
Lo scrittore è stato uno dei più formidabili e acuti lettori dell’ultimo quarantennio […]. Aveva il gusto della libertà, dell’intelligenza e dell’ironia, che nascevano dalla coscienza della serietà della vita e del valore della parola come dimora dell’essere. Faceva letteratura perché l’amava profondamente e ne percepiva il significato civile: perciò era un incontentabile correttore dei suoi libri quando l’esito non lo convinceva […]. Aveva il DONO DELL’ASCOLTO E DELLA SEMPLICITÀ DI CUORE3. Amava la vita e sapeva viverne tutti gli aspetti con gioia e ottimismo4.
I lettori hanno colto profondamente la sua autenticità e la sua grandezza d’animo. Un vero gigante!
Note
1 Giuseppe Pontiggia, Opere, a cura di Daniela Marcheschi, Meridiani Mondadori, Milano 2004, p. LXXII.
2 Op. cit., p. LXI.
3 Il maiuscolo è mio, n.d.r.
4 Op. cit., p. LXIII.