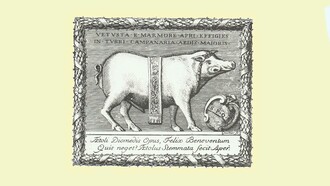Crescere con due lingue madri è un’esperienza strana. Fin da piccolissimi si impara che le cose non hanno un solo nome, che il modo in cui si esprime un’idea può cambiare a seconda del contesto, e che certe emozioni sembrano più vere in una lingua rispetto all’altra.
Io mi sono sempre chiesta: è solo una questione di parole, o la lingua stessa modella il modo in cui vedo il mondo? La scienza ha cercato di rispondere a questa domanda per decenni, e oggi sappiamo che la lingua non è solo un codice per comunicare ed esprimere pensieri e sentimenti, ma un vero e proprio filtro attraverso cui percepiamo la realtà.
Lera Boroditsky, una delle massime studiose in questo campo, lo spiega con una serie di esperimenti affascinanti. Le persone che parlano lingue diverse notano dettagli differenti dell’ambiente circostante, organizzano il tempo in modi diversi e attribuiscono perfino caratteristiche emotive agli oggetti in base al loro genere grammaticale.
Ma questa non è solo una teoria accademica e io l’ho vissuta in prima persona. Quando penso in una delle due mie lingue madri, mi sento più razionale e analitica; nell’altra, più istintiva e poetica. Quando esprimo un concetto o un’emozione, mi ritrovo a scegliere una lingua piuttosto che l’altra, come se certe espressioni appartenessero ad un codice specifico.
In questo articolo, vorrei esplorare come la lingua che parliamo plasma la nostra percezione del mondo, come i diversi sistemi linguistici influenzano il pensiero e come, parlando più lingue, possiamo arricchire la nostra esperienza della realtà.
La lingua modella il nostro spazio mentale
Orientarsi nel mondo: sinistra e destra o nord e sud?
Un esempio affascinante riguarda il modo in cui le diverse lingue concepiscono lo spazio. Nelle lingue europee, siamo abituati a pensare in termini di “destra” e “sinistra”, ma alcune comunità aborigene australiane – come i Guugu Yimithirr - non usano mai queste parole e usano solamente i punti cardinali. Per esempio, invece di dire “il libro è alla tua destra”, loro dicono “il libro è a sud-est di te”. Questo significa che fin da bambini, i membri di questa comunità imparano a sviluppare un senso dell’orientamento incredibile. Anche all’interno di una stanza senza finestre, sapranno comunque dove di trova il nord, perché il loro cervello è allenato a percepire il mondo in termini assoluti.
Questo cambia il modo di pensare. In un esperimento, ai partecipanti veniva chiesto di disporre delle immagini di una sequenza temporale (un uomo che invecchia, una pianta che cresce). Gli anglofoni tendono a disporre le immagini da sinistra a destra, perché è così che leggiamo; ma i Guugu Yimithirr le dispongono sempre da est a ovest indipendentemente da dove siano seduti, perché per loro lo scorrere del tempo segue il movimento del sole.
Lo spazio: la metafora culturale del tempo
Non solo spazio: anche il tempo viene percepito diversamente a seconda della lingua. Gli inglesi e gli italiani parlano del futuro come qualcosa “davanti a noi” e del passato come qualcosa “dietro di noi”. Ma per popoli come l’aymarà, popolazione indigena del Sud America, è l’opposto: il passato è davanti a loro, perché solo il passato è conosciuto e si può vedere, mentre il futuro è dietro proprio perché ignoto.
Questo significa che il modo in cui una lingua organizza il tempo cambia la nostra percezione e concezione del futuro. Studi hanno dimostrato che le persone che parlano lingue con un futuro marcato, come l’inglese o l’italiano, tendono a risparmiare meno denaro e a organizzare di meno il venire, perché il futuro sembra più distante. Chi parla lingue che non separano nettamente presente e futuro, come il cinese o il tedesco, tende a pianificare e organizzare di più.
Personalmente, noto che in una delle mie lingue madri parlo del futuro in modo più cauto, quasi come se fosse meno prevedibile. Nell’altra, tendo a usare strutture verbali che danno più certezza. Forse è un caso, ma probabilmente è la lingua stessa che mi porta a pensare in modo diverso.
La grammatica e il pensiero: come il linguaggio costruisce il mondo
Il peso del genere grammaticale
Se parli una lingua con genere grammaticale, probabilmente non ci pensi troppo: un tavolo è maschile, una sedia è femminile e va bene così. Ma questo cambia il modo in cui percepiamo gli oggetti.
Un esperimento interessante è stato condotto su persone che parlano tedesco e spagnolo. In tedesco la parola ponte è femminile; in spagnolo è maschile. Quando è stato chiesto ai partecipanti di descrivere lo stesso ponte, i tedeschi lo hanno descritto con aggettivi come “elegante” e “esteticamente bello” (stereotipicamente femminili), mentre gli spagnoli hanno usato parole come “forte” e “solido” (stereotipicamente maschili).
Questo è un caso in cui la grammatica non è solo una questione di regole, ma anche di percezione. Crescere con due lingue, una con genere grammaticale e l’altra che non ce l’ha, mi ha fatto notare che percepisco gli oggetti in maniera diversa e che sono più oggettiva quando uso la lingua senza genere. Questo perché l’associazione culturale oggetto-descrizione è radicata profondamente nel modo in cui pensiamo.
I verbi e la responsabilità: chi ha rotto il vaso?
Un altro aspetto interessante è il modo in cui le lingue descrivono le azioni. In inglese, se qualcuno rompe un vaso, si tende a dare la colpa a qualcuno anche se è stato un incidente, dicendo infatti “he broke the vase”. In spagnolo, è più comune dire “el vaso se rompió”, attenuando la responsabilità dell’agente.
Questo cambia il modo in cui percepiamo la responsabilità e studi dimostrano che chi parla lingue che enfatizzano l’agente (come l’inglese) ricorda meglio chi ha compiuto un’azione, mentre chi parla lingue che attenuano la responsabilità (come il giapponese o lo spagnolo) tende a focalizzarsi sull’evento stesso. Anche questo è qualcosa che noto nel mio modo di parlare. In una delle mie lingue madri, tendo a enfatizzare la causa, mentre nell’altra mi concentro più sul risultato e questo cambia il modo in cui percepisco la responsabilità nelle situazioni quotidiane.
La lingua e le emozioni: il potere delle parole
Se siete bilingue, probabilmente vi siete accorti che alcune emozioni si esprimono meglio in una lingua piuttosto che in un’altra. Personalmente, ho sempre trovato strano come alcune parole abbiano un peso emotivo completamente diverso a seconda della lingua in cui vengono comunicate.
Prendiamo ad esempio le dichiarazioni d’amore. Nella mia esperienza, “Ti amo” in una delle mie lingue madri suona molto più forte e definitivo rispetto alla traduzione nell’altra. In una lingua, sembra qualcosa di solenne, quasi vincolante; nell’altra, è più leggero, più facilmente utilizzabile in diversi contesti. Questo non significa che in una lingua si ami di più o di meno, ma che il contesto culturale e linguistico in cui cresciamo modella la nostra percezione delle emozioni.
La lingua cambia il modo in cui sentiamo le emozioni
Studi dimostrano che le persone bilingue vivono le emozioni in modo diverso a seconda della lingua che usano. Un esperimento ha mostrato che quando si chiede a una persona bilingue di descrivere un ricordo emotivo in una lingua piuttosto che nell’altra, il tono della narrazione cambia.
Quando si usa la lingua materna, le emozioni tendono a essere più intense e personali, mentre quando si parla una seconda lingua, il racconto diventa più distaccato, quasi analitico. Questo fenomeno si chiama “effetto della distanza emotiva” e spiega perché molte persone trovano più facile parlare di argomenti difficili in una lingua diversa dalla loro madrelingua: è come se le parole creassero una barriera tra l’esperienza e il modo in cui la riviviamo.
La censura emotiva delle lingue a noi straniere
Un altro aspetto curioso riguarda il modo in cui le parole volgari o offensive vengono percepite nelle lingue straniere. Hai mai notato che una di queste parole in una lingua che non è la tua madrelingua suona meno forte? Questo accade perché le parole cariche di significato emotivo sono profondamente radicate nel nostro cervello, associate ai ricordi della nostra infanzia e alla nostra educazione.
Uno studio ha dimostrato che le persone hanno una reazione fisiologica più forte (come un aumento della frequenza cardiaca o della sudorazione) quando sentono insulti o parole emotivamente cariche nella loro lingua madre rispetto a una lingua acquisita più tardi. Questo dimostra che le emozioni e il linguaggio sono legati in modo profondo, tanto che persino il nostro corpo reagisce diversamente a seconda della lingua che usiamo.
Il linguaggio influenza la nostra personalità
Molti bilingue riferiscono di sentirsi “persone diverse” a seconda della lingua che parlano. Questo è un fenomeno che ho notato anche su di me: in una lingua tendo a essere più diretta e pragmatica, mentre nell’altra sono più espressiva e coinvolta emotivamente. Ma è solo una sensazione o c’è qualcosa di scientifico?
Alcuni studi suggeriscono che il cambio di lingua può davvero influenzare la nostra personalità. In un esperimento, ai partecipanti bilingue è stato chiesto di completare un test sulla personalità in due lingue diverse. Il risultato? Le risposte variavano in base alla lingua usata: nella lingua più legata alla cultura dominante del paese, i partecipanti risultavano più estroversi e aperti, mentre nella lingua dell’ambiente familiare erano più introspettivi.
Questo potrebbe spiegare perché chi parla più lingue sente di adattarsi meglio a diversi contesti sociali. Non è solo una questione di lessico: è come se la lingua attivasse un diverso modo di pensare e di comportarsi.
Il bilinguismo modella il cervello
Come cambia la struttura cerebrale?
Essere bilingue non è solo un vantaggio pratico, ma anche un allenamento continuo per il cervello. Gli studi di neuroscienze hanno dimostrato che le persone bilingue hanno una maggiore densità di materia grigia in alcune aree del cervello, in particolare quelle legate alla memoria e al controllo cognitivo.
Ma perché succede? Il cervello di una persona bilingue è costantemente impegnato a gestire due sistemi linguistici: deve decidere quale lingua usare, inibire l’altra e passare rapidamente da una all’altra. Questo esercizio rafforza la corteccia prefrontale, la parte del cervello responsabile del multitasking, della concentrazione e del problem solving.
Il vantaggio cognitivo del bilinguismo
Questa flessibilità mentale porta a una serie di benefici, tra cui:
Migliore capacità di concentrazione: i bilingue sono più bravi a ignorare le distrazioni e a focalizzarsi su un compito specifico.
Maggiore capacità di problem solving: cambiare prospettiva tra due lingue abitua il cervello a trovare soluzioni alternative.
Ritardo dell’invecchiamento cerebrale: diversi studi suggeriscono che il bilinguismo può ritardare l’insorgenza di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer fino a cinque anni.
Pensare naturalmente in più lingue: un vantaggio nella vita quotidiana
Molti bilingue notano che quando devono prendere una decisione complessa, tendono a passare da una lingua all’altra. Questo perché il linguaggio influisce anche sul modo in cui ragioniamo.
Uno studio condotto all’Università di Chicago ha dimostrato che prendere decisioni in una lingua straniera porta a scelte più razionali e meno influenzate dall’emotività. Questo è probabilmente dovuto all’effetto della distanza emotiva: quando pensiamo in una lingua meno radicata nella nostra infanzia, ci basiamo di più sulla logica e di meno sulle emozioni.
Nella mia esperienza, quando devo affrontare una situazione difficile o valutare un problema complesso, mi trovo spesso a riflettere in entrambe le mie lingue madri. È come se avessi due voci interne che mi danno prospettive diverse, e spesso solo combinando entrambe arrivo alla soluzione migliore.
Conclusione: la lingua che parliamo ci definisce
Alla fine di questo viaggio tra linguistica, psicologia e neuroscienze, emerge una risposta chiara: sì, la lingua che parliamo dà forma al nostro pensiero. Non è solo un mezzo per comunicare, ma un filtro attraverso cui vediamo il mondo.
Parlare più lingue significa avere più prospettive, più strumenti per interpretare la realtà e persino più modi di essere noi stessi. Non è un caso se molti bilingue si sentono diversi a seconda della lingua che parlano: la lingua è un’identità, un modo di vivere le emozioni, formare i pensieri e costruire il nostro rapporto con il mondo.
Se hai la fortuna di parlare più di una lingua, prova a prestare attenzione a come cambia il tuo modo di pensare e sentire a seconda della lingua che usi. Forse scoprirai che dentro di te convivono più versioni di te stesso, pronte a offrirti nuovi modi di vedere la realtà.
E tu, hai mai notato come la lingua che parli influenzi il tuo modo di pensare?