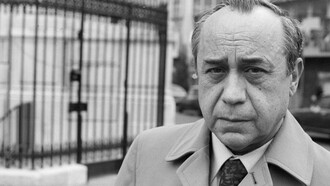L’80 % del patrimonio letterario antico è andato perduto. E questa è una stima ottimista. Il tempo, l’incuria e la furia di fanatici hanno contribuito alla cancellazione di materiale importantissimo, portando solo alla sopravvivenza di autori scelti.
Considerato ciò, è una fortuna che ci siano arrivati, seppur pochi frammenti, le liriche di una delle uniche voci femminili della poesia greca (anche se, forse, non l’unica): Saffo di Lesbo.
Ma chi era Saffo? Cosa sappiamo di lei?
Saffo nacque ad Ereso, sulla costa sud ovest di Lesbo, intorno al 630 a.C., da Scamandro e Cleide. Dei genitori conosciamo solo i nomi, e se per le madri, purtroppo, nell’antichità era normale non sapere altro, su suo padre non sappiamo né che professione svolgesse né le sue preferenze politiche.
Abbiamo più informazioni sui fratelli perché lei stessa ce le fornisce: Larico, il più giovane, era il coppiere nel pritaneo della città, un ruolo molto ambito; Erigio, di cui si conosce solo il nome; e Carasso, il maggiore, era un mercante che dilapidò una fortuna per un’etera, Rodopi.
Stando alla Suda, la poetessa sposò un uomo ricco, Cercila di Andros – notizia però che va presa con le pinze - da cui ebbe una figlia, Cleide, che lei amò molto e a cui dedicò teneri versi.
Intorno al 600 a.C. Saffo fuggì a Siracusa a causa di tensioni politiche a Lesbo, dove tornò un paio di anni dopo. Nell’opera della poetessa però non c’è alcuna traccia di politica, a differenza del conterraneo Alceo: la sua principale occupazione fu l’educazione delle ragazze del suo tiaso, legato al culto di Afrodite.
Il tiaso era un’associazione femminile finalizzata all’educazione di giovani donne di buona famiglia per prepararle al matrimonio: secondo la tradizione, tra Saffo e le sue studentesse nascevano rapporti di grande familiarità, fino al punto di sfociare in vere e proprie relazioni.
Tali rapporti rientravano nella concezione greca dell’erotismo paideutico, che si faceva canale di trasmissione di formazione culturale e morale nel contesto di un gruppo ristretto qual era, appunto, il tiaso.
L’educazione si basava sui valori che la società aristocratica riconosceva come prettamente femminili: amore, grazia, eleganza, canto e danza.
Conosciamo alcuni nomi delle ragazze che frequentarono il tiaso di Saffo: Archeanassa, Atthis, Arignòta, Dike, Eirène, Mégara.
Nonostante l’amore per loro rientrasse in un contesto educativo (molto più documentato in ambito maschile), Saffo attribuiva all’amore anche una funzione totalizzante, di origine divina, rappresentato dalla dea Afrodite.
La dea era la protettrice di Saffo, e in una famosa ode veniva invocata dalla poetessa, e le prometteva che:
chi ora fugge, seguirò […] e ti amerà anche se non vorrà.
L’amore per Saffo era una creatura γλυκυπικρον (dolceamara), procuratore di tormenti e ansie vissuti quasi patologicamente, potente come:
il vento che squassa le querce.
Il frammento che meglio esprime la visione di Saffo sull’amore è il 16 V: il carme individua ciò che è più bello sulla terra, dove ad una visione guerriera, maschile, della vita, la poetessa ne contrappone un’altra, più intima.
Nel carme dice che per lei al mondo non è bella una schiera di cavalieri pronti a combattere, o le navi pronte a partire, ma più semplicemente, la persona di cui uno è innamorato.
Per dimostrare quest’affermazione, Saffo fa l’esempio di Elena: la regina di Sparta aveva tutto, ma nonostante questo, scelse di seguire Paride a Troia, spinta dal fuoco d’amore.
L’amore è un dio, e noi possiamo solo piegarci al suo potere.
Non si sa con certezza la data della morte di Saffo, come morì, o se arrivò ad un’età avanzata. Del tutto leggendaria è però la storia del suo suicidio a causa dell’amore infelice per il traghettatore Faone, che dopo essere stato benedetto dalla dea Afrodite, divenne bellissimo, ma sdegnò gli affetti della poetessa, perché considerata troppo brutta.
Dopo essere stata rifiutata dal giovane, la poetessa si sarebbe buttata dalla rupe Leucade per purificarsi dall’amore infelice. Questo soggetto divenne poi popolare in arte, soprattutto nell’Ottocento. E Faone? Pare che divenne troppo superbo ed orgoglioso della sua bellezza, e venne ucciso dagli uomini di Lesbo.
Alla fine, aveva ricevuto la sua punizione per aver rifiutato quella che per gli antichi era la Decima Musa. Quale fu l’eredità di Saffo? Non bisogna sottovalutare il suo influsso, sebbene noi la conosciamo pochissimo rispetto ai lettori del passato.
Della sua sterminata produzione ci rimangono circa duecento frammenti, alcuni composti da una sola parola, derivati da tradizione indiretta e dai ritrovamenti papiracei nel deserto egiziano.
L’unico componimento integro è il fr.1 V, tramandato da Dionigi di Alicarnasso, e più comunemente conosciuto come Ode di Afrodite.
Già nell’antichità veniva ammirata per la sua maestria; Solone, ascoltando in vecchiaia un carme della poetessa, disse che desiderava solo due cose: imparare il carme a memoria, e poi morire, mentre Catullo trasse ispirazione da lei per la sua Ode della gelosia e ne fu allievo spirituale.
A partire dal XIX secolo, la sua poesia divenne paradigma dell’amore omosessuale femminile, dando origine al termine “saffico”.