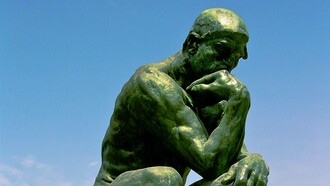Pensate: di tutta la produzione letteraria del mondo antico, a noi sarà pervenuto sì e no il 10%. Questo, tuttavia, facendo delle stime generose.
Purtroppo, i materiali erano deperibili, si doveva fare una scelta di cosa conservare, e durante il Medioevo si scelsero perlopiù opere considerate edificanti, nonostante fossero pagane.
Di fronte a questo stillicidio, è una fortuna che ci sia pervenuta la Pharsalia, il poema epico di Marco Anneo Lucano, nipote del filosofo Seneca. Ancora più sorprendente perché nel poema Giulio Cesare veniva accusato di essere un mostro, e che la morte della Repubblica fu la cosa peggiore che successe a Roma. Marco Anneo Lucano nacque a Cordova il 3 novembre 39 da Marco Anneo Mela, fratello di Seneca. Nel 40, si trasferì a Roma dove divenne allievo di Lucio Anneo Cornuto e crebbe imbevuto di ideali repubblicani, ormai fuori moda dai tempi di Augusto.
Considerata la sua formazione, fu una sorpresa che entrò nelle grazie dell’imperatore Nerone, di cui divenne intimo amico.
Amicizia che tuttavia ebbe una brusca interruzione, pare, per la gelosia di Nerone nei confronti del più talentuoso amico, almeno quanto riportato dagli antichi storici.
Tuttavia, non è da escludere che la fine dell’amicizia fu dovuta sì al lavoro di Lucano, ma nello specifico, all’opera epica a cui si stava dedicando: la Pharsalia.
Dalla critica, spesso la Pharsalia è stata definita come l’anti-Eneide e il suo autore, Lucano, per via di una certa ideologia presente nel poema, come l’anti-Virgilio.
La Pharsalia è un poema epico in cui non è più presente e centrale l’esaltazione e la glorificazione dello stato, ma è presente l’indignazione di Lucano per le guerre fratricide e per l’ingiustizia. Lucano stravolge quello che era il poema epico nella tradizione letteraria, abbandonando i classici moduli della poesia epica: non ci sono interventi divini, quasi come se l’umanità fosse stata abbandonata sé stessa.
In Lucano tutto appare dominato dall’imprevedibile potere del caso, tanto che le vicende prendono avvio senza che alcun dio sia coinvolto e che il Bellum civile è privo di qualsivoglia invocazione alle Muse, che occupa tradizionalmente la sede del proemio e che troviamo nei primi versi dell’Eneide. In molti hanno collegato questa scelta con il drammatico pessimismo di Lucano, dovuto anche all’insuccesso della carriera presso la corte neroniana e alla progressiva disillusione per l’operato del nuovo imperatore.
Il poeta riprende in chiave polemica le situazioni virgiliane, rimproverando a Virgilio di aver lodato Augusto (non certo apertamente, ma tale critica la si può ben desumere dopo il prologo della Pharsalia ), e con sottile ironia (ironia non vista da alcuni critici, che anzi credono che inizialmente l’autore, come Seneca, fosse sinceramente convinto che l’età neroniana fosse una nuova fase della storia romana) loda il principato di Nerone come la vera età dell’oro, in contrasto con quanto Virgilio afferma nell’Eneide. L’esaltazione repubblicana di Lucano è tale da indurlo, in più circostanze, a deformare o storpiare la verità storica per conferire più vivacità e forza ai fatti da lui narrati.
Pompeo, per esempio, appare come una vittima delle circostanze, una nave sballotto lata dalle onde del Fato, che non può far altro che arrendersi e farsi trascinare.
Storicamente, sappiamo che Pompeo fu colpevole almeno quanto Cesare per la guerra civile e che, nonostante l’età, era ancora combattivo, tanto da dare del filo da torcere al suo avversario. Questo però a Lucano non interessava: la licenza artistica lo autorizzava a dare ai suoi personaggi le caratteristiche che preferiva.
Non aveva simpatia per Pompeo, considerato debole. Il vero eroe, se di eroe si può parlare, del poema, era Catone l’Uticense.
Victrix causa diis placuit sed victa Catoni, (ovvero, la causa vincitrice piacque agli dei, ma quella dei vinti a Catone) riassume una figura titanica all’interno del poema, l’unico che potrebbe essere paragonato agli eroi dell’antichità, soprattutto Enea.
Ma a differenza di Enea, Catone non è protetto dagli dèi, e va incontro ad una morte atroce ma, al contrario di quella di Pompeo, degna di lui.