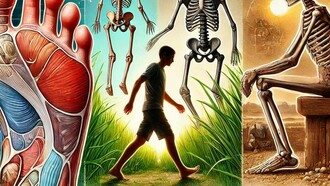Meditare è un verbo che sembra contenere il respiro stesso dell’universo, con le sue molteplici forme e gradazioni. Pronunciare questa parola, sussurrarla a te stesso/a te stessa, condividerla con altre anime in cammino, è come aprire una finestra sul vuoto fertile, su quel tuo luogo interiore dove il pensiero si dissolve per incanto. Nel meditare rimani nel qui-e-ora con te e con la tua coscienza, non separata dall’umanità, interconnessa a tutti gli esseri senzienti, eppure in dialogo intimo con la tua indivisibile, singola, speciale, colorata unicità.
Meditare per curare l’anima
Il termine latino meditari, da cui deriva l’italiano meditare, è un verbo deponente, ha cioè la forma passiva ma il significato attivo: ci parla di esercizio mentale e del corpo, di riflessione, ma anche di un allenamento dell’anima. È un verbo che vibra tra il pensare e il contemplare, tra il ragionare e il sentire, tra lo stare del corpo in ascolto di sé e lo stare dell’anima in ascolto della propria profondità. È un verbo che sembra danzare, ondeggiando nelle dimensioni plurivoche delle persone accostandosi ora a una polarità ora all’altra del transito terrestre. Siamo molti esseri in noi stessi, siamo unitas multiplex, come ci ha insegnato maestro Edgar Morin. Siamo grumi di contraddizioni, paradossi in cammino, somme di et-et, anime alla ricerca di sé.
Il latino meditari ha a sua volta un genitore: è un verbo frequentativo di medēri, con il significato di ‘curare’, ‘provvedere’, ‘rimediare’. Da quel verbo in italiano sono derivate tante parole connesse alla medicina, che è appunto l’arte del curare: medico, cioè colui che cura, medicare, medicinale, rimedio, in latino remedium, che in senso stretto significa per l’appunto ‘medicinale’ ma che estensivamente indica ogni mezzo utile per impedire o far cessare un danno, un inconveniente, per risolvere una questione intricata o una difficoltà
E da quel medēri è derivata anche la meditazione che ha quindi una stretta attinenza con il concetto di cura. Meditare significa quindi in primo luogo prendersi cura di sé e delle altre persone a cui rivolgi il pensiero meditante. Meditare è guarire dalle ferite che ti segnano l’anima o – se proprio non guarire, perché alcune ferite profonde restano indelebili – quanto meno cercare di guarire, alleviando il male che provi dentro di te e accostando ai tagli e ai graffi qualche balsamo profumato o qualche garza protettiva, qualche parola, qualche gesto o qualche persona che ti fa stare bene.
Nella meditazione si trova traccia del verbo greco antico médō, che voleva dire ‘ho cura’, ‘penso a’, ‘mi prendo cura’, ‘mi do il pensiero di’, ‘ho in mente’. La radice di questo verbo è indoeuropea, *med, comune a molte delle lingue parlate dall’oceano Atlantico al Gange. Possiamo trovare connessioni tra il médō (e quindi il prendersi cura) e altre tre parole parlate nella Grecia classica: métron, mēdomai e mētis.
Il sostantivo métron voleva dire ‘misura’ e anche il mezzo tramite il quale si effettuano le misurazioni, da cui l’italiano metro quale unità di misura, con i suoi multipli e sottomultipli come kilometro e centimetro. La parola métron da ‘misura’ ha poi iniziato a significare la ‘giusta misura’, quindi il ‘giusto mezzo’, la ‘proporzione’, il ‘limite’ che non deve valicato per non commettere hybris, cioè ‘tracotanza’. Nella meditazione si comprendono i propri limiti, ci si confronta con le proprie luci e le proprie ombre, ci si allontana dal mondo per rimanere nel mondo. Nel meditare abbiamo modo di conoscere il giusto mezzo che significa anche apprendere ciò che sta agli estremi, oltre quella buona misura, estremi che pure ci appartengono anche se fanno male e vorremmo scacciare da noi.
Il verbo mēdomai significava ‘penso’, ‘medito’, ‘considero’ e nella forma transitiva ‘immagino’, ’escogito’, ‘macchino’, ‘preparo’. Meditare è anche immaginare, lasciare che le immagini attraversino la mente e scorrano su di essa. Meditare è accogliere le immagini che si affollano come nuvole transeunti in quello strano pannello iridescente che chiamiamo mente.
La mētis era la ‘saggezza’ pratica, concreta, incarnata, il ‘senno’ e anche la ‘prudenza’. I greci antichi avevano un tale rispetto e reverenza per questa forma di saggezza così diversa dalla saggezza della speculazione e della razionalità pura da averla trasformata in una dea, Mētis appunto, figlia di Oceano e di Teti. Nel meditare attingiamo allo spirito buono di Mētis. Dopo aver meditato possiamo invocarla perché ci porti saggezza e pensieri pacificati.
La meditazione si fa corpo
La meditazione è spesso percepita come un’attività mentale, un esercizio della coscienza, una pratica dell’introspezione. È così, è anche così. Ma questa visione è parziale.
La meditazione è anche — e forse soprattutto — un’esperienza incarnata. Il corpo non è un ostacolo alla meditazione, ma il suo tempio, il suo strumento, il suo luogo sacro. Il pensiero, per meditare, deve farsi corpo, talvolta corpo in stasi, talvolta corpo in movimento. Il pensiero, per meditare, deve scendere dal cielo delle idee e radicarsi nella terra del respiro, con il respiro, per il tramite del respiro.
Il respiro è il primo maestro. È il ponte tra il conscio e l’inconscio, tra il dentro e il fuori, tra il visibile e l’invisibile. Ogni inspirazione è un ritorno, ogni espirazione un lasciar andare. Respirare consapevolmente è già meditare. È già essere presenti. È già abitare il momento. Controllare il respiro (prāṇāyāma) significa controllare la mente, le emozioni, la vita stessa.
Nel nostro transito terrestre, compiamo in media 700 milioni di respiri. Settecento milioni. In ognuno dei settecento milioni di respiri, entriamo, restiamo, lasciamo andare, restiamo, in un circolo che appare senza fine ma che una fine, in realtà, ha (come tutto nella nostra impermanenza). Il corpo in meditazione non è immobile per costrizione, ma per libertà. La postura — seduta, eretta, distesa — è un gesto simbolico. Sedersi a gambe incrociate come avviene quando pratichi yoga, con la schiena dritta, le mani appoggiate alle cosce, gli occhi socchiusi, è un atto di dignità. È dire al mondo: “Sono qui. Sono presente. Sono intero”. Non sempre sono integro (perché la vita sa anche sbrecciare l’anima) ma intero sì. La postura, quale che sia, è il linguaggio silenzioso della meditazione. È il modo in cui il corpo dice sì alla vita e quindi all’impermanenza della vita (anicca, in lingua pali).
Le pratiche contemporanee, come la mindfulness, hanno riportato l’attenzione al corpo. Jon Kabat-Zinn, fondatore della Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), ha definito la meditazione come “prestare attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante.” Questa definizione è rivoluzionaria perché sposta il focus dalla trascendenza alla presenza. Non si tratta di fuggire dal corpo, ma di abitarlo. Non di elevarsi, ma di radicarsi. Per come si può, con gli strumenti che si possiedono, con le abilità che di volta in volta ci ritroviamo ad avere. La scansione corporea, il body scan, una delle pratiche fondamentali della mindfulness, consiste nell’osservare ogni parte del corpo, una alla volta, con attenzione e gentilezza. Dalle dita dei piedi alla sommità del capo, ogni zona viene esplorata, sentita, accolta. È una meditazione che ti cura, che ti ascolta, che ti riconosce. Il corpo diventa mappa, territorio, compagno di viaggio e di cammino.
Anche le tradizioni orientali hanno sempre integrato il corpo nella meditazione. Nel buddhismo zen, la postura è fondamentale. Zazen, la meditazione seduta, è una pratica rigorosa che ho avuto la fortuna di praticare in alcuni monasteri zen: schiena eretta, mento leggermente abbassato, mani in mudra, sguardo rivolto verso il basso. Il corpo è il contenitore della mente, il veicolo della consapevolezza. Eitei Dōgen, maestro zen del XIII secolo, fondatore della scuola zen Sōtō, scriveva: “Sedersi in zazen è già illuminazione”. Sedersi con consapevolezza è già illuminazione. Mangiare con consapevolezza un chicco d’uva passa o la cena che abbiamo preparato e che sta sul nostro piatto è già illuminazione. Osservare in silenzio è già illuminazione. Vivere con pienezza le proprie emozioni è già illuminazione. Rispettare la cena, rispettare il cibo nel piatto, rispettare le emozioni altrui è già illuminazione.
Nello zazen meditare è dunque sedersi. È fermarsi. È respirare. È ascoltare. È lasciar andare. È accogliere. Non serve essere monaci, mistici o asceti. Basta essere sinceri e non giudicanti. Basta voler ascoltare. Basta voler tornare a casa. Ogni giorno, qualche minuto di silenzio può cambiare la qualità della nostra presenza. Può trasformare il modo in cui guardiamo, parliamo, camminiamo, viviamo.
La pratica della meditazione è semplice, ma non facile. Richiede disciplina, costanza, dedizione. Richiede il coraggio di affrontare il vuoto, il silenzio, l’ombra. Richiede la volontà di non fuggire, di non distrarsi, di non riempire. Ma proprio in questa semplicità (che è sempre sinonimo di complessità) risiede la sua potenza. Meditare oggi diventa quindi un atto politico, poetico, spirituale. Diventa un dire no alla distrazione, sì alla presenza. Diventa un dire no alla frammentazione, sì all’unità. Diventa un dire no alla superficialità, sì alla profondità.