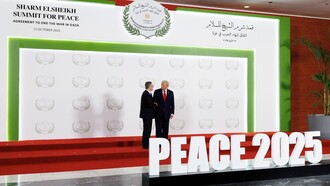Teddy non parla un inglese formale, ma si rivolge ai suoi amici parlando come un qualunque bambino, quindi insegna un inglese moderno, colloquiale ed entusiasmante, che traduce il vissuto quotidiano con un idioma semplice e diretto. Per questo, esso viene più facilmente ritenuto dal bambino della Scuola dell’Infanzia e in modo del tutto naturale.
La mia esperienza
La mia esperienza di apprendimento della lingua inglese ha inizio nel lontano 1975, quando mi iscrivo alla neonata prima classe del Liceo Linguistico Bambin Gesù parificato di San Severino Marche e dove, grazie al professor John Morley, proveniente dall’Università di Leeds in Inghilterra, allora in forza presso il Laboratorio Linguistico dell’Università di Camerino in qualità di lettore madrelingua, ho avuto accesso al metodo di apprendimento audio-visivo, rivoluzionario per l’epoca. Tale metodo, infatti, mi ha dato l’opportunità di apprendere velocemente una lingua con caratteristiche morfosintattiche non propriamente assimilabili agli studi linguistici da me compiuti fino ad allora (francese e latino), l’inglese, appunto, una lingua di origine prettamente germanica, anziché romanza.
Infatti, in un’epoca in cui non si concepiva altro metodo che quello grammaticale per l’apprendimento L2, che comunque muoveva i primi passi solo a partire dalla scuola media inferiore, escludendo completamente la scuola primaria, il metodo audiovisivo condotto da un professore universitario madrelingua ha per me fatto la differenza in termini fonetici, glottologici e alfabetici.
In pratica, nessun inglese studia la sua lingua a scuola su basi grammaticali, al pari di quanto invece ancora oggi avviene in Italia, essendo la grammatica a noi nota quella che gli italiani o gli stranieri in generale hanno “coniato” per apprendere una lingua che risulta essere di suo già molto scarna dal punto di vista del costrutto.
I supporti didattici del metodo audiovisivo erano già libri dove la lezione, basata sull'imitazione e memorizzazione di dati linguistici con l'apprendimento considerato come acquisizione di abitudini, era svolta per “units”, corredati da immagini corrispondenti ed esercizi strutturali, i cosiddetti “pattern drills”, basati sul principio stimolo/risposta – conferma/correzione che, coadiuvati da audiocassette dell’epoca, erano ascoltabili e ripetibili individualmente in sede di laboratorio linguistico, macchinario che nasce nel dopoguerra e che oggi è stato aggiornato dai più moderni software tecnologici.
Il metodo audio-orale, diffuso negli Stati Uniti a partire dagli anni '50, prende spunto dalle teorie dello strutturalismo comportamentistico di Bloomfield e Skinner, a cui si accenna anche più avanti. Questo metodo utilizza anche l'analisi contrastiva, che mette in risalto eventuali interferenze negative causate dalla lingua madre e che possono essere corrette tramite esercizi mirati, distinguendo le quattro abilità linguistiche di speaking, listening, writing e reading1.
Breve cenno sul ruolo educativo e sociale della Scuola dell’Infanzia
Le finalità della Scuola dell’Infanzia, come evidenziato dal Documento Ministeriale aggiornato, sono rivolte a promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza, avviandoli alla cittadinanza democratica. In questo è fondamentale l’interazione tra scuola e famiglia, che rimane, quest’ultima, l’agente educativo primario del bambino. Pertanto, il bambino nella fascia di età prescolare (3/6 anni) acquisirà competenze di preparazione alla scuola primaria in un ambiente sereno che gli consoliderà fiducia in sé e negli altri, imparando a scoprire l’altro da sé attraverso le pratiche di dialogo e di ascolto. L’obiettivo è quello d’iniziare ad affrancarsi dall’egocentrismo infantile in visione di un armonico sviluppo psico-fisico, per porre le basi alla costruzione di un individuo attento alla convivenza democratica e alle regole della vita comunitaria.
In questo contesto, la conoscenza delle lingue straniere non può più considerarsi un fine, bensì un mezzo. Come cittadino europeo è indispensabile conoscere almeno una lingua comunitaria oltre la propria madrelingua, per poter far fronte alle sfide della società multietnica e multi-linguistica che si muove nell’ambito di un’economia globale.
Sebbene lo studio di una lingua straniera sia sempre più presente nella scuola italiana, a differenza di altri Paesi comunitari, come ad esempio l’Olanda o la Svizzera, il nostro Paese è in questo ancora neofita, in quanto l’ordinamento scolastico non considera la lingua comunitaria al pari della madrelingua, a parte le provincie autonome di lingua tedesca, esprimendola ancora in L2, prevalentemente inglese. Come indicato dal testo aggiornato del Decreto Ministeriale 2012 “I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi”. L’esigenza di introdurre l’insegnamento di una seconda lingua fin dalla Scuola dell’Infanzia nasce dal desiderio di sfruttare l’enorme potenzialità linguistica che il bambino in età prescolare possiede. Tale precocità deve essere sfruttata come condizione favorevole all’insegnamento delle lingue straniere.
È, infatti, scientificamente dimostrato che l’età compresa tra i tre e i cinque anni sia il periodo più vantaggioso per l’apprendimento linguistico ed è, al tempo stesso, stato appurato che l’insegnamento di più lingue straniere ha una ricaduta positiva su ognuna di essa, oltre che sullo sviluppo cognitivo dell’intero processo di crescita evolutiva, mentre in età adulta ci si dimostra meno capaci nell’ambito dell’acquisizione linguistica.
Giocare in inglese: come la L2 entra nella Scuola dell’Infanzia
In generale, la comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, ma richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le già sopracitate quattro dimensioni e tra le diverse lingue, a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. È ormai noto che non si possa insegnare una lingua senza tenere conto della cultura ad essa associata. In particolare, quando i bambini hanno il primo “contatto” con una L2, è importante mostrare loro che il nuovo idioma da apprendere non è solo un concetto astratto, ma è associato ad una cultura, a delle abitudini, usanze, festività, ecc. Dal momento che non è parlata soltanto in Inghilterra, la lingua inglese, in particolare, è connessa a diverse culture come quella americana, canadese o australiana e il “contatto” con essa, dunque, dovrà tener conto dei diversi aspetti culturali delle varie civiltà in cui l'inglese è madrelingua.
In età prescolare, i bambini hanno un enorme potenziale nei confronti dell'apprendimento della seconda lingua. Tenendo conto che essi a questa età hanno un'attitudine innata a voler conoscere e imparare sempre di più, l'insegnante di L2 ha il vantaggio di trovare un dinamico substrato su cui lavorare. Il suo compito sarà, quindi, quello di utilizzare la loro voglia di conoscere per avvicinarli alla nuova lingua, considerando che l'istruzione della Scuola dell’Infanzia non ha la pretesa di insegnare la lingua secondo i classici obiettivi e le metodologie abituali, ma, al contrario, si prefigge quello di offrire un'esperienza e un apprendimento linguistico.
Il processo di acquisizione fa imparare la lingua materna in modo naturale e inconscio, mentre l'apprendimento di una seconda lingua diventa il processo mediante cui apprendere elementi linguistici in modo naturale, inconsapevole, coinvolgendo i bambini al fine di far scoprire, osservare, capire ed imparare. Ed ecco, quindi, che lo studio della L2 inglese alla Scuola dell’Infanzia, al pari dello studio della L2 italiano nel caso di bambini stranieri, deve avvenire iniziando, in modo innato, con un vero e proprio apprendimento. Infatti, i metodi e le tecniche per insegnare L2, sia inglese che italiana, sono tutti legati ad atti comunicativi, in quanto non si devono insegnare, in questo periodo scolastico, le regole grammaticali, bensì limitarsi ai vocaboli e alla fonetica.
Per raggiungere i migliori risultati, si può ricorrere all'utilizzo dei codici musicale e gestuale, da mettere in pratica mediante il gioco, ma anche del codice verbale, come suggerito dal metodo TPR (Total Physical Response) elaborato da James Asher 2, che prevede un input verbale sotto forma di comando agli studenti, che comprendono e compiono un’azione in risposta al comando verbale, ideale nelle prime fasi dell’apprendimento. Scopo di questi metodi è quello di sviluppare e preferire l'abilità orale e non occuparsi dell'apprendimento scritto. Sotto forma di gioco, quindi, immagini di video musicali e ritmati, fotografie chiare, giochi di ruolo, dialoghi, schede, disegni da colorare e molte altre attività potranno interessare e attirare l'attenzione, senza mai annoiare i piccoli studenti. L'ascolto, la ripetitività e la ciclicità delle immagini, i dialoghi, la ripetizione dei vocaboli e la mimica avranno come obiettivo quello di far assimilare un bagaglio notevole di vocaboli stranieri. Le scuole bilingue e anche l'asilo nido bilingue mettono in pratica con notevole successo queste metodologie e tecniche, facendo della metodologia comunicativa il loro punto di forza.
Lo studio dell'inglese iniziato al nido infantile e continuato alla Scuola dell’Infanzia, per esempio, diventa così la base essenziale per affrontare lo studio grammaticale che si presenterà per la prima volta alla primaria. A conferma di ciò e nel principio della continuità scolastica, si era già espresso il Progetto Lingua 1999/2000, che include lo studio di una lingua straniera, l'inglese, a partire dal secondo anno di frequenza della “scuola materna” o nel momento in cui il bambino ha raggiunto stabilità di rapporti e chiarezza di comunicazione con l'adulto e i pari , con l'obiettivo principale della “costruzione condivisa, tra Scuola dell'Infanzia e primaria, di un percorso di lingua straniera unitario e continuo”3.
Metodo e didattica
I bambini hanno bisogno di essere incuriositi, quindi per le prime nozioni s’inizia utilizzando un metodo accattivante, con delle immagini colorate e suoni. Ai tempi in cui le mie figlie erano in età pre-scolare, avevano funzionato molto bene le videocassette del corso Magic English, per riproporre loro un mondo a cui erano affezionate e, in tal modo, avevano iniziato ad orecchiare la lingua mentre imparavano le prime cose.
Moltissime sono le cose che è più facile apprendere quando si è ancora molto giovani e imparare una o due lingue straniere è oggi certamente indispensabile per l’avvenire dei ragazzi. In particolare, in gran parte d’Italia, a differenza di alcuni altri Paesi comunitari, l’interculturalità è un’esperienza che solo in tempi recenti ha iniziato a conoscere una vera e propria integrazione. Questo fa spesso la differenza sulla necessità di apprendimento della L2 inglese e/o francese, a differenza delle precedenti generazioni di cittadini italiani.
Bilinguismo precoce: un dono da piccoli
Con l’etimologia di “insegnare una lingua straniera”, si andrebbe ad impostare un “programma mentale” con in rilievo la forza delle parole “insegnare” e “straniera”, dove “insegnare” presuppone una preoccupazione con il prodotto da trasmettere, mentre “straniera” evoca una situazione di distanza e, per effetto di una tradizione connessa, un apprendimento piuttosto formale. Tutti e due i termini danno assieme l’idea di una disciplina a sé stante, priva di qualsiasi forma d’interazione. In realtà, non credo a questa cognizione perché, data la mia esperienza personale anche di allieva, ritengo che per i bambini di età pre-scolare sia spontanea la capacità di interiorizzare una lingua diversa da quella materna.
Proprio per tale convincimento, nella mia esperienza scolastica di didattica applicata, ho usato la seguente metodologia di base che individua l’oggetto da insegnare non più in termini di pseudo “regole grammaticali”, bensì in azioni comunicative, che portano a “far capire” l’inglese ai bambini, piuttosto che “apprenderlo per insegnamento”. In tal modo, ho tenuto conto degli aspetti della personalità del bambino, sfruttando tutti i codici espressivi di cui egli dispone: verbale, musicale e mimico gestuale, dove le abilità orali hanno la netta priorità su quelle scritte, producendo un apprendimento più immediato.
Questo sfondo teorico permette di sviluppare un progetto basato sulla metodologia ludico-teatralizzante, dove il gioco è il veicolo della conoscenza e dove, attraverso la drammatizzazione di una conversazione, il dialogo viene ascoltato, ripetuto, mimato e cantato dal bambino.
Obiettivo specifico di questa metodologia è stato quello di far assimilare al bambino un bagaglio espressivo di base, da trasferire nella propria struttura linguistica profonda e, attraverso la sensibilizzazione di ogni singolo bambino verso un codice linguistico diverso dal proprio, ho cercato di portare ad un apprendimento attivo, promuovendo in tal modo l’obiettivo formativo di base che invita a riflettere sulla lingua, confrontando e sperimentando lingue diverse, ai fini di riconoscere ed apprezzare la pluralità linguistica.
Pertanto, in prima fase, ho suscitato nei piccoli alunni l’interesse verso la nuova lingua, creando le condizioni favorevoli ad un totale coinvolgimento ed attuando le varie attività con entusiasmo e curiosità. In tale contesto, il gioco è rimasto “la strategia di sfondo” delle attività, mentre è stato attuato il potenziamento delle capacità di ascolto, di attenzione e memorizzazione, attraverso situazioni di role-playing (attività di simulazione che mette in scena didatticamente situazioni tipiche della vita attraverso il dialogo guidato) e l’utilizzo di immagini (flash-cards), grazie alle quali ogni bambino ha appreso un nuovo vocabolo visualizzandolo e ascoltandone la pronuncia, a cui ha fatto seguito la sua riproduzione in forma verbale: l’immagine associata ad un fonema che produce, pertanto, l’apprendimento linguistico attivo di cui sopra.
Negli anni scolastici dal 2012/2013 fino al 2021/2022, svolti in sezioni miste e omogenee con prevalenza di alunni frequentanti il terzo anno di scuola dell’infanzia presso il plesso Luzio di San Severino Marche, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “P.Tacchi Venturi”, ho seguito le indicazioni del Progetto per l’insegnamento di L2 inglese per lezioni della durata di 45 minuti cadauna, condotte due volte a settimana, secondo il calendario scolastico. I gruppi erano costituiti per fasce di età 3-4-5 anni ed il programma, su tre moduli diversi, sviluppato per livelli:
Bambini di 3 anni programma introduttivo.
Bambini di 4 anni programma di consolidamento.
Bambini di 5 anni programma avanzato.
Esperienza sul campo
Attività didattica con applicazione del metodo Burattingegno
Questa attività era rivolta all’insegnamento di L2 inglese in sezioni omogenee di 5/6 anni e in sezioni miste di 3/5 anni.
Gli obiettivi principali erano quelli di far conoscere le fondamentali espressioni di lingua inglese di base, come salutare, presentarsi, accomiatarsi. L’attività consisteva in presentare il puppet “Teddy Bear” per insegnare il saluto di arrivo tra pari “Hello!” e come chiedere il proprio nome. I materiali usati erano stati le flashcards e la scatola Mistery Box, da cui fuoriesce sempre il puppet e gli oggetti che lo rappresentano al meglio, come i suoi giochi, i suoi abiti ecc.
L’inizio dell’intervento in sezione, come nell'esempio pratico qui riproposto, prevedeva la canzoncina di apertura “Hello, Hello, Hello, how do you do?” con l’elemento mediatore Teddy Bear “puppet", seguita dall’animazione corporea: canzone mimata, sulle note di “Fra Martino”, Teddy ha chiesto a ciascun bambino “What’s your name?” di volta in volta, ciascun bambino ha risposto sulle stesse note “My name’s .., my name’s ..”. Si stimola la cooperazione, attivando il coro a due voci (divisione del gruppo-sezione): un coro domanda con toni più alti e ritmati, mentre l’interrogato risponde cantando il suo nome (drammatizzazione ludica).
Si prosegue con giochi motori individuali e di squadra, avviando il girotondo in inglese (Ring, ring a roses..). I bambini formano 2 gruppi concentrici che ruotano in senso opposto. Quando la canzoncina termina, i bambini si fermano tenendosi per mano e, a turno, si salutano chiedendo e rispondendo il proprio nome in inglese.
Per la fase di elaborazione di questo esempio di attività pratica, i bambini passavano i contorni della propria mano su cartoncino rosa, attaccando le lettere adesive di “Hello” su un lato e di “Goodbye” sull’altro (preparate dall’insegnante).
Nella chiusura di quest'attività, si cantava la canzoncina “Goodbye children, time to go..”, mentre Teddy Bear “puppet” seduto sul trenino salutava tutti i bambini, che a loro volta lo salutavano in inglese con la manina.
Progettazione di un intervento in sezione con l’uso della LIM
Qusta attività è rivolta all’insegnamento della L2 inglese in sezioni omogenee di 5/6 anni e miste di 3/5 anni. Gli obiettivi sono: conoscere le fondamentali espressioni di lingua inglese di base, relative alla famiglia, con l’uso interattivo della lavagna LIM. L’attività prevede: presentare su Ppt (Power Point) la famiglia del puppet Teddy Bear per imparare a nominare i componenti della famiglia (mamma, papà, sorella, fratello), in concomitanza con la festa del papà (il quale riceverà in regalo una cartolina “virtuale” fatta dal suo bambino/a). Anche in questo esempio di attività pratica si usava con successo la Mistery Box, da cui fuoriusciva sempre il puppet e i suoi oggetti ludici.
L’intervento in aula LIM & Animazione corporea inizia con una canzoncina mimata di apertura “Hello, hello, hello, hello how do you do?” con l’elemento mediatore puppet. Attraverso l’attività didattica guidata su lavagna LIM con le slides, Teddy chiede di volta in volta “What’s your name?” e la cooperazione si attiva facendo scrivere a ciascun bambino il proprio nome sulla lavagna interattiva.
Per la fase di elaborazione grafica dell'attività, si continuava la presentazione della famiglia di Teddy e i bambini imparavano a nominare tutti i componenti della famiglia, fino alla costruzione del bigliettino per la festa del papà, per questo esempio di attività, dove ogni bambino disegnava il proprio viso e quello del papà all’interno delle due lettere D colorate di rosso dell’abbreviazione familiare DAD.
La fine dell’intervento prevede una canzoncina di saluto e la chiusura dell’attività “Goodbye children, time to go”, con il puppet che saluta dal trenino.
Ad ogni pratica fonica o grafica fa seguito una valutazione oggettiva, basata sulla corretta pronuncia e riproduzione della parola scritta, usando le letterine adesive precedentemente preparate dall’insegnante. Ugualmente, per tutte le attività eseguite di volta in volta è fondamentale gratificare la buona riuscita del risultato ottenuto confermando con “Good”!, “Very good”!, poiché l’incoraggiamento e la gratificazione sono molto importanti nel processo di apprendimento, specialmente nella fascia di età pre-scolare.
Conclusioni
Maturando una riflessione più approfondita sulle caratteristiche della Scuola dell’Infanzia, soprattutto in termini di utenti e delle loro famiglie, posso affermare che le difficoltà affrontate quasi ogni giorno hanno accresciuto piano piano in me la consapevolezza che lavorare con “materiale umano” non abbia solo “addolcito” la mia professionalità, ma abbia fortemente contribuito ad aumentare ancora di più il mio senso di responsabilità e del dovere, già maturati in oltre 30 anni di lavoro alle dipendenze di una rinomata ditta privata e, forse, anche un po' di nuova competenza nella vita.
Entrare nell’ottica di un mestiere che si conosce solo attraverso i libri non è facilissimo, ma la mia volontà è stata meravigliosamente supportata da tutti i fantastici piccoli alunni, che hanno lasciato un solco nel mio cuore, così come io spero di aver lasciato una traccia significativa nel loro.
Per circa 10 anni, ho cercato di svolgere il mio ruolo al massimo delle mie possibilità, mi sono documentata e aggiornata, provando a mettere in pratica tutto il bagaglio della mia conoscenza e, infine, al commiato da questo mondo fantastico ho compreso il vero significato di molte parole studiate sui libri di scuola, interiorizzando definitivamente la verità di quell’espressione che “fare l’insegnante non è solo un mestiere, ma è una vocazione”, sperando di aver contribuito anche spiritualmente alla crescita dei miei piccolissimi alunni bilingue, i quali sperimenteranno nella vita questa loro ricchezza di un’esperienza di acquisizione linguistica e di apprendimento linguistico precoci.
Bibliografia
1 Università degli Studi di Ferrara – Corso di Formazione per Insegnanti 2007/2008 - La classe plurilingue e pluriculturale – Dott.ssa Stefania Rocco.
2 Professore emerito di psicologia alla San José State University in California.
3 Progetto Lingue 2000.
Intervista a Z. Dienes in “psicologia contemporanea”, n. 32, marzo-aprile 1979.
Z.Dienes, Logique et jeux logiques.
L.Mantilleri, Avviamento al pensiero logico, La Scuola, Brescia.
A.R.Lurja, Il bambino ritardato mentale, Zanichelli, Bologna, 1978.
J.Piaget, La formazione del simbolo, La Nuova Italia, Firenze.