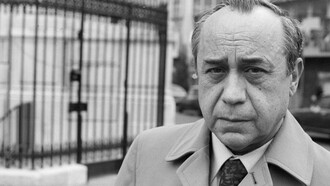I tratturi sono tracciati viari della transumanza utilizzati sin dai tempi antichi per spostare le greggi e cercare pascoli adatti all’allevamento. Transumanza deriva dal verbo attraversare ed è quello che i pastori facevano assieme alle loro greggi ed è composta da trans, oltre, e da humus che vuol dire terra perché questa attività si basava sulla mobilità che richiedeva spostamenti in alcuni periodi dell’anno.
La pastorizia era un’attività caratteristica del popolo sannita ed era alla base della sua economia e rappresentava un bene prezioso da cui trarre ogni beneficio sotto ogni aspetto possibile vendendo carne, prodotti caseari ma anche lana. Per questo motivo per avere degli animali adatti all’allevamento era fondamentale spostarsi compiendo migrazioni stagionali per raggiungere pascoli floridi quindi garantire agli animali la giusta alimentazione.
Lo spostamento delle greggi avveniva per trovare il clima adatto alla vita delle greggi, nei mesi di maggio i pastori spostavano il bestiame verso nord per cercare erbe montane che dopo lo scioglimento dei ghiacci risultavano più verdi e rigogliose e nel mese di settembre si scendeva a sud per avere pascoli adatti e non ghiacciati. Questi viaggi garantivano ai pastori del buon cibo per il proprio bestiame.
In alcuni territori comunali è possibile vedere ancora oggi le piste erbose sulle quali avveniva la transumanza, sono identificabili come tratturi le strade erbose che venivano fiancheggiati da cespugli o muretti e in alcuni tratti nel corso del tempo sono rimasti invariati. La larghezza era solitamente fino a 116,6 metri che equivalevano a 60 passi napoletani. Il collegamento dei piccoli centri con i tratturi più impostanti avveniva attraverso i tratturelli che avevano dimensioni minori dai 18 metri ai 30 metri.
La strada della transumanza non era completamente isolata ma era una strada che consentiva il commercio, per questo motivo lungo accanto ad essa sorgevano strutture sacre o profane per scambi commerciali con le popolazioni del luogo. Queste strade erbose sono uno dei primi segni che le attività dell’uomo lasciano sul territorio e con il passare dei secoli costituirà la base per la futura viabilità e il sistema di rapporti commerciali e politici che si avranno nel territorio sannita.
In epoca sannita la transumanza aveva un vero sistema di controllo costituito da fortificazioni poligonali che servivano come luogo di rifugio in caso di pericolo, come ricovero per gli spostamenti più lunghi o addirittura venivano usate in alcuni periodi storici come sbarramento per le vie di accesso al Sannio. Queste fortificazioni erano collocate su alture con distanza variabili in base alla conformazione del territorio e in modo da costituire un collegamento con le altre opere. Solitamente la distanza era di circa 2500 – 3000 metri consentendo la comunicazione tra i forti adeguata la periodo storico.
Anche i romani ritenevano la pastorizia di vitale importanza e ne fecero un’attività economica di particolare importanza. I tratturi con i romani divennero delle vere vie di comunicazione, al punto da sostituire il tracciato di tratturi con nuove strade come, ad esempio, la Minucia che venne trasformata dal console Marco Minucio Ruffo nel 110 a.C. dal quale ne prende il nome.
I tratturi con il passare del tempo videro nascere agglomerati urbani e villaggi che spesso avevano un carattere temporaneo perché servivano per lo più come ricovero stagionale dei pastori e delle loro greggi. Sul loro tracciato nacquero anche gli stazzi cioè ricoveri adibiti alla permanenza stagionale dei pastori e delle greggi. Parti essenziali dello stazzo erano: il recinto (per contenere il bestiame); la casetta (rifugio per il pastore); una casa di servizio (non sempre presente). Un’altra caratteristica degli stazzi era la tecnica di costruzione a secco della casetta che in base alla reperibilità di materiali naturali aveva una diversa forma o grandezza. Lo stazzo aveva dimensioni ridotte perché consentiva una veloce manutenzione per essere riutilizzato in breve tempo.
Alfonso V D’Aragona, re di Napoli, istituì nel 1447 La Regia Dogana della Mena delle pecore di Puglia riprendendo la Mesta spagnola prima associazione di proprietari ovini medievale. La dogana aveva il compito di organizzare la pastorizia nel Regno di Napoli utilizzando i pascoli della Regia Corte o di privati se attraversati dai tratturi. Un’altra importatene funzione della Dogana era acquistare cibo per le greggi e concederli ai padroni in cambio del pagamento di un canone annuo in questo modo gli spostamenti erano agevolati e tutelati.
I tratturi principali, visibili ancora oggi, sono cinque e sono: Pescasseroli-Candela che parte dall’Abruzzo attraversa il Sannio Campano e arriva nella Daunia; Lucera-Castel di Sangro che dalla valle del Volturno passa nel Fortore e arriva a Lucera; Celano-Foggia passa nelle valli del Trigno e del Biferno per arrivare nelle pianure della Daunia; L’Aquila-Foggia attraversa il Molise e raggiunge la Daunia chiamato Tratturo Magno segue l’andamento della costa adriatica; Centurelle-Montesecco diramazione del Tratturo Magno ma mantiene un percorso interno.
Il tratturo Pescasseroli-Candela è quello che interessa il territorio dell’alto Sannio e i comuni in provincia di Benevento. I tratturelli che collegano i vari centri abitati alla via di transumanza sono tanti e spesso hanno utilizzato percorsi che venivano percorsi già nell’antichità. Spesso erano vere e proprie strade con la presenza di una pavimentazione e avevano bisogno di un controllo da parte dello stato per garantire la loro sicurezza. Quello che però è oggi visibile non è che una parte della vera rete tratturale, durante l’Ottocento gran parte di questi percorsi vennero utilizzati per ampliare i centri abitati, per l’agricoltura o per costruire delle vere e proprie strade.
Nel 1858 la transumanza veniva regolamentata attraverso veri e proprie leggi, con il decreto 14 che conteneva le nuove norme sulla loro amministrazione e sulla direzione che spettava al Tavoliere delle Puglie che aveva il compito di vigilare in modo che tutti i pastori potevano accedere gratuitamente. Questa legge garantiva a chi vi transitava il diritto di denunciare in caso di inaccessibilità della strada ma anche se il tratto da percorrere era gestito male. Altra legge importante per la storia dei tratturi è Il Regio Decreto n.3244 del 1923 che determina il passaggio di proprietà di queste aree al Ministero delle Finanze e dell’Agricoltura dando la possibilità ai privati di rendere legittime le opere abusive. Importanti disposizioni vengono introdotte da questa legge che prevedeva le concessioni di pascolo, di taglio della legna, di deposito materiale e di transito di veicoli.
Dopo tante attenzioni per il riscontro economico che ne derivava queste strade verdi sono state completamente abbandonate e quasi dimenticate a causa dell’evolversi delle tecnologie utilizzate nell’allevamento. Solo verso la fine del Novecento si è presa consapevolezza che i Tratturi sono testimonianza della storia e della nostra economia e si inizia a pensare alla loro conservazione. Viene fatta la “Legge Regionale del 11 Aprile 1997, n° 9” che ha lo scopo di tutelare, valorizzare e gestire il demanio tratturi ricadenti nel Molise istituendo il Parco dei Tratturi del Molise. Secondo questa legge:
I Tratturi in quanto beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utili all’esercizio dell’attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico della rete tratturale denominato “Parco dei Tratturi del Molise".
Per la rete tratturale nel 2006 è stata attivata la candidatura a Patrimonio sia materiale sia immateriale dell’umanità dell’UNESCO dal Ministero per L’Ambiente con le regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Dalle analisi effettuate il 15% della rete tratturale è perfettamente conservato ma il 12% è completamente perso per questo le opere di conservazione o di recupero possono garantire la vita di una parte di queste strade fatte d’erba creando un polo d’attrazione turistica accessibile supportando lo sviluppo economico e culturale di aree interne e soprattutto conservano un documento materiale che ci consente di conoscere meglio le nostre radici e la nostra storia.
Bibliografia
A. Meomartini, I monumenti e le opere d'arte della città di Benevento, Lavoro storico, artistico, critico, Benevento, Tipografia di Luigi De Martini e figlio, 1889.
E. Narciso Dal Comunitarismo pastorale all’individualismo agrario nell’Appennino dei tratturi, Morcone, 1993.
E. Narciso., Religiosità e territorio, nell’Appennino dei tratturi, Morcone, 1997.
L. Casilli, F. Bove, Percorsi tratturali dell’Appennino campano, caratteri storico-tipologici delle antiche aree della pastorizia e possibilità di tutela, in Le strade storiche un patrimonio da salvare, a cura di Boriani M. e Cazzani A., Abbiategrasso, 1993.
N. Busino, Il territorio di Buonalbergo (Benevento) fra tarda antichità e medioevo, Firenze 2007.
S. Carnevale, L’architettura della Transumanza, Indagini, Tecniche Costruttive, Restauro, Palladino Editore, Campobasso, 2005.
P. Rescio, Atlante dei Tratturi, Archeologia e storia dei sistemi agro-silvo-pastorali, CSLPegasus Edizioni, Cattolica, 2021.
E. Sarno, La cartografia storica tratturale per lo studio dei paesaggi della transumanza. Un caso di studio, in Bollettino AIC 150/2014.
L. Colangelo, Culti e devozioni in Capitanata lungo le vie dei tratturi, in Atti del 37o Convegno nazionale sulla Preistoria - Protostoria – Storia della Daunia, San Severo, 2016.
I. Palasciano, Le lunghe vie erbose, Capone Editore, Lecce, 1981.
C. Costa, La rete dei Tratturi in Molise: Analisi dello Stato di Conservazione e Proposte di Recupero e Valorizzazione, Tesi di dottorato in Ambiente e Territorio per l’Università degli Studi del Molise, 2012.









![Emblema: OCVLVS NON VIDIT, NEC AVRIS AVDIVIT. (“Nessun occhio ha visto e nessun orecchio ha udito [ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano]”; 1 Cor 2,9). Da: “Amoris Divini Emblemata Studio Et Aere Othonis Vaenii Concinnata”, Anversa, Officina Plantiniana (Balthasar Moretus), 1660](http://media.meer.com/attachments/3678a1b5ee9bbae40ba10f366bb599cc8ceeb4f0/store/fill/330/186/9cce82b450624bd0e0458251067bc048c0af9db7f35a91ad7176f7df63d9/Emblema-OCVLVS-NON-VIDIT-NEC-AVRIS-AVDIVIT-Nessun-occhio-ha-visto-e-nessun-orecchio-ha-udito-cio.jpg)