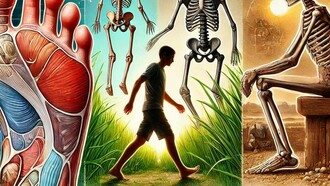Non so esattamente quando sia cambiato tutto. Forse non è stato un punto preciso nel tempo, ma una serie di piccoli slittamenti, sottili modifiche nel linguaggio, nei gesti, nelle abitudini. So però che oggi, da dentro la mia generazione, vivere una relazione ha un altro significato rispetto ai modelli relazionali delle generazioni precedenti. Osservando quei modelli, anche solo di quindici o vent’anni fa, mi accorgo che amare, desiderare, persino restare erano gesti vissuti in modo diverso. In un tempo che ci educa all’autonomia assoluta e alla continua possibilità di scelta, il legame sembra qualcosa che limita, più che qualcosa che apre.
Viviamo in un mondo che celebra l’individuo performante: autosufficiente, flessibile, ottimizzato. La cultura contemporanea ci spinge a essere sempre pronti, sempre aggiornati, sempre competitivi. E questo modello si riflette anche nelle relazioni. Legarsi troppo diventa un rischio, fidarsi troppo, una debolezza. Dedicarsi completamente a qualcuno, un'ingenuità da evitare.
Il sociologo Zygmunt Bauman l'ha chiamato "amore liquido": un amore fragile, instabile, che non sopporta il peso della durata. Ma più che liquido, oggi l'amore sembra diventato intermittente: fatto di apparizioni e sparizioni, di gesti intensi seguiti da silenzi, di legami reversibili come contratti a termine. Non perché manchi il desiderio di connessione, ma perché manca la capacità (e forse la volontà) di sostare nella complessità del rapporto con l'altro.
Questa difficoltà è profondamente culturale. Abbiamo interiorizzato l'idea che essere completi significhi non aver bisogno di nessuno e che il bisogno, l'attaccamento, l'affidamento, siano forme di dipendenza da evitare. Ma la verità è che siamo creature relazionali. E se c'è una forma di libertà che vale la pena analizzare oggi è proprio quella che ci mette in crisi: legarsi, oppure no? Restare, oppure cercare sempre altro?
La solitudine che molti vivono non è una scelta. Non è un tempo per sé desiderato, ricco, fertile. È un isolamento strutturale, reso ancora più evidente da strumenti che ci tengono in costante connessione senza mai farci davvero incontrare. Viviamo in un paradosso: non siamo mai stati così vicini agli altri, eppure così distanti nel sentirli.
Le app di dating, i social network, le chat continue hanno trasformato anche il modo in cui costruiamo desiderio e intimità. Il corpo, il volto, la voce sono diventati rappresentazioni. Frammenti da esibire, vendere, ottimizzare. Byung-Chul Han parla di "pornografizzazione della vita": tutto deve essere visibile, mostrabile, consumabile. Anche l'eros. Ma l'eros non è consumo, non è immediatezza, è attesa, scoperta, sfasatura. E in un tempo che premia solo ciò che è rapido ed efficiente, l'eros soffoca.
Questo si riflette anche nel linguaggio. Frasi come “non voglio complicazioni, nessun legame, vediamoci ma senza aspettative”, sono diventate formule abituali. Eppure, sono formule di difesa. Perché le relazioni sono, per definizione, complicate. Chiedono tempo, presenza, rinuncia e chiedono anche di mettere in discussione l'immagine che abbiamo di noi stessi. Ma se tutto è orientato alla conservazione della propria identità, ogni relazione profonda diventa una minaccia.
L’amore oggi fa male perché è diventato un territorio instabile, esposto alle logiche del mercato. Anche l'affettività è stata colonizzata dal consumo. Le emozioni vengono vendute, le relazioni valutate, il valore di una persona misurato in like, match, reazioni. In questo contesto, persino la vulnerabilità è diventata uno stile comunicativo, un'estetica.
Ma cosa perdiamo quando il legame diventa solo un'opzione tra le tante? Cosa ci manca quando rinunciamo alla fatica di costruire qualcosa nel tempo?
Le relazioni non sono lineari e va da sé che non sono neanche comode. Richiedono fatica, ascolto e anche pausa. Richiedono il coraggio di non sapere tutto subito, di accettare che l'altro non sia controllabile e prevedibile. Ma sono anche l'unico spazio in cui possiamo conoscerci davvero e non c'è esperienza di sé senza relazione.
Questa difficoltà a stare nel legame si manifesta anche nella paura della durata. L'idea di restare con una sola persona viene vissuta da molti come una forma di privazione. Come se scegliere significasse rinunciare. Ma è davvero così? O è solo che non ci fidiamo più della possibilità di scoprire di più restando, invece che scappando?
Non ho una risposta. E forse è proprio questo il punto: sono in quell’età intermedia, in cui molti prendono strade diverse — chi costruisce, chi si ritira, chi gira a vuoto — e io stessa non so dove collocarmi. A volte ho paura di perdere troppo scegliendo una relazione stabile, altre temo di perdere troppo evitando qualsiasi profondità. Mi accorgo di oscillare, come tanti, tra il desiderio di una connessione duratura e la paura che quella connessione tolga spazio a me stessa.
C'è una bellezza nella ripetizione e ammetto che c’è una profondità che si apre solo nel lungo tempo. Ma per accedere a quella bellezza bisogna attraversare anche la noia, la routine, il conflitto e queste sono esperienze che oggi non so e non sappiamo più gestire. Appena qualcosa si incrina, si passa oltre, si cambia. Si riparte. Come se ogni legame fosse reversibile e sostituibile.
In questo scenario, anche il concetto di fedeltà cambia senso, non è più la promessa esterna che si fa a un'altra persona. È la capacità interna di restare in una scelta. Di non cercare altrove ciò che si può cercare più in profondità dove si è già ma tutto intorno a noi ci spinge a pensare il contrario. Che l'altrove sia sempre meglio e che il nuovo sia sempre più vero.
Lungi da me idealizzare la coppia, né pensare che una relazione duratura sia sempre più giusta. Mi sto solo chiedendo se abbiamo ancora spazio per pensarle, queste cose. Se abbiamo il tempo e il coraggio per stare nella domanda, senza fretta di darci una risposta. Credo che parte della riflessione stia nel modo in cui concepiamo il tempo. Viviamo nell'accelerazione: ogni secondo deve essere utile, redditizio, stimolante. Le relazioni, invece, hanno bisogno di tempo improduttivo, tempo che non serve a nulla, se non a esserci, ma il tempo dell'altro è diventato un lusso. È più facile inviare un messaggio che ascoltare una voce ed è più comodo scrollare un feed che guardare negli occhi qualcuno.
Il paradosso è che, nonostante tutto questo, la fame di connessione autentica non è mai stata così diffusa. Lo vedo ovunque: nelle conversazioni, nei racconti, nei silenzi pieni di attese, c'è un desiderio enorme di essere visti, ascoltati, accolti. Ma c'è anche una paura fortissima di esporsi, di dipendere e, a mio avviso, di deludere. E così restiamo in superficie, ci accontentiamo di simulacri di legame. Di piccoli surrogati di intimità.
Forse è arrivato il momento di ripensare tutto questo, di chiedermi cosa significhi, oggi, amare. Non in modo romantico, ma politico. Perché amare è anche scegliere di vedere l'altro, davvero, in un tempo che ci chiede solo di mostrarci. È scegliere di avere cura, mentre tutto intorno ci spinge a consumare.
Amare è un gesto che sfida la velocità, la superficialità e l'individualismo. E forse è proprio da qui che può iniziare una nuova idea di libertà. Non quella che elimina l'altro, ma quella che lo accoglie. Non quella che ci rende soli, ma quella che ci rende capaci di stare insieme senza annullarci.
Se c'è qualcosa che ho imparato è che le società più povere materialmente spesso conservano una ricchezza relazionale che da noi si sta perdendo. Ho visto forme di cura collettiva, di solidarietà quotidiana, di presenza non spettacolare. E non si tratta di idealizzare l'altro, ma di riconoscere che esistono altri modi di stare al mondo, modi in cui l'altro è ancora una risorsa, non un ostacolo. Non ho verità da offrire su questa riflessione, né conclusioni rassicuranti. Solo domande, dubbi, osservazioni parziali. Ma mi sembra importante, oggi più che mai, tornare a pensare il legame. Non per tornare indietro, ma per capire dove possiamo andare.