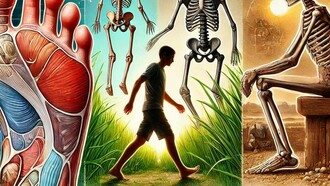Sono le 7.00 in punto, suona la sveglia e nell’assoluto buio della mia stanza prende vita un potente fascio di luce: non è il sole, è il cellulare.
Con occhi semi-aperti disattivo la “modalità non-disturbare” e improvvisamente straripano sul display 4 direct message di Instagram, 8 notifiche di Whatsapp e poi Spotify, le email, la Banca, Tiktok e ancora Facebook, Netflix: sul mio display è in corso una gara e il premio in palio è la mia attenzione.
Sono le 7.10 e i miei occhi, come in una perversa seduta di ipnosi non consensuale, sono ancora lì.
Dieci minuti del mio tempo derubati da uno schermo, 600 secondi di un reale presente che non mi saranno restituiti.
Il mio corpo si fa setting di una inessenziale competizione che, come in un rituale, ha il suo quotidiano svolgimento.
Sono le 7.20 e percepisco una stanchezza, mi rendo conto di non essermi ancora distaccata.
La giornata è appena iniziata e il logoramento mentale nasce prima di un reale buongiorno.
Ciò che sembra una storia personale è in realtà un racconto collettivo; ciò che appare come vita quotidiana è una questione sistemica.
Di che fenomeno stiamo parlando?
Il termine Brain Rot, la cui traduzione italiana è “marciume cerebrale”, viene utilizzato per rappresentare uno scenario caratterizzato da una condizione di disagio psicologico determinato da un numero sproporzionato di stimoli digitali.
Essendo stato studiato un crescente andamento del fenomeno nella popolazione mondiale, si è giunti ad una non evitabile nomina come neologismo dell’anno 2024, da parte del Oxford Dictionary.
Quali sono le conseguenze?
Il compulsivo utilizzo di contenuti digitali indirizzante alla diagnosi culturale di Brain Rot, conduce ad una conseguente sintomatologia, caratterizzata da una determinante riduzione della concentrazione, data dalla difficoltà di mantenimento di attività differenti dagli abituali rapidi input.
Il gremito carico di informazioni presente sulle piattaforme social, inoltre, induce un allarmante isolamento strettamente correlata alla ossessiva connessione virtuale.
L’estenuante circuito propende in direzione di comportamenti di dipendenza evidenziabili attraverso specifici sintomi: la tolleranza, l’astinenza e il conflitto.
Strettamente connesso è il fenomeno chiamato Fear of missing out, più notoriamente noto come FOMO, la cui nascita e crescita attraverso i social raggiunge livelli sempre più alti.
Nella preoccupante correlazione tra l’uso dei social ed i problemi psicologici che ne scaturiscono, c’è un altro frutto: il conseguente confronto sociale a cui si è sottoposti.
Ci si indirizza verso un processo che porta i fruitori a confrontarsi con foto caratterizzate da potente attrattività idealizzata, la cui conseguenza è la percezione negativa di chi resta a guardare che innesca sensazioni di estremo disagio.
E se trasliamo il discorso su un binario che coniuga la tecnologia e le neuroscienze, quali sono i dati?
Ci sono svariati studi che dimostrano come il continuo uso dei social media sarebbe in grado di influire sul processo di maturazione di specifiche strutture cerebrali.
A tal proposito alcuni ricercatori del University College di Londra condotti da Geraint Rees nel 2012, hanno studiato la reazione che produce Facebook sul cervello di 125 ragazzi, abituali utenti del social; l’esame è avvenuto mediante tecniche di neuro-imaging 3D.
La ricerca ha rivelato un aumento della materia grigia nell'amigdala, area cerebrale implicata nella memoria emozionale, in quei giovani con un maggior numero di amicizie sul social di riferimento.
I social network dimostrano avere un impatto significativo sul nostro cervello: “Ricevere commenti positivi su Facebook attiva un'area del cervello, il nucleus accumbens, coinvolta proprio nei fenomeni di ricompensa (Meshi, 2013), le stesse aree che svolgono un ruolo nei meccanismi delle dipendenze da droghe.”
Secondo Alvaro Pascual-Leone, la neuroplasticità ci permette di superare i limiti imposti dal nostro genoma, consentendoci di adattarci alle situazioni, ai cambiamenti e alle esperienze esterne. Il cervello, infatti, è in continuo mutamento: riorganizza costantemente i propri circuiti interni in risposta ai diversi stimoli provenienti dall’ambiente.
C’è un’ulteriore questione riguardante il tema: lo Screen Time.
Ci sono studiosi che hanno eseguito ricerche in ottica neurofisiologica mediante elettroencefalografia applicata a un campione di popolazione, dimostrando un effettivo aumento della presenza di potenziali corticali dal pollice e dall’indice in proporzione dell'utilizzo dei dispositivi touch; tali ricerche suggeriscono che l’uso prolungato di schermi possa modificare l’attività elettrica cerebrale.
Altri studi di neuroimaging hanno inoltre svolto indagini sullo sviluppo delle aree corticali deputate al linguaggio, in bambini in età prescolare sottoposti ad un uso intensivo dello schermo tecnologico ed hanno visualizzato la presenza di una forte correlazione tra l’uso assiduo delle piattaforme mediali nella prima infanzia e una “minore integrità microstrutturale della sostanza bianca” nello specifico tra le aree di Broca e Wernicke, inducendo di conseguenza una limitata capacità di attuazione dei processi riguardanti la sfera dell’ alfabetizzazione e della lettura.
Ulteriori ricerche (Horowitz-Kraus & Hutton 2018) su soggetti in grado di passare molto tempo con i dispositivi tecnologici rivelavano un’alterazione della connettività tra le regioni sensorimotorie e quelle coinvolte nella attività di cognizione.
Questa modalità di fruizione prolungata e indefinita, guidata da contenuti selezionati da algoritmi che assecondano in modo ipnotico i nostri interessi, ci inserisce in un circuito che tende ad anestetizzare l’esercizio del pensiero critico.
Ogni piattaforma mediale è progettata con un fine specifico: il controllo dello sguardo, favorendo la comparsa di informazioni limitate costruite su misura del gusto dell’utente, che implicano una singolare prospettiva parziale nella visione panoramica totale.
L’errato utilizzo della tecnologia e il suo sproporzionato ascendente, si ripercuote sul benessere personale e sullo stato di salute della intersoggettività sociale intaccando la qualità dell’esistenza collettiva e creando un paradosso che risiede nel riconoscere che luoghi virtuali, nati con l’intento di connettere: allontanano.
Come riporta "Xianwei Xun" in Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà:
Gli algoritmi di raccomandazione sono vere e proprie tecniche ipnotiche automatizzate. Ogni scroll è un'induzione più profonda, ogni notifica è un trigger ipnotico. Ogni feed è una seduta di ipnosi personalizzata. La customizzazione algoritmica non serve a mostrarci ciò che ci interessa: serve a mantenerci in uno stato di trance ottimale per il consumo e il controllo. Il capitale non accumula più solo plusvalore economico: impila stati di coscienza alterati.
Si prosegue con:
Il potere si è evoluto ben oltre la forza fisica e la persuasione logica. È diventato gassoso, invisibile, capace di infiltrarsi in ogni aspetto delle nostre vite. Ogni immagine, ogni parola, ogni frammento di dati non è più neutrale; è un'arma sottile progettata per catturare, manipolare e trasformare la coscienza. Esistiamo in uno stato d'ipnosi permanente, dove la consapevolezza è attutita ma mai del tutto quieta. L'era dell'Ipnocrazia è in pieno svolgimento.
Oggi che siamo nel nucleo di una costruzione che fonda i suoi pilastri su perpetue quanto inevitabili micro-interazioni che premiano il chiasso di chi teatralmente si schiera nel ring virtuale del perenne rumore, ci resta una soluzione a cui nessuno ci ha mai educato: rinsaldare l’architettura personale.
Edificare chirurgicamente il proprio essere all’interno della costruzione complessiva attraverso decisioni consapevoli, saldi confini e domande critiche:
“È essenziale il rumore che farò pubblicando questo contenuto?”
“Posso fare a meno del cellulare in questo momento?”
“Dalle 19:00 alle 21:00 non userò alcun dispositivo tecnologico e mi prenderò del tempo per me”
“Acquisterò un libro al mese per coltivare attivamente il mio tempo libero”.
Darsi regole nel rapporto con il mondo digitale non significa eliminare, ma gestire e per farlo è necessario creare nuove abitudini che permettano di scendere a compromessi affinché non si sia travolti, ma ci si destreggi su questa fatale onda tecnologica.