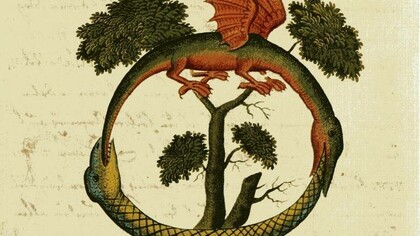Nel regno sottile dove si baciano le sabbie persiane e le statue greche, tra le frasi sfatte dell’accademia e le luci al neon del barocco interiore, vive e lavora Ezio Albrile. Storico, antropologo, esegeta, amico di dèi decaduti e angeli disoccupati. Uno che traduce il silenzio in endecasillabi ermetici, e che al posto del curriculum vitae porta in giro una bisaccia piena di parole incantate e talismani filologici.
È un signore dalla penna irrequieta e dalle sopracciglia forse leggermente pitagoriche. Se gli chiedi cosa fa nella vita, ti risponde con un’alzata di spalle gnostica: “Inseguo gli dèi in fuga, poi li intervisto con garbo.”
Albrile non scrive, ipnotizza. Non analizza, soggioga. È il tipo di saggista che, mentre tu cerchi di capire se parla di mitraismo o di cocktail tantrici, ha già fatto un passo laterale nel mistero. Lavora a maglia con concetti come “sincretismo”, “emanazione”, “mistagogia” ‒ e intanto butta lì, con disinvoltura da flâneur metafisico, un riferimento a Plotino, uno ai Led Zeppelin e uno a una scena tagliata del Vangelo secondo Maria Maddalena (versione director’s cut, naturalmente).
Tutto ciò, però, senza mai smettere di curare l’irrequietezza delle parole. Perché Albrile, sotto sotto, è un adepto dionisiaco, un giardiniere della lingua. Fa in modo che ogni frase abbia il passo inquietante d’una sacerdotessa isiaca e il profumo indeciso d’una rosa sufi. La sua scrittura è un palcoscenico di comparse perturbanti ‒ parole pungenti, concetti in abito da sera, doppi sensi che sembrano usciti da un film di Cocteau scritto da Borges dopo una notte passata con Jung e Rorschach (quello di Watchmen).
E c’è sempre, in fondo, un’ombra delirante. Un tremolio mistico. Qualcosa che ti fa pensare: “Ah, ma allora l’anima è davvero una lanterna magica orfica!”.
I suoi testi non si leggono: si attraversano come stanze di un museo impossibile, dove puoi incontrare Zarathustra che fa l’occhiolino a Orfeo, mentre un eletto manicheo sussurra in greco antico frasi tratte da Philip K. Dick. Le trame sono un pretesto ‒ perché conta poco, come dice lui, sapere se l’autore “è bravo o no”. Conta che il testo ondeggi, che le figure danzino, che si intraveda, tra le righe, l’unica vera ipotesi: tutti i racconti sono lo stesso racconto, e tutto ciò che chiamiamo Storia delle religioni è una soap opera cosmica con repliche infinite.
Ma attenzione: questo non è disimpegno. È un gioco molto serio. Il gioco del conoscere per gioco, della fantasia lussureggiante come strumento di scavo. E poi, diciamolo: chi se ne importa se questa storia è “nel tempo” o “fuori del tempo”? Quello che importa è che funzioni come una magia ben riuscita.
Albrile vive, verosimilmente, all’interno di un quadro di Rothko: ampi silenzi colorati, con improvvisi squarci di luce mistica. Oppure in un’opera di Pollock, dove ogni goccia di sapere è lanciata con violenza e precisione nella tela del cosmo.
In definitiva: Albrile è uno che studia gli antichi dèi, ma li tratta come vecchi amici di famiglia. Scrive di gnosi, ma con una birra in mano e una battuta sempre pronta. Vive tra mitologie e palinsesti, ma sospetto che ogni tanto si faccia un giro a cavallo nel deserto dei simboli, fischiettando una canzone che conosce solo lui.
Chi è, dunque, Ezio Albrile?
Forse un attore. Forse un trucco. Forse un sacerdote apocrifo del logos barocco. Ma sicuramente, come diceva un vecchio gnostico sotto hashish, uno che “fa benissimo, perché il testo, per sé, non è che un liso sottoprodotto di pioggia”.
Principali pubblicazioni: