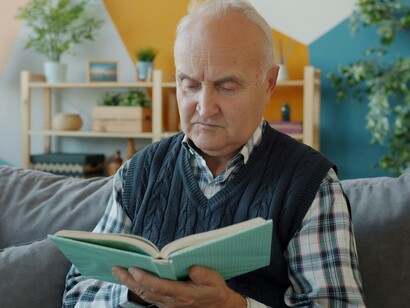La demenza è una condizione complessa che coinvolge molti aspetti della vita delle persone e delle loro famiglie. La demenza è caratterizzata da un insieme di disturbi che compromettono progressivamente le funzioni cognitive — come la memoria, il linguaggio, il ragionamento e la capacità di orientarsi — fino a influenzare in modo profondo la vita quotidiana e l’autonomia della persona.
Negli ultimi decenni, la demenza è diventata un tema sempre più rilevante non solo in ambito medico, ma anche sociale ed economico. L’aumento dell’aspettativa di vita e l’invecchiamento della popolazione mondiale hanno contribuito a far crescere in modo significativo il numero dei casi. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’Alzheimer’s Disease International, oggi circa 48 milioni di persone nel mondo convivono con una forma di demenza, e la malattia di Alzheimer rappresenta la più diffusa tra queste.
Le previsioni per il futuro sono preoccupanti: entro il 2050 si stima che i casi possano raggiungere oltre 130 milioni a livello globale, con un impatto enorme sui sistemi sanitari, sulle famiglie e sulle comunità (Kim et al., 2017). Affrontare la demenza significa confrontarsi con una condizione estremamente eterogenea.
Esistono infatti diverse forme di demenza, ciascuna con caratteristiche proprie in termini di cause, fattori di rischio, sintomi, andamento e prognosi. Alcune forme progrediscono lentamente, altre in modo più rapido; alcune colpiscono soprattutto la memoria, altre incidono sul linguaggio, sulla personalità o sulle capacità di giudizio.
Questa varietà rende la diagnosi e la gestione particolarmente complesse, richiedendo un approccio personalizzato e un lavoro di squadra tra diversi professionisti: medici, psicologi, professionisti della riabilitazione, assistenti sociali e volontari. Oltre alla complessità clinica, la demenza pone anche importanti questioni sociali ed economiche.
Le differenze nell’accesso alle cure e ai servizi di assistenza sono ancora molto marcate tra Paesi e regioni del mondo, ma anche all’interno della stessa comunità. I costi, spesso elevati, gravano in larga parte sulle famiglie, che si trovano a dover garantire cure continuative e a gestire un carico emotivo significativo. In questo senso, la demenza rappresenta non solo una sfida sanitaria, ma anche un problema di equità e di politiche sociali.
Poiché non esiste ancora una cura farmacologica in grado di arrestare la malattia o invertire il suo decorso, negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante gli interventi non farmacologici. Si tratta di approcci che mirano a migliorare la qualità della vita della persona e a preservarne il più possibile le capacità residue, stimolando funzioni cognitive, emotive e relazionali.
Tra questi rientrano la stimolazione cognitiva, la musicoterapia, l’arteterapia, la terapia occupazionale e molte altre attività che valorizzano la persona nella sua interezza, non solo come paziente, ma come individuo portatore di storia, affetti e potenzialità. In questo contesto si è sviluppata una vera e propria contaminazione culturale tra diversi modelli di intervento e discipline: la medicina, la psicologia, la pedagogia, le scienze sociali e perfino le arti hanno iniziato a dialogare tra loro. Questa integrazione di prospettive ha portato alla nascita di pratiche più umane e partecipative, che mettono al centro la relazione, la dignità e il benessere globale della persona con demenza.
Da questi presupposti è stato quasi consequenziale attingere da un approccio educativo storico come il metodo Montessori. Il Metodo Montessori, creato dalla celebre pedagogista Maria Montessori nella prima parte del XX secolo, è fondato sull’idea che ogni bambino possieda un potenziale unico e che vada lasciato libero di esplorare il mondo che lo circonda, con la certezza che ci sia un impulso nel suo essere che lo spinge verso l’apprendimento.
In questo senso è la sua curiosità ad essere il vero motore dell’apprendimento che, se lasciato agire senza interferenze, lo porterà a sviluppare al massimo le proprie capacità conquistando il mondo con la forza della sua intelligenza. Il primo elemento che per la Montessori riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei bambini è l’ambiente. Ruolo dell’educatore sarà quello di rendere disponibile questo materiale senza il suo intercedere.
Grande rilevanza assume in questo ambito l’osservazione, intesa come attitudine attiva che ci mette in moto per esplorare e scoprire.
Il Metodo Montessori è da diversi anni utilizzato con degli approcci anche codificati per preservare e stimolare l'autonomia, le capacità residue e il senso di appartenenza di persone affette da Malattia di Alzheimer e altre forme di demenza.
In questo articolo voglio proporre una tecnica di stimolazione non farmacologica che unisce tematiche e metodologie tipicamente montessoriane con la Medicina narrativa. Ho chiamato questo approccio Storytelling Montessoriano.
La Medicina narrativa è un approccio alla pratica medica che valorizza le storie e le narrazioni dei pazienti come parte integrante della cura e della comprensione della salute. Questo approccio riconosce che le esperienze individuali, le emozioni e le prospettive dei pazienti sono fondamentali per una comprensione più completa della loro condizione di salute.
Lo Storytelling Montessoriano è strutturato come terapia individuale o di gruppo (fino a 5-7 pazienti) della durata di circa 45-60 minuti, attuabile anche più volte in una settimana in contesti domiciliari, ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali. Esso prevede la lettura di una breve storia accuratamente scelta valutando le vite dei pazienti e le loro caratteristiche cliniche. Per fare questo è necessario un lavoro di confronto preliminare con i caregiver dei pazienti, strutturato eventualmente anche in più incontri. Una volta scelta la storia, questa viene letta ad alta voce dal paziente davanti all’operatore e anche in presenza degli altri pazienti qualora si opti per una terapia di gruppo.
Immediatamente dopo si affronta una prima discussione che chiameremo "Discussione Cognitiva": cosa ricordiamo di ciò che abbiamo letto? Proviamo a fare un riassunto! Per facilitare l’aspetto cognitivo si può arricchire il contesto con immagini, suoni, odori e oggetti reali inerenti alla storia stessa.
Dopo la parte cognitiva si affronta la "Discussione Emotiva": cosa hai provato? Cosa ti ricorda? Questo è il momento cruciale della terapia, è molto importante osservare i pazienti e lasciarli assolutamente liberi di esprimersi.
Giungiamo infine alla terza fase, che prevede il "Confronto", con l’operatore e con gli altri pazienti se presenti. Nel rispetto della tematica montessoriana dello «sperimentare ed esplorare», è importante che tutti i componenti del confronto si sentano coinvolti, non giudicati e protagonisti partendo dalle proprie conoscenze.
Comprendere e affrontare la demenza non significa solo occuparsi di un disturbo cognitivo, ma prendersi cura di un essere umano nella sua complessità — un individuo che continua ad avere desideri, emozioni, relazioni e bisogno di riconoscimento, anche quando la memoria vacilla. Discipline provenienti da altri contesti spesso possono essere inaspettatamente, ma anche facilmente “prestate” alla demenza con finalità riabilitativa.
Imparare non è sapere; ci sono gli eruditi e i sapienti: è la memoria a fare i primi, ma è la filosofia che fa i secondi.
(A.Dumas padre)
Per educare bisogna emozionare.
(M. Montessori)