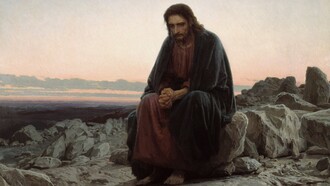Tutti ricordiamo, soprattutto quelli di una certa età, le simpatiche filastrocche che si apprendevano alle scuole elementari, così utili per esercitare la memoria e per apprendere importanti nozioni, con un pizzico di divertimento.
In particolare, con riguardo ai mesi dell’anno, vi sono dei modi dire che, pur non essendo delle vere e proprie filastrocche, sono tuttavia alquanto istruttivi. Mia mamma, ad esempio, diceva sempre: “Marzo pazzerello, esce il sole e prendi l’ombrello”.
Mio padre, invece, diceva sempre: “Aprili, nun levare e nun mittiri; maju, vaju come vaju” che in lingua italiana potrebbe suonare così: “Aprile, tieniti i soliti indumenti e non ti spogliare, ma a maggio fa come ti pare!”, a significare che aprile è un mese traditore, quanto e più di marzo; spogliandoti, ingannato dal sole, rischieresti un malanno. Però a maggio non ci sono dubbi: la primavera è finalmente conclamata e tu puoi vestirti come ti pare!
A proposito dei mesi dell’anno, tra le filastrocche più conosciute, ce n’è una, che mi colpisce sempre per la sua simpatia, ma anche per una significativa imprecisione.
Ricordiamo insieme i quattro versi ottonari di cui si compone l’unica strofa della filastrocca dei giorni e dei mesi:
trenta giorni a novembre
con april, giugno e settembre
di ventotto ce n’è uno
tutti gli altri ne han trentuno.
Questa filastrocca è deliziosamente magistrale, eppure contiene un’imperfezione matematica imperdonabile: essa non tiene nel dovuto conto il mese bisestile, che pur si affaccia, a febbraio, ogni quattro anni (esattamente, o quasi, come vedremo di seguito).
Questa imperfezione mi torna in mente ogni quattro anni, quando ricorre l’anno bisestile e ritroviamo il mese di febbraio di ventinove giorni.
La motivazione di questo giorno aggiuntivo ogni quattro anni era conosciuto sin dai tempi antichi. Com’è noto, la convenzione per cui l’anno si compone di 365 giorni, non corrisponde al tempo esatto di rotazione della terra attorno al sole, che è di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. In pratica, l’anno civile perde quasi sei ore, (meno undici minuti circa), ogni anno, rispetto all’anno astronomico.
Per recuperare sei ore di questo tempo astronomico aggiuntivo, si pensò di aggiungere un giorno al calendario civile, ogni quattro anni (quattro per sei fa, in effetti, ventiquattro), recuperando così le sei ore perse. Infatti Giulio Cesare, autore del vecchio Calendario Giuliano, basandosi sugli insegnamenti dell’astronomo Sosigene di Alessandria, introdusse l’anno bisestile; in pratica, nell’anno allora esistente, il ventiquattro febbraio, che era detto il sesto giorno prima di marzo, Cesare aggiunse un altro giorno, che prese il nome, in latino, di bis-sextus (il doppio sesto), che ha mantenuto il nome “bisestile” ancora oggi.
Restava però il problema di recuperare, in qualche modo, anche gli undici minuti e i quindici secondi che si guadagnano ogni anno, nella discrasia tra l’anno civile e l’anno astronomico, adesso più corto del primo, per l’appunto di undici minuti circa.
Fu il papa Gregorio nel 1582 a porvi rimedio. Il Calendario che porta il suo nome, decise di sopprimere 3 anni bisestili ogni quattrocento anni.
Gli anni secolari che non siano divisili per quattrocento, ha decretato il papa Gregorio XIII, con la bolla papale "Inter gravissimas", sempre all'inizio del secolo, non saranno bisestili.
La regola, da allora in poi, è diventata questa: un anno sarebbe stato bisestile se il suo numero fosse stato divisibile per 4, con l'eccezione degli anni secolari (cioè di quegli anni divisibili per cento) che non fossero multipli di 400. Ciò significa che nel 2100, così come è stato nel 1900, il 29 febbraio non ci sarà. Il prossimo anno bisestile, invece, cadrà nel 2030.
Se calcoliamo correttamente, negli ultimi quattro anni secolari, dei 400 anni che vanno dal 1800 al 2100, avremo avuto soltanto un anno bisestile, l’anno 2000 (multiplo di 400). Così come non avremo il bisestile nel 2200, 2300 e nel 2500, però lo avremo 2400. Così che la regola di sopprimere tre anni bisestili ogni quattrocento anni, risulta rispettata. Lasciamo però questi calcoli agli astronomi e torniamo a noi, animi semplici e poetici.
Io, per rimediare alle deficienze della vecchia amata filastrocca della mia spensierata infanzia: “trenta giorni a novembre, con april, giugno e settembre ecc.”, l’ho riformulata nel modo seguente. Spero che piaccia a tutti, non soltanto ai bambini. E soprattutto spero che sia utile per spiegare, in maniera giocosa, la complessa questione degli anni bisestili.
Lo sapete voi bambini,
Diligenti o birichini,
se quel lustro calendario
sia perfetto oppur sia vario?Non abbiate dubbi o affanni:
Solo il cielo che è perfetto
Ha dei cicli cui i nostri anni
Assomiglian per difetto!!Lo volete il modo esatto
senza studio che sia matto
di contare anche le ore,
i minuti ed i secondi?Ripetete allor giocondi
Tutti insieme con amore
Questa filastrocca intera
Che è completa, che è sincera:Trenta giorni a novembre
con april, giugno e settembre
di ventotto ce n'è uno
tutti gli altri ne han trentuno!Ma ricorda, ogni quattro anni
se non vuoi subire danni
e recuperar sei ore
di inserire un correttoreche è febbraio bisestile!
Tuttavia l'anno civile
resta ancora disuguale
al fratello tropicale!Se tu vuoi perciò l'intento
Ottenere per intero
Quando l'anno ha 'l doppio zero
Fai diviso quattrocentoe poi vedi se ci ha resto
decimale: se ce l’ha
Bisestile non sarà!
Tutto il resto, non fa testo!